Questo articolo è il post originale che ha costituito la base dell’inchiesta poi confluita nel libro “Bronzi di Riace, illustri (tuttora) sconosciuti”, pubblicato esattamente 4 anni dopo, l’1 Gennaio 2023.
È un articolo lunghissimo e approfondito, anche piuttosto divertente, ma parziale: è abbondantemente superato — soprattutto nelle conclusioni cui sono giunto (l’autore dei Bronzi non è Pitagora Reggino e i personaggi non sono Eteocle e Polinice) —, ma lo lascio ugualmente online come semplice, genuina testimonianza.
Contiene peraltro materiali testuali e fotografici che non sono stati inseriti nel libro, poiché non determinanti, in particolar modo l’esame di una delle più recenti ipotesi circolate in merito all’identità dei Bronzi, quella bizzarra e del tutto inattendibile (eppure pompata a spron battuto sui media locali calabresi e sui social) di “Pericle e Temistocle”.
Chi volesse ugualmente inoltrarsi nella lettura è dunque avvertitə.

Blogpost originale dell’1/1/2019
Un longform su Riace che non si riferisce al “sindaco dell’accoglienza” Mimmo Lucano, di questi tempi? Sì, si può.
Premessa.
Non sono un esperto di “antichità”, né un archeologo, né un iconografo, né nient’altro che mi possa far definire uno “studioso” o uno “scienziato”. Il mio metro è la logica deduttiva. Quanto scrivo qui è il frutto delle letture delle pubblicazioni di chi “studioso” o “scienziato” è veramente: dopo attenta analisi, le mie conclusioni sono appunto il frutto della pura deduzione.
A volte è sufficiente unire i dettagli con la freddezza tipica di chi non è addentro alle segrete cose accademiche, per mettere a fuoco un quadro d’insieme cui gli accademici di professione non sono in grado di giungere per svariati motivi, non ultimo il “non pestarsi i piedi” fra loro.
Le prime, affollate ipotesi sulle origini dei BRONZI DI RIACE seguirono il ritrovamento e la successiva esposizione a Firenze e al Quirinale, negli Anni ’70/’80; ci fu poi una seconda fase di teorie, il cui volàno furono le prime approfondite analisi dei materiali, negli Anni ’90; e infine una terza e ultima ondata, stimolata dal nuovo restauro e dalla rinnovata esposizione al Museo di Reggio Calabria. Detto questo, dopo esaustive letture e procedendo per esclusione su quanto è stato messo in campo da studiosi di mezzo mondo, a me sembra di poter affermare con ragionevole certezza che finalmente, a quasi mezzo secolo da quel fatidico 16 Agosto 1972, siamo davanti a narrazioni che ci possono consentire una accettabile “linea globale di lettura”. A mio modo di vedere (si parva licet), fra tutte le tesi proposte dagli studiosi affermati — i cosiddetti “luminari del settore” —, la storia dei Bronzi può essere ricostruita “unendo” quelle del prof. Daniele Castrizio e del compianto prof. Giuseppe Roma. A condizione che si epurino, rispettivamente, del “naufragio” (Castrizio) e di tutta la parte artistico-iconografica (Roma), le due ricostruzioni sono perfettamente sovrapponibili, e l’una diventa la prosecuzione dell’altra. Per le origini (realizzazione, iconografia e primi secoli di vita), dopo decenni di teorie contrastanti, il dottor Castrizio offre la visione più congrua, argomentata e innovativa, sia pure con qualche pecca (su tutte: stili e realizzatori diversi); per il motivo del loro ritrovamento a Riace e per la storia dei Bronzi nei secoli che vanno dall’Alto Medioevo al 1972, è il dottor Roma a offrire le argomentazioni più persuasive e accattivanti.
L’unico buco storico riguarda il momento del loro arrivo in Calabria: epurando del naufragio la ricostruzione degli eventi, infatti, non abbiamo più copertura e giustificazione della loro presenza nella Locride. D’altro canto, però, il naufragio ha la colpa di abbandonare in mare i Bronzi “troppo presto”, lasciando inspiegate alcune cose riguardo ai miti riacesi sviluppatisi nei secoli e vivi ancor oggi, e riguardo alla “stranezza” del ritrovamento.
La sovrapposizione non è indolore, ed è piena di se, ma e forse. Peraltro, la tesi del prof. Castrizio non ha mai presunto di voler spiegare certi miti riacesi (la forzatura è interamente mia). Il mio obiettivo però non è Sua Maestà la Verità bensì di giungere a un sufficiente grado di verosimiglianza: male che vada, è una buona “provocazione storica” da leggere in un quarto d’ora di totale relax.
ORIGINE ICONOGRAFICA DEI BRONZI
Archeologo, numismatico, storico e iconografo di fama, il prof. Eligio Daniele Castrizio è uno dei più eminenti studiosi “magnogreci” contemporanei; esperto di monetazione antica e docente universitario, è anche autore di numerose pubblicazioni e saggi storici.
Secondo Castrizio, la corretta identificazione dei personaggi raffigurati nei due Bronzi di Riace ha origine e fondamento dalla lettura e dall’interpretazione di tutti i segni presenti sulle statue, dall’eliminazione di tutti gli elementi proposti che non abbiano prove materiali a sostegno, e — soprattutto — dalle ricerche nelle fonti antiche degli attributi iconografici proposti.
Procedendo così, a parere di Castrizio l’unico confronto realmente attendibile per le due statue da Riace si ritrova in una scena con cinque personaggi, raffigurata su reperti archeologici di varia natura, che rimanda a una versione del mito del duello finale fratricida tra Eteocle e Polinice, e che secondo il professore dobbiamo al grande poeta Stesicoro (630–550 a.C.). I filologi alessandrini raccolsero le sue vaste composizioni ma di questa produzione restano solo titoli e scarsi frammenti; tuttavia alcuni papiri ritrovati nel Novecento hanno proiettato una luce nuova sulle opere di Stesicoro: in particolare il “Papiro di Lille”, pubblicato nel 1977, conterrebbe parti di una “Tebaide”, di cui il frammento meglio conservato riguarda il discorso della regina Giocasta/Euriganeia ai figli Eteocle e Polinice, in cui la donna tenta di dividere i due figli scongiurando che si uccidano a vicenda — cosa che però avverrà ugualmente più tardi.
I Bronzi di Riace raffigurerebbero proprio questi due personaggi: Eteocle è il “Bronzo B”, Polinice il “Bronzo A”.
Ciò spiega la cuffia (kynê) scolpita sulla testa della “Statua B”: era un copricapo in cuoio indossato sotto l’elmo che, con il suo paranuca a ricciolo posto nella parte posteriore della testa, permetteva ai soldati (ippikon, opliti e toxtai) schierati alle spalle del comandante di avere un segno riconoscibile del ruolo, che però fosse al contempo impercettibile per i nemici. Kynê indossata da Eteocle poiché sovrano di Tebe al momento del duello fatale.


L’origine magnogreca della storia, secondo Castrizio, è dimostrata, oltre che dalla cronologia di stesura (Stesicoro visse oltre un secolo prima di Eschilo, Sofocle ed Euripide, a loro volta autori di tebaidi), dalle differenze significative rispetto alle altre versioni fornite dalla tragedia greca: nei “Sette contro Tebe”, opera di Eschilo rappresentata ad Atene la prima volta nel 467 a.C., i due fratelli Eteocle e Polinice si uccidono tra loro senza che la madre intervenga nel disperato tentativo di dividerli; nel capolavoro “Edipo re” di Sofocle, tragedia rappresentata tra il 430 e il 420 a.C., Giocasta si era già suicidata quando aveva compreso di aver sposato il figlio, anni prima del duello fratricida.
La scena (riconoscibile in particolare su un sarcofago del II Sec. d.C. conservato a Villa Doria Pamphilj a Roma) mostra tutti i personaggi presenti: i due guerrieri si fronteggiano, mentre la vecchia madre, che ha scoperto i seni per ricordare a entrambi di essere fratelli e di avere succhiato il medesimo latte materno, tenta di frapporsi; alle spalle di Polinice si vede sua sorella Antigone; accanto a Eteocle si riconosce un altro anziano: a seconda dei tragediografi, si tratta di Edipo, padre dei contendenti, o di Creonte (fratello di Giocasta), zio dei due uomini, oppure di Tiresia l’indovino.
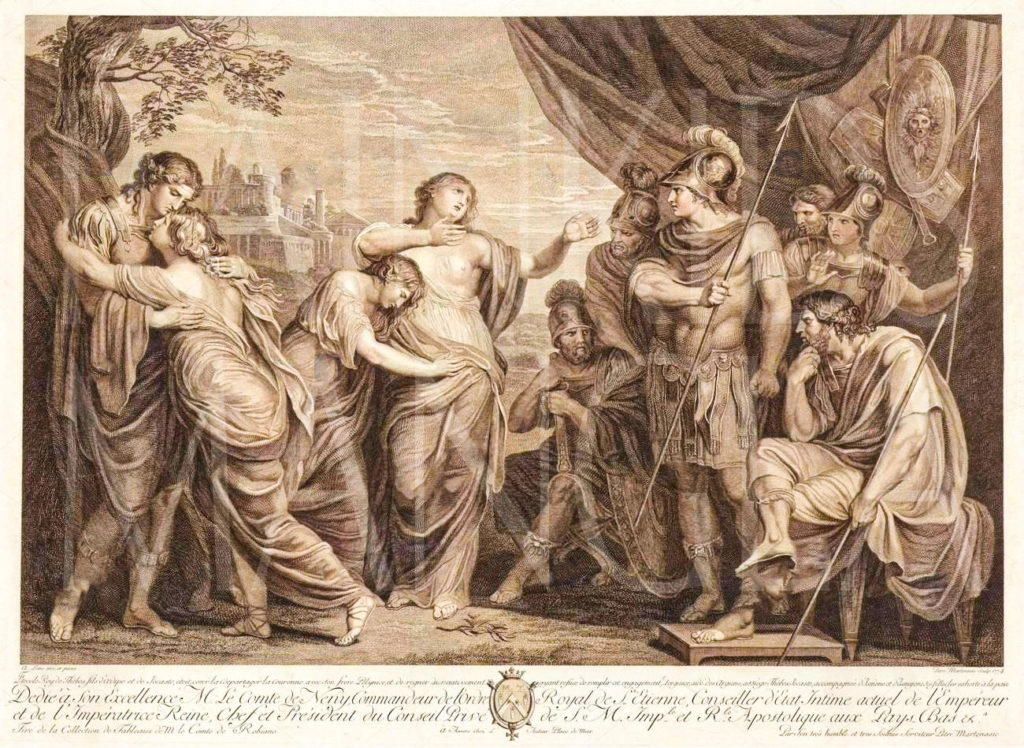


Il mito dei “Sette contro Tebe”
Eteocle e Polinice, figli di Edipo, si sono accordati per spartirsi il potere sulla città di Tebe: regneranno un anno a testa, alternandosi sul trono. Eteocle tuttavia, allo scadere del proprio anno, non lascia il posto al fratello, sicché Polinice, con l’appoggio di Adrasto re di Argo (suo suocero), dichiara guerra al proprio fratello e alla propria patria.
All’inizio del dramma, Eteocle appare impegnato a rincuorare la popolazione preoccupata per l’imminente arrivo dell’esercito nemico. Giunge un messaggero, che informa che gli uomini di Polinice sono nei pressi della città, e hanno deciso di presidiare le sette porte della città di Tebe con sette dei loro più forti guerrieri. È quindi necessario che Eteocle scelga a sua volta sette guerrieri da contrapporre a quelli nemici, ognuno a difendere una porta.
Ricevuta la notizia, il coro di giovani tebane reagisce con paura, ma Eteocle le rimprovera aspramente per questo. Torna il messaggero e riferisce che i sette guerrieri nemici, tirando a sorte, hanno deciso a quale porta essere assegnati. Eteocle viene informato sul nome e sulle caratteristiche principali di ognuno, e a essi contrappone un proprio guerriero. Quando il messaggero nomina il settimo guerriero, che è il fratello Polinice, Eteocle capisce di essere predestinato allo scontro con lui, e che probabilmente nessuno dei due ne uscirà vivo. Tuttavia non si tira indietro, nonostante i tentativi di dissuaderlo.
È a questo punto della tragedia che si fissa, «come in un fermo immagine» (cit. Castrizio), la scena rappresentata nel gruppo scultoreo di cui i due Bronzi di Riace avrebbero fatto parte.
Il gesto della madre Giocasta/Euriganeia, supportata dalla figlia Antigone (sorella dei contendenti) e dall’indovino Tiresia, si situerebbe sul campo di battaglia mentre i due fratelli stanno per affrontarsi.
Negli antichi testi grecoromani era diffuso il motivo di una donna che mostra il seno nudo, simbolo di maternità, per implorare.
Il punto di partenza è Ecuba nel XXII canto dell’Iliade: la disperata supplica della regina di Troia che, svelando il seno, implora il figlio Ettore perché desista dal duello fatale con Achille, è un momento celebre del racconto iliadico ed è il primo passo della letteratura greca in cui il topos dell’esibizione del seno ad misericordiam fa la sua comparsa.
Molti secoli dopo, con Clitemnestra, avviene un ribaltamento del topos: nelle Coefore (Eschilo, 458 a.C.) lo svelamento del seno è il disperato tentativo di convincere il figlio Oreste a non ucciderla.
Ne Le fenicie di Euripide (410/409 a.C.) e più tardi nelle incompiute Fenicie di Seneca, Antigone suggerisce a Giocasta di frapporre il seno nudo tra le spade dei due figli: «Mostrando a tutti penose lacrime/ supplice ai figli porgeva/ porgeva il seno supplice slanciandosi». Arrivata a Roma circa cinque secoli dopo, la tragedia si arricchisce di ulteriore pathos nel passaggio dagli autori greci a quelli latini. Nel VII libro della Tebaide di Publio Papinio Stazio l’anziana madre, scortata dalle figlie, spinge il passo malandato fino all’accampamento argivo, del quale, a petto nudo, riesce a forzare l’ingresso; a Polinice, che le corre incontro e la abbraccia chiamandola ripetutamente madre, ella rivolge un aspro ammonimento e la preghiera di cercare una soluzione pacifica, prima di esigere dagli Argivi la restituzione del figlio caro al proprio seno. Nell’XI libro, infine, udita la notizia del duello imminente, Giocasta si slancia fuori di casa e, raggiunto Polinice, gli oppone i bianchi capelli e — letteralmente — si straccia le vesti scoprendo le mammelle.
L’intera “ipotesi Castrizio” era consultabile qui: www.bronziriace.it/ipotesi-di-castrizio/ (oggi la pagina sembra non esistere più, ma ne è stata recuperata una copia su Internet Archive)

Al di là di tragediografi e poeti classici, la vicenda — leggendaria o meno che fosse — era ben nota nell’antichità. Più antico dell’Iliade, il Ciclo epico Tebano cantava la spedizione degli Argivi in Beozia: secondo il computo antico, la vicenda si sarebbe svolta una generazione prima della guerra di Troia, che oggi si suppone in un decennio intorno al 1210 a.C.. Pindaro (Olimpiche VI.12-17, databile tra il 476 e il 468 a.C., e Nemee IX.9-27, databile tra il 474 e il 471 a.C.) ricorda che i corpi degli argivi caduti a Tebe «furono posti su sette pire». In Omero (Iliade IV.406) ed Esiodo (Op. 162) l’epiteto tradizionale della città è “dalle sette porte”. Sofocle (Antigone 140-141) riprende l’immagine dei «sette capi alle sette porte schierati», e nell’Edipo a Colono (Oed. Col. 1311-1312) Polinice passa in rassegna i nomi dei principî che «con sette schiere e sette lance sono schierati intorno alla piana di Tebe». Pausania il Periegeta (110–180 d.C.), nella “Guida della Grecia” (II.20.4), ci informa che gli uomini caduti insieme a Polinice nell’assalto a Tebe «furono ridotti da Eschilo al numero di sette soltanto». (L’osservazione di Pausania va forse inquadrata nel senso che Eschilo fu il primo a inserire il numero “sette” nel titolo di un’opera che narrava la spedizione, poiché peraltro il “7” non trova corrispondenza negli scavi archeologici in loco e neppure nella pianta delle altre città micenee: del resto, i principî di strategia difensiva sconsigliavano di moltiplicare gli accessi alle città.)

Paolo Moreno, primo a prendere la mira sui Sette (mancando almeno in parte il bersaglio)
Prima di Castrizio, il collegamento ai “Sette contro Tebe” fu proposto originariamente dallo storico e archeologo Paolo Moreno di Udine (cfr. “I Bronzi di Riace, Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe”, Milano 2002, seconda edizione Electa; “Les Bronzes de Riace, Le Maître d’Olympie et les Sept à Thèbes”, Paris 1999, Gallimard), il quale fa riferimento al gruppo statuario “degli eroi in Tebe” (così l’iscrizione nei cippi attorno alla base semicircolare sopravvissuta fino a noi) innalzato nell’agorà di Argo dopo la battaglia di Oinoe (ca. 461 a.C.) vittoriosa contro gli Spartani.
A differenza di Castrizio, Moreno sosteneva che nel caso dei due capolavori ritrovati a Riace si tratti di altri due guerrieri argivi, Tideo e Anfiarao, che presero parte alla medesima prima disastrosa spedizione contro Tebe, e gli artisti sarebbero due noti bronzisti di nome Agelada e Alcamene.
Cominciamo col dire che le opere attribuite ad Agelada II detto il Giovane sono note solo tramite fonti letterarie e monete, e che la sua cronologia è indecifrabile. Viene soprannominato “il maestro dei maestri” poiché tradizionalmente, seguendo principalmente Plinio, si ritiene che dalla sua scuola siano uscite le “star” della generazione successiva: passava per maestro di Mirone (Plinio, Nat. Hist. XXXIV.57), di Fidia (Plinio, XXXIV.54; Tzetzes, Chiliadi VII.929) e di Policleto (Plinio, XXXIV.55). La cronologia è fissata dalle notizie di alcune sue statue di atleti vincitori a Olimpia; e cioè: 1ª quella di Anaco Tarantino (Pausania, VI.14.11); 2ª quella di Cleostene di Epidamno, collocata su una quadriga (VI.10.6); 3ª quella del pancratiaste Timositeo (VI.8.6). Le dette statue si riferiscono al periodo che va dal 520 al 511/508 a.C.; se accettiamo il dato che alla scuola di Agelada si formarono i tre grandi artisti su menzionati (il che si mette in gran dubbio per Fidia), sembra lecito ritenere che l’attività del maestro si sia prolungata fin circa il 460 (supposto inizio dell’attività di Policleto). Questa datazione ai limiti del credibile, con ben sessant’anni di lavori, parrebbe confermata da un’iscrizione di Olimpia, nella quale si fa menzione di un Argeiadas, figlio dell’argivo Agelada, associato a un Atotos, pure argivo, e che risulta dedicata da un certo Prassitele, che si qualifica siracusano e camarinese a un tempo; e da una seconda iscrizione, rinvenuta a Delfi, riferibile a un donario e databile al primo quarto del V Sec. a.C..
Senonché la datazione viene contraddetta da altre notizie: Plinio (Nat. Hist. XXXIV.49) pone intorno al 432 a.C. il momento culminante dell’attività di Argelada; non anteriore al 430 a.C. sarebbe una statua di Eracle ‘Αλεξίκακος, che gli Ateniesi avrebbero dedicata nel demo di Melite in occasione della grande pestilenza (Schol. ad Aristoph., Ran., 504). Nulla di preciso, rispetto alla cronologia, ci è riferito dalle fonti intorno ad altre due opere (o gruppo di due figure), attribuite ad Agelada: una statua di bronzo di Zeus fanciullo e una di Eracle imberbe, che si trovarono insieme a Egio (Pausania, VII.24.4). Quanto alle notizie che contrastano con i dati cronologici più sicuri, si è cercato di spiegarle con possibili inesattezze, sia da parte di Plinio nel riferire al 432 il momento culminante dell’attività di Agelada (possibilissimo, visto che Plinio assegna a quest’epoca anche Pitagora, Policleto e gli altri maggiori maestri del V Sec. a.C.), sia da parte di coloro che pensavano soltanto alla peste del 430 per l’Eracle. Secondo altri studiosi, di artisti a nome Agelada ne sono esistiti due: uno in attività tra la fine del VI e il principio del V Sec. a.C., l’altro all’incirca dopo la metà del V Sec.. Insomma, il solito caos, quando si tratta di fonti antiche — specialmente quando c’è di mezzo Plinio.
Alcamene, detto “ateniese”, forse per cittadinanza acquisita, ma probabilmente originario di Lemnos, lo si ritiene, seguendo un passo di Plinio, allievo di Fidia. Anche in questo caso nessuna opera è sopravvissuta, e la sua cronologia è da prendere con le molle (gli studiosi ci si azzuffano spesso in merito): le principali sculture attribuite ad Alcamene tramite copie di epoca romana sono datate tra il 440 e il 403 a.C.; tuttavia Pausania (Guida della Grecia V.10.8) attribuisce ad Alcamene il frontone occidentale del tempio di Zeus a Olimpia di cui grazie a Plinio conosciamo la datazione: intorno al 465 a.C.. Sarebbe perciò stato attivo per 62 anni: anche qui, assai improbabile. Inoltre secondo Plinio sarebbe stato uno scultore che lavorava principalmente il marmo:
Alkamenes discepolo di Pheidias [Fidia, ndr] fece opere di marmo e un Lottatore di pentatlo in bronzo che i Greci chiamano «encrinómenos», o «approvato all’esame».
Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia” XXXIV.72
Al netto di tutto questo caos delle fonti e di miraggi accademici in cui gli scultori si sdoppiano, a parere di Moreno i Bronzi di Riace somigliano in modo sorprendente alle sculture di detto tempio di Zeus a Olimpia (periodo di realizzazione 471–456 a.C.). Il che peraltro offrì, all’epoca dell’ipotesi di Moreno, la soluzione al più tenace mistero dell’archeologia greca: l’identità del cosiddetto Maestro di Olimpia, cioè il tuttora sconosciuto artista che ha eseguito le sculture in marmo che decoravano il tempio nel santuario, sede delle gare atletiche.
Il “Bronzo A” di Riace sarebbe impostato come lo Zeus di Olimpia al centro del frontone orientale; il suo volto sarebbe rassomigliante a quello di Oinómaos, re di Pisa (che non è ovviamente la città italiana bensì un’antica località dell’Elide, nel Peloponneso, nelle vicinanze di Olimpia; presso Pisa scorreva il fiume Alfeo), nella stessa scena, oppure dell’Atlante nella metopa con Eracle e i pomi delle Esperidi. La testa del “Bronzo B” richiamerebbe l’Eracle che lotta col Toro o con Gerione su altre lastre (metope) del fregio dorico dello stesso tempio di Olimpia.



Grazie all’affinità della barba con quella della statua del dio Ermete presunta opera di Alcamene, già era stata avanzata, da parte dell’archeologo greco Geórgios Dontás (1984), l’eventualità che il “Bronzo B” fosse del medesimo autore: la qual cosa per Moreno verrebbe confermata dalla contiguità del volto del dio rispetto ai Centauri del timpano occidentale di Olimpia riferito ad Alcamene da Pausania.

Trattamento dei riccioli abbondanti, lunghi, attorti, dinamici; forma generale della testa; stretta radice del naso; forma degli occhi; bocca semi aperta, piena di vivacità… tutte queste opere, secondo Dontás, sono da ricondurre a Mirone di Eleutère. Peraltro, le dimensioni della testa Chiaramonti corrispondono esattamente a quelle del Riace A (alt. Chiaramonti: 36 cm, alt. Riace A: 35 cm).
Per il frontone orientale del tempio, si è compreso che il nome di Paionio, sempre avanzato da Pausania, era frutto dell’errata interpretazione di un’epigrafe; la critica archeologica vi aveva comunque riconosciuto il carattere di un bronzista argivo, in coincidenza col fatto che le imprese di Eracle nelle metope sono illustrate secondo le tradizioni di Argo. Poiché la terra di riempimento (terra di fusione) del “Bronzo A” è quella di Argo, e la figura troverebbe rispondenza nella ceramica attica alla metà del V Sec. a.C., per la sua realizzazione Moreno ha pensato ad Agelada, che allora dominava ad Argo (era lo scultore più noto della sua generazione, e come detto secondo Plinio era stato maestro di Fidia, Mirone e Policleto) e che in questo modo diventerebbe anche il miglior candidato all’attribuzione delle sculture di Olimpia, realizzate con la collaborazione di Alcamene I di Lemno. Se uno fece il “Bronzo A”, l’altro nello stesso periodo realizzò il “Bronzo B”.
La fabbricazione argiva attenua l’eventualità [che il realizzatore sia] il beota Calamide [e anche che possa essere] Pitagora con cittadinanza di Samo e Reggio, che era l’antesignano dell’ipotesi magnogreca (Stucchi, 1986); ma soprattutto viene a sanare con insperata evidenza — e qui sta la positiva proiezione del risultato — la discontinuità delle nostre cognizioni tra l’Attica e le scuole del Peloponneso, prospettando al fianco di Alcamene la personalità di Agelada, che spicca ad Argo intorno al 450 secondo le testimonianze letterarie, ma non trovava finora adeguata risposta nei monumenti, per la difficoltà di provare la collaborazione dei due artisti alla decorazione del Tempio di Zeus in Olimpia, dove solo Alcamene ha il supporto della tradizione.
Paolo Moreno, “I Bronzi di Riace, Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe”
L’acerba emancipazione dalla struttura arcaica, il manifestarsi allo stato nascente di trovate che soltanto la classicità attica saprà divulgare, concentrano nel “Bronzo A” le intuizioni che nutriranno una generazione di scultori prima di diventare universali. Le somiglianze che di volta in volta sono state rilevate — in apparente, reciproca contraddizione — con opere di Mirone, di Fidia o di Policleto, trovano finalmente accordo ed esaltazione nel fatto che Agelada è stato maestro dei tre artefici. Assegnandogli il portentoso eroe, comprendiamo come Mirone abbia approfondito il motivo del respiro, Fidia il chiaroscuro della capigliatura, Policleto la potenzialità del moto nella stasi: senza che noi si debba seguire affascinati ciascuna di queste risonanze come traccia verso altrettante, elusive attribuzioni.
L’identificazione del “Bronzo B” con Anfiarao, che nei testi è raccontato sempre accanto a Tideo, è fondata per Moreno sul copricapo: che non sarebbe una kynê bensì una cuffia da indovino (Anfiarao era come Tiresia un veggente).
Figlio di Oecleo e di Ipermnestra, poeta e “àugure”, sposò Erifile, sorella di Adrasto re d’Argo, avendone due figli, Alcmeone e Anfiloco. Fu uno degli Argonauti. Non volendo partecipare alla guerra contro Tebe (detta “dei Sette re”, e Anfiarao ne fu appunto uno) poiché per le sue virtù divinatorie sapeva che vi sarebbe morto, si nascose in luogo noto soltanto a Erifile. Ma questa lo rivelò a Polinice, corrotta dal dono della famosa collana di Armonia (apportatrice di sventure a chi la possedesse), allora di proprietà di Argia, moglie di Polinice. Anfiarao, scoperto, dovette perciò recarsi alla guerra (ricordata da Dante nella Divina Commedia, cfr. Inferno XIV.68-69). Dopo vari combattimenti, in cui ebbe modo di mostrare il proprio valore militare, finì inghiottito dalla terra, improvvisamente apertasi in una profondissima crepa, pervenendo ancor vivo e armato nelle sedi inferne. Il figlio Alcmeone poi lo vendicò macchiandosi di matricidio. Il mito di Anfiarao e di Erifile ha goduto di larga fortuna, specie tra i tragediografi greci, ed è ripetutamente ricordato dai poeti latini.
«Come Eteocle e Polinice nella vicendevole uccisione, o Tideo e Melanippo nella simultanea agonia, anche Tideo e Anfiarao sono uniti nella fine da una reciprocità conturbante», osserva Moreno.
Meditando dagli spalti di Tebe sull’eterogenea adunanza degli assalitori, Eteocle distingue con vivo accento la virtù di Anfiarao dalla furia degli empi: «Ahi, quale sortilegio accosta l’uomo giusto a questi esseri sacrileghi! In ogni impresa nulla è peggio di una malvagia compagnia. Frutto non se ne coglie. Come un uomo pio che s’imbarca con marinai avventurati in un’infamia, e perisce con quella gente detestata dagli dei; come uno che è giusto, e si mette con cittadini inospitali, dimentichi degli dei, e preso fatalmente nella stessa rete, viene percosso e abbattuto nel mucchio dalla sferza divina; così l’indovino, dico il figlio di Oicleo, saggio uomo, giusto, valoroso e pio, grande profeta, mischiato contro voglia a uomini dalla bocca oltraggiosa (thrasystomoi) che vanno a un’impresa – se Zeus vorrà – senza ritorno, insieme a loro sarà travolto» (Eschilo, Sette 597-614).
Paolo Moreno, “I Bronzi di Riace, Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe”
I temerari chiamati in causa con l’epiteto di thrasystomoi sono il blasfemo Capaneo — che troviamo nel frontone di Pyrgi con un robusto impianto figurativo di non poco interesse per la genesi del “Bronzo A” — e, nella massima pregnanza del termine, Tideo l’antropofago. Con quest’ultimo il contrasto si fa lancinante nel racconto di Eschilo sulla discordia tra gli aggressori: Anfiarao «dal suo posto davanti alle Porte Omoloidi rimprovera altamente la violenza di Tideo, l’omicida, rovina della sua città, supremo maestro di sciagure per Argo, prodromo delle Erinni, ministro di strage, consigliere di ogni male ad Adrasto» (Eschilo, Sette 570-575). E d’altra parte «Tideo […] offende e insulta l’indovino» accusandolo (qui il poeta si serve di una citazione omerica) di «evitare la sorte e la battaglia per mancanza d’animo» (Eschilo, Sette 382-383).
È avvincente leggere la sorta di… “duello fratricida” che avviene fra due studiosi affini, Paolo Moreno e Daniele Castrizio, mettendo i loro libri uno accanto all’altro.
Moreno, all’alba del Terzo Millennio, argomenta in questo modo sui dettagli dei due Bronzi:
La strana fascia (di lana?) dalla rustica superficie, che il “Bronzo B” indossava sotto il casco metallico (Stucchi 1986; Sabbione 1994, p. 188), può essere il segno esteriore di consacrazione dell’indovino: «L’ornamento delle bende di Parnaso rivela il vate» (Stazio, Tebaide IV.216-217). Rimane nel bronzo una parte della striscia che correva al di sopra della fronte e si componeva con quella più stretta, girata sull’occipite; la cuffia era allacciata sotto il mento dal cordino che affondava nella barba lungo il solco verticale, ancora nettamente visibile. Sul retro, dove il “Bronzo B” conserva un lembo della cuffia sottostante al paranuca dell’elmo, l’estremità (oggi perduta) di questa “bianca infula” doveva incontrare la coda pendente del “purpureo cimiero” (albaque puniceas interplicat infula cristas, IV.218). Il motivo diventa sensazionale nella corrispondenza della visione poetica d’insieme al nostro Anfiarao: «Abbassata l’asta di frassino della lancia, apparve l’infula sotto l’elmo rimosso» (VII.717). Conosceva Stazio la replica marmorea della statua di Alcamene, oggi a Bruxelles?
Il “Bronzo A” partecipa all’intensità del momento nella contrazione del braccio destro, abbassato ma non abbandonato: formidabile macchina da guerra. Il pollice e le ultime dita serravano l’asta obliqua (oggi dispersa), che aderiva all’avambraccio fino ad affondare nel solco previsto; l’indice rimane discosto perché impegnato a reggere l’occhiello dell’ancile (ankyle), l’estremità del laccio che circondava in fitte spire il giavellotto nel suo baricentro, servendo da impugnatura. Il terminale libero consentiva all’indice di imprimere all’arma una rotazione all’atto del lancio, in modo da accrescere (per l’effetto giroscopico) la stabilità del volo, la precisione della mira e la forza dirompente. La contrazione del bicipite e il lavoro di tutti i tendini in vista – “le braccia dure e nervose” di Tideo (Stazio, Tebaide VI.845) – confermano che la lancia non era poggiata a terra, come se il guerriero fosse stato in riposo, bensì tenuta pronta in allarme: messaggio cui s’incorpora il messaggero nella mortifera stretta.
[In più, Moreno ipotizza l’antica presenza di una bandoliera su entrambe le statue e una corona di alloro sul “Bronzo B” frapposta fra l’elmo e il capo — ndr]
A simili argomentazioni circa quindici anni dopo Castrizio risponde così:
Il giavellotto è stato ipotizzato dal Moreno per la presenza di un foro all’altezza del dito indice della mano destra della statua, che, a suo avviso, faceva riferimento alla correggia di cuoio che serviva a scagliare l’akontion a distanza maggiore e con migliore precisione. Ma l’idea stessa di un giavellotto in statue di eroi opliti, per la mentalità antica, era semplicemente offensivo*, dato che il mondo classico considerava le armi da lancio tipiche di personaggi non dotati del coraggio necessario a fronteggiare il nemico a viso aperto. Il giavellotto era arma di peltasti o di psiloi, mercenari stranieri o appartenenti alle classi più basse della scala sociale, non certo di eroi guerrieri. […] Il parazonion, la spada a tracolla con bandoliera, invece, è completamente di fantasia, non essendoci sulle statue traccia di questa arma.
Venendo ora al “Bronzo B”, dobbiamo dire che la ricostruzione della cuffia è fortemente inesatta […] la spada a tracolla è completamente inventata, come pure la corona d’alloro sull’elmo. Il particolare della ricostruzione della cuffia è di grande importanza per l’identificazione del personaggio rappresentato nel “Bronzo B”: il Moreno, infatti, è convinto che si tratti dell’indovino Amfiarao, proprio per il particolare della “cuffia dell’indovino”, che si intravede sotto l’elmo. In verità, l’unica cuffia tipica di un indovino antico era, nel mondo romano, l’apex, ma tale ipotesi ci sembra sia da scartare con grande decisione: in primo luogo l’apex, dall’inconfondibile forma peculiare, è proprio della religione romana, e non ve n’è traccia in Grecia; secondariamente, la forma dell’apex è totalmente diversa e incompatibile rispetto a ciò che si riesce a ricostruire in base ai segni nel bronzo.
Rimangono altri punti deboli: i confronti con la ceramica attica non sembrano persuasivi; non risulta peraltro chiaro come due artisti non citati dalle fonti abbiano potuto realizzare il gruppo statuario ad Argo, attribuito dagli antichi ad altri scultori; l’indizio iconografico dei denti non ci sembra cogente per identificare un Tideo di cui non è stato offerto nessun confronto [sulla vicenda dei “denti”, cfr. osservazioni alla fine dell’articolo —ndr]; non sembra molto convincente che il “Bronzo B” raffiguri Amfiarao solo perché è spesso nominato con Tideo, soprattutto se, come abbiamo visto, cade l’ipotesi che vedeva nella cuffia sotto l’elmo un copricapo degli indovini.
L’ultimo punto riguarda le terre di fusione, dal Moreno utilizzate per attribuire una statua a un artista argivo e l’altra a un bronzista attico. In verità, le analisi non hanno assolutamente specificato che una statua sia stata eseguita ad Argos e una ad Atene, propendendo per un’unica sede.
NOTA (*) – L’appunto sul giavellotto necessita di un approfondimento. Un giavellotto è una lancia leggera progettata principalmente per essere scagliata, storicamente usata come arma a distanza; la lancia lunga, la mitica “dory”, veniva invece usata nello scontro ravvicinato o corpo a corpo (era una lancia lunga 2/3 metri, con corpo in legno di corniolo o di frassino e un peso di ben due chilogrammi). Il giavellotto è arma “da lancio”, la lancia “da urto”. I peltasti erano unità militari di fanteria leggera che affiancavano gli opliti greci durante le battaglie; erano armati con diversi giavellotti, spesso con cinghie da lancio per aumentare la potenza di distacco. I peltasti lanciavano i loro giavellotti contro le truppe più pesanti del nemico, la falange oplita, al fine di spezzare le loro linee in modo che gli opliti del loro stesso esercito potessero distruggere la formazione nemica indebolita.
Gli opliti si differenziavano dai peltasti armati alla leggera. L’armatura oplitica, che comprendeva scudo, corazza di metallo o di cuoio guarnito di metallo, schinieri, elmo, lancia e spada, s’impose quando, abbandonato il poco maneggevole scudo dei Micenei, fu necessario, a difesa dalle neonate armi di ferro, un insieme di elementi (panoplia) che proteggesse le varie parti del corpo. In conseguenza del progresso economico del VII Sec. a.C. e del diffondersi della metallurgia, poterono fornirsi di panoplie non solo i nobili ma notevoli strati di medi proprietari, che divennero così il nerbo di regimi politici in contrasto con quelli tradizionali.
La tattica oplitica, consistente nell’avanzata inarrestabile di una schiera compatta di opliti, prevalse in Grecia fino al V Sec. a.C.: dopo la Guerra del Peloponneso (successiva alla realizzazione di entrambi i Bronzi di Riace), che aveva messo in luce i vantaggi dell’impiego della cavalleria e della fanteria leggera, generali, tra cui Ificrate, introdussero l’armamento leggero che diventò predominante.
Dire perciò che un «eroe» (il “Bronzo A”) è armato di giavellotto anziché di lancia è non soltanto un anacronismo ma è come dire che è un codardo.
Un dettaglio su tutti spicca in questa polemica ed è sufficiente a rigettare le ipotesi di Moreno sul “Bronzo B”, affossando però in tal modo le sue attribuzioni (che sul suo libro sono tutte inestricabilmente collegate) quasi per intero: le testimonianze iconografiche che oggi possediamo escludono la possibilità che il copricapo sia qualcosa di diverso da una kynê.
Perdendo per intero il costrutto di Moreno, se ne perdono intuizioni che altrimenti sarebbero da approfondire: su tutte, l’equivalenza fra “Bronzo A” e Tideo, e la centralità della bottega di Agelada nell’origine dei Bronzi (cfr. le note alla fine dell’articolo).
Secondo Moreno la composizione del gruppo statuario cui i Bronzi di Riace sarebbero appartenuti era «così affollata da accogliere il ripetersi del gesto in un ritmo pausato dai soggetti per noi dispersi». È necessario osservare, tuttavia, che proprio la ripetitività dei gesti potrebbe essere la prova dell’appartenenza delle due statue a gruppi differenti: nei casi di cui ci è rimasta la testimonianza, gli artisti greci evitavano la ripetitività e le analogie tipologiche all’interno del medesimo gruppo.
Utile altresì ricordare che molti studiosi, soprattutto in base alle analisi stilistiche (cfr. più avanti), sono concordi sulle date di realizzazione dei Bronzi: circa 460 a.C. per il “Bronzo A” (il che coincide con la prima rappresentazione di Eschilo e con la battaglia di Oinoe) e circa 430 a.C. per il “Bronzo B”. Questo genere di datazione viene ripetutamente contestato (anche dallo stesso Moreno, il quale propone la quasi contemporanea collaborazione Agelada-Alcamene), ma non è stato finora confutato con dati inoppugnabili.
La medesima combinazione che ornava l’Agorà di Argo — i Sette e gli Epigoni — si ripeteva nel donario decretato dalla città stessa a Delfi, di cui si conservano ancora oggi le fondamenta: una grande esedra semicircolare a meridione della Via Sacra, poco dopo l’ingresso al recinto. Quest’opera è meno significativa ai fini dell’indagine sui Bronzi di Riace poiché Pausania l’attribuisce a due artisti di Tebe:
Vicino al cavallo vi sono altri doni degli Argivi, che furono condottieri di quelli, che insieme con Polinice andarono contro Tebe, Adrasto di Talao, Tideo di Oeneo, i discendenti di Preto, Capanèo di Ippono, Eteoclo d’Ifi, Polinice, e Ippomedonte figlio delle sorelle di Adrasto: vicino è stato fatto il carro di Anfiarao, e Batone, che sta sopra di esso per guidare i cavalli, e d’altronde attinente per la parentela ad Anfiarao: l’ultimo di loro è Aliterse. Queste sono opere d’Ipatodoro, e di Aristogitone, e le fecero come gli Argivi stessi dicono colle vittorie, che in Oenoe Argiva essi e gli alleati Ateniesi sopra i Lacedemonj riportarono. Per questa stessa azione (a mio credere) dedicarono gli Argivi quelli ancora dai Greci chiamati Epigoni.
Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” X.10.2
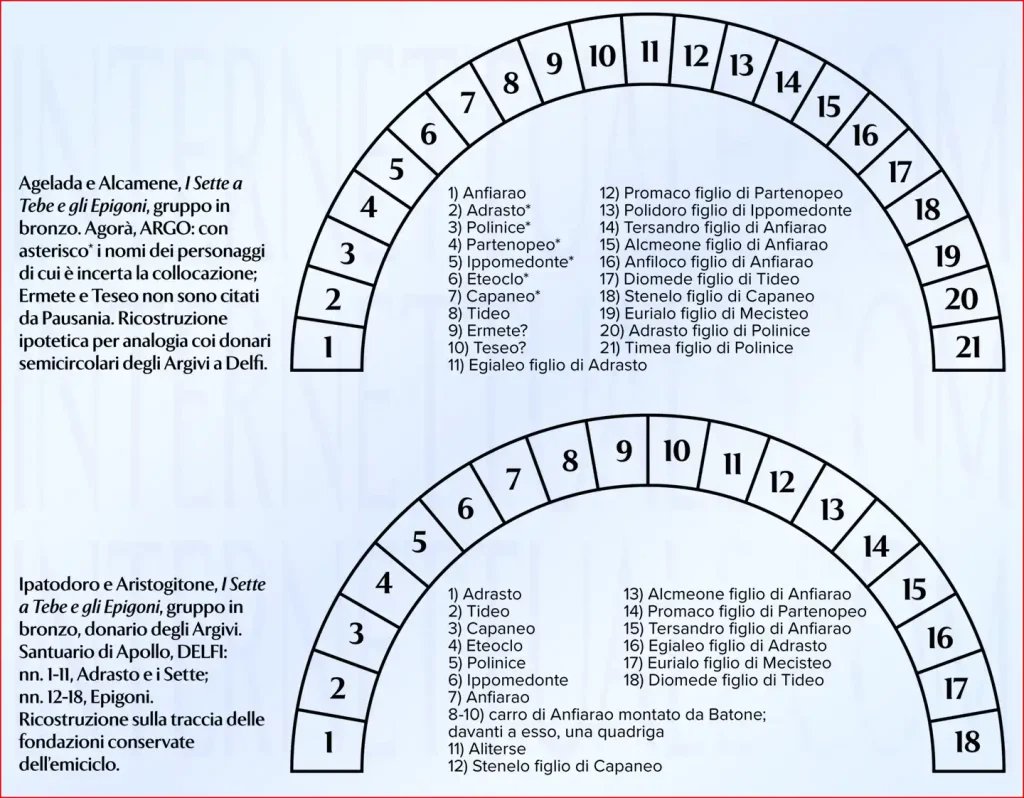
CHI REALIZZÒ I BRONZI, DOVE, E QUANDO?
Secondo Castrizio (che lo riprende dalle ipotesi del 1986 di Sandro Stucchi, cfr. prossimo capoverso) l’autore sarebbe il grande bronzista Pythagoras, meglio noto come “Pitagora reggino” o “Pitagora di Reggio”, scultore attivo tra il 480 e il 450 a.C. circa, nel Peloponneso e in Magna Grecia. E attraverso la sua “bottega” sarebbe autore di entrambi, malgrado le incongruenze*.
I due Bronzi di Riace, come detto, farebbero parte di un più esteso gruppo statuario, quello dei “Fratricidi”, di cui ci darebbero notizia sia il polemista cristiano Taziano l’Assiro, vissuto nel II Sec. d.C. (autore della celebre utopia in cui tenta di armonizzare “le avventure di Gesù” descritte sui quattro Vangeli, cfr. il mio libro Cerco il Figlio pagg. 55, 161, 321, 455), sia probabilmente il poema epico “Tebaide” di Publio Papinio Stazio, pubblicato all’epoca di Domiziano (ca. 92 d.C.: a parere di Castrizio, Stazio sarebbe stato ispirato dalla visione delle cinque statue).
NOTA (*) — La prima incongruenza è il trentennio che stilisticamente intercorre fra l’una e l’altra, una seconda è di natura non artistica ma tecnica: per esempio nel “Bronzo A” (anche detto “il Giovane”) alcune porzioni dei riccioli della barba sono fabbricate a parte e poi saldate (come nel celebre “Cronide” di capo Artemisio, statua in bronzo databile al 490/470 a.C. e conservata nel Museo archeologico nazionale di Atene, ritrovata anch’essa in fondali marini, quelli antistanti capo Artemisio, nell’odierna Eubea: anch’essa di autore incerto, ma da alcuni attribuita allo stesso Pythagoras), mentre nel “Bronzo B” (il “Vecchio”) i riccioli sono colati in un solo pezzo. Ma le incongruenze sono assai più numerose — un esaustivo compendio è presente più avanti, ndr.

Sandro Stucchi, primo a proporre Pythagoras
Più che nell’uso dell’avorio per il bulbo oculare per renderne il colore del bianco latte, il desiderio estremo di imitare la realtà naturale è dato dalla presenza delle orecchie sotto i boccoli che le nascondevano completamente: qui più che la realtà delle orecchie, l’artista ha voluto riproporre esattamente il loro volume sotto la massa dei capelli, in modo che questi scendendo dai parietali trovassero l’esatta caduta accanto ai padiglioni auricolari. La presenza degli orecchi non è quindi un’inutile sovrabbondanza, ma il tocco reale dell’artista, al quale non basta il rendimento arioso delle ciocche a tortiglione, ma che vuol fare intendere anche che cosa si nasconda dietro a loro.
Sandro Stucchi, 1986
Sandro Stucchi (1922–1991) è stato un grande nome dell’archeologia italiana. Dal 1956 insegnò archeologia e storia dell’arte greca e romana all’università di Urbino, rimanendovi fino al 1976, anno in cui passò all’università di Roma La Sapienza. Oltre che dei Bronzi di Riace si occupò di ritrovamenti come la villa romana di Lucinico, ma la sua attività annovera oltre 150 lavori, di cui almeno una settantina quelli concernenti gli scavi dei siti archeologici libici di Cirene e Leptis Magna: Stucchi fu infatti direttore della missione archeologica italiana in Libia per oltre trent’anni, riavviandola dopo la parentesi della guerra e conducendola fino alla morte nel 1991.
Secondo Stucchi, i Bronzi di Riace rappresenterebbero entrambi l’eroe locrese Eutimo (cfr. S. Stucchi, Nuove osservazioni sulle statue bronzee di Riace, in “Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti” XLIII, 1986, pagg. 99–102; Le due statue di bronzo dal mare di Riace. Una revisione, in “Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti” XLI, 1986, pagg. 111–135). Seguendo il mito, Eutimo, figlio di Asticle locrese, dopo aver vinto negli agoni di Olimpia nella specialità del pugilato durante tre edizioni, avrebbe debellato il demone Alybas che terrorizzava gli abitanti di Temesa, città di dubbia identificazione (citata in Omero, Licofrone, Strabone, Tito Livio e Plinio ma mai ritrovata) e che Strabone situava sul Tirreno cosentino. Tale demone sarebbe stata la nemesi di Polite, compagno di Ulisse, lapidato dei cittadini di Temesa in seguito alla violenza da lui commessa ai danni di una donna locale, e abbandonato insepolto sulla spiaggia. Per vendetta, Alybas avrebbe reclamato il sacrificio annuale di una fanciulla.
L’ipotesi di Stucchi è che il “Bronzo A” rappresenti Eutimo di Locri ritratto quale eroe guerriero vincitore a Temesa: la statua sarebbe opera dell’eccelso scultore Pitagora di Reggio e la sua realizzazione sarebbe avvenuta poco dopo il 470 a.C., al termine dei successi di Euthymos alle Olimpiadi. Il “Bronzo B”, invece, raffigurerebbe… lo stesso Eutimo di Locri, stavolta presentato come un pugile, eroizzato dopo la morte. Questa statua sarebbe opera di un artista magnogreco che avrebbe operato poco prima del 425 a.C..
Nel caso di Eutimo l’eroizzazione sarebbe avvenuta quando questi era ancora in vita: secondo una notizia di Plinio il Vecchio tratta dagli “Aitia” (opera del 280 a.C.) del poeta Callimaco di Cirene (cfr. Nat. Hist. VII.152 = Callimaco fr. 99 Pf.), le due statue che Eutimo possedeva a Locri e Olimpia — ossia quelle che oggi chiamiamo Bronzi di Riace — furono danneggiate nel medesimo giorno da un fulmine: in risposta a questo prodigio, che aveva destato grandissima meraviglia come segno del favore degli dèi, la Pizia ordinò di sacrificare al pugile, sia mentre questi era ancora in vita, sia poi da morto.
Si tratta del primo caso di eroizzazione di atleta a noi noto del mondo antico e non è improbabile che esso abbia avuto origine per iniziativa di Eutimo stesso: numerose caratteristiche del suo personaggio rimandano infatti alla figura di Eracle (in particolare la lotta contro il dio fluviale Acheloo), analogamente a quanto si racconta per altri atleti che presero Eracle come modello: Milone di Crotone guidò i suoi concittadini all’assedio di Sibari vestendo la leonté e con in mano la mazza, mentre Teogene di Taso, altro lottatore famoso dell’antichità, proclamava di essere figlio dell’eroe (Diodoro, XII.9.6; Pausania, VI.11.2).
Stucchi offre anche un responsabile per la presenza delle opere a Riace: Pirro, grande collezionista di capolavori, avrebbe depredato le statue in Italia e poi, dopo la sconfitta di Maleventum con i Romani nel 275 a.C., nella ritirata da Locri all’Epiro, il naufragio.
L’attenzione è attirata dal saccheggio di Locri da parte di Pirro, per le circostanze che hanno accompagnato questa azione. Dalle ricostruzioni storiche sappiamo che Locri si alleò a Pirro dopo la battaglia di Eraclea; che in città vi era una guarnigione di Pirro e anche un suo atelier monetale dal 280 a.C.; che infine Pirro al ritorno dalla sfortunata impresa in Sicilia sbarcò a Locri e da qui preparò il suo ritorno in patria nello stesso 275 a.C., non prima però di aver compiuto vari misfatti secondo racconti di Tito Livio e di Dionigi di Alicarnasso: tra altre gravi ingiurie che inferse alla città di Locri, la spoliazione dei tesori del Santuario di Proserpina rimasti intatti fino a quel giorno e il conseguente carico di denaro e anathémata, quindi anche statue, sulle navi. Ma fatta poca strada verso l’Epiro, una burrasca fece affondare una parte della flotta ed egli, inteso questo come un segnale divino, fece riconsegnare a Locri denaro e anathémata che erano stati asportati.
Sandro Stucchi
L’asportazione delle statue da Locri da parte di Pirro fu operata con ogni cura, scalpellando le basi per mantenere intatti i tenoni che si sono conservati in modo eccellente. Fulvio Nobiliore, alla presa di Ambracia, la capitale di Pirro, nel 186 a.C., portò via quasi mille statue che il re epirota aveva raccolto da varie parti del mondo greco. La sua spoliazione di Locri, e in particolare l’asportazione delle due statue di Eutimo, rientra nell’idea di riportare comunque in patria i segni di una vittoria, per dimenticare i trascorsi negativi della campagna in Sicilia. Le due statue di Eutimo, quindi, ad Ambracia avrebbero aumentato il numero delle opere d’arte, ma avrebbero ricordato chiaramente anche una vittoria degli Epiroti sulla città bruzia.
Tuttavia la presenza delle statue in Italia già all’inizio del III Sec. a.C. è troppo in anticipo sulle razzie dei Romani in Grecia (cominciate più di un secolo dopo): presuppone che le opere nacquero nella penisola e ivi rimasero, non mettendo mai i loro bronzei piedi nell’Ellade — e se è per questo nemmeno a Roma, dove Pirro non giunse mai —. Mentre invece sappiamo per certo, dalle terre di fusione, che furono forgiate nel Peloponneso nord-orientale, fra Argolide e Megaride.
Sempre un problema di cuffie
Anche Stucchi, come Moreno, inciampa nel… rotto della cuffia. Per la sua ricostruzione avrebbe un valore probante la cuffia presente sotto l’elmo del “Bronzo B”, che sarebbe stata tipica dei pugili. Osservando, però, il copricapo dei pugili, come risulta per esempio nella statua dell’atleta Amelung, si può notare come tale elemento appaia iconograficamente molto diverso da quello ipotizzabile per il “Bronzo B”, con due lembi laterali molto lunghi.
A svilire del tutto le sue pur sensate ipotesi c’è poi il fatto che a sostegno delle identificazioni Stucchi, in un post-scriptum, dichiari che le analisi sulle terre di fusione delle due statue indicherebbero come possibile area della fusione «la Calabria nord-occidentale» (l’area di Temesa): affermazione smentita proprio dalle analisi chimiche per entrambe le sculture, che riportano irrefutabilmente al Peloponneso orientale.
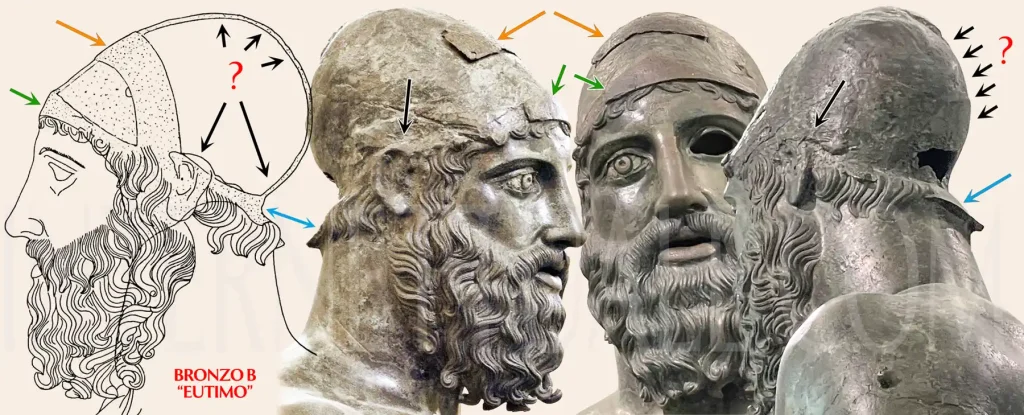

[…] un caschetto di pelle rinforzato da strisce di cuoio, con sottogola e con falda paranuca, caratteristica degli atleti, e in particolare dei pugili, in allenamento. Esempi di caschetti di questo genere, conosciuti come amphotides, ci sono pervenuti in diverse varianti dall’antichità, sia in rappresentazioni a tutto tondo che su ceramica. Mi pare quindi evidente che la figura calzasse un caschetto da allenamento posto tra la capigliatura e l’elmo rialzato.
Sandro Stucchi
Tuttavia, come si può vedere dalle pitture vascolari, gli amphotides avevano un aspetto diverso, e il paranuca era molto più accentuato, arrivando fino a metà collo.

Sulla vita di Pythagoras si fa una gran confusione (altro caso di miraggi accademici in cui gli scultori si sdoppiano). Già la fonte romana più antica, Plinio il Vecchio, oltre a postdatare in avanti di molti decenni i grandi bronzisti (Alcamene, Agelada, Pythagoras, Policleto, Mirone: tutti attribuiti al finire del secolo), scambia il Pitagora di Reggio con un “secondo Pitagora nato a Samo” e salta di palo in frasca con un Sostrato figlio della sorella del primo Pitagora; sulla base della statua del pugile Eutimo ritrovata a Olimpia, la firma è “Pitagora di Samo”; molti studiosi identificano un altro Pitagora di Samo scultore (è sempre così, con gli studiosi: quando la cronologia è troppo lunga o gli autori antichi dimostrano di aver alzato il gomito mentre scrivevano, «ce ne doveva essere un altro con lo stesso nome» e il problema sparisce, succede perfino coi Vangeli dove le donne di nome Maria si moltiplicano come i virus, e per gli “studiosi” è normale, anche fra sorelle); su ben tre enciclopedie — Wikipedia, Enciclopedia Britannica e Treccani — si legge che Pythagoras nacque forse a Samo e si trasferì da esule (immigrato, diremmo oggi) con tutta la famiglia in Magna Grecia dopo le Guerre Persiane. È possibile che lo scultore fosse solito firmarsi proprio così, “Pitagora di Samo”, in osservanza alle proprie origini, e che sia stato questo a generare tutto il qui pro quo. Anche perché sfortuna ha voluto — nel senso proprio greco del termine: colpa delle tre dispettose sorellacce Cloto, Làchesis e Àtropos, le Moire — che nell’antichità ci fosse un omonimo di gran lunga più celebre: il Pitagora di Samo filosofo, attivo mezzo secolo prima. La cosa data da tutti per scontata è che il Pitagora bronzista visse a Rhégion, l’odierna Reggio Calabria, fiorente città della Magna Grecia, almeno a partire dal 496 a.C., al tempo del tiranno reggino Anaxilas; in riva allo Stretto sarebbe divenuto discepolo di Clearco/Learco di Reggio, fantomatico scultore greco antico*.
NOTA (*) – L’unica fonte di notizie riguardo a Clearco di Reggio è il solito Pausania (Guida della Grecia III.17.6), il quale dice che una statua di lui, rappresentante Zeus Hypatos (altissimo), era nel tempio di Atena Chalkioikos a Sparta. La statua era di bronzo, ma non fusa, bensì fatta di tanti pezzi inchiodati fra loro: e secondo Pausania era la più antica statua di bronzo che esistesse. Se la testimonianza circa la tecnica è esatta, dobbiamo credere che Clearco appartenesse veramente a tempi molto antichi: in tal caso però sono da accogliere come dubbie le altre notizie aggiunte alla prima, che cioè Clearco avesse avuto come maestro, oltre ai mitici Dipeno e Scilli, anche Dedalo oppure Euchiro di Corinto, e come discepolo Pitagora di Reggio.
Da simile pochezza di fonti, qualcuno è riuscito addirittura a ipotizzare una “celebre scuola di scultura a Reggio” (!), finendo perfino su Wikipedia: arrivati sull’enciclopedia online, si possono leggere perle come una liberissima interpretazione delle parole di Plinio, in cui le statue di Pythagoras «respirano» (sic!), o l’ennesimo sdoppiamento di uno scultore, in base al quale Clearco a sua volta diventa allievo di un mai esistito Learco.
Questo per dire com’è ridotta la “ricerca”…
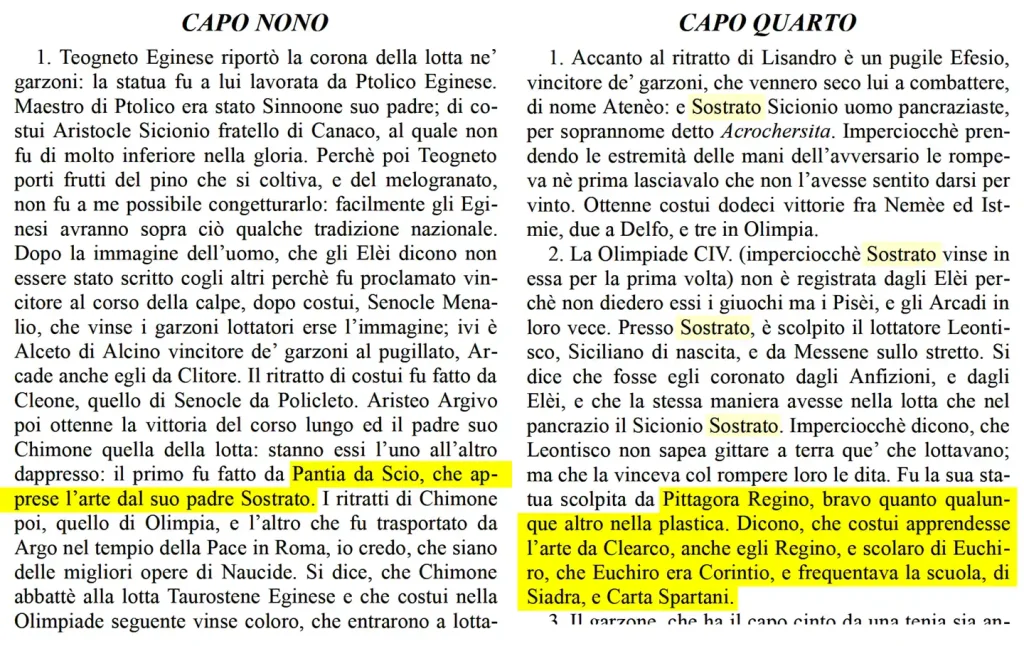
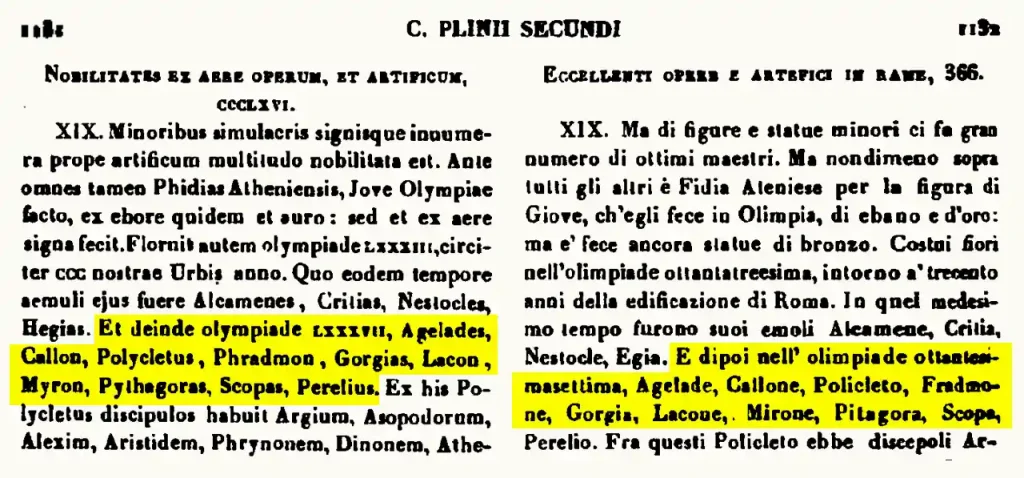
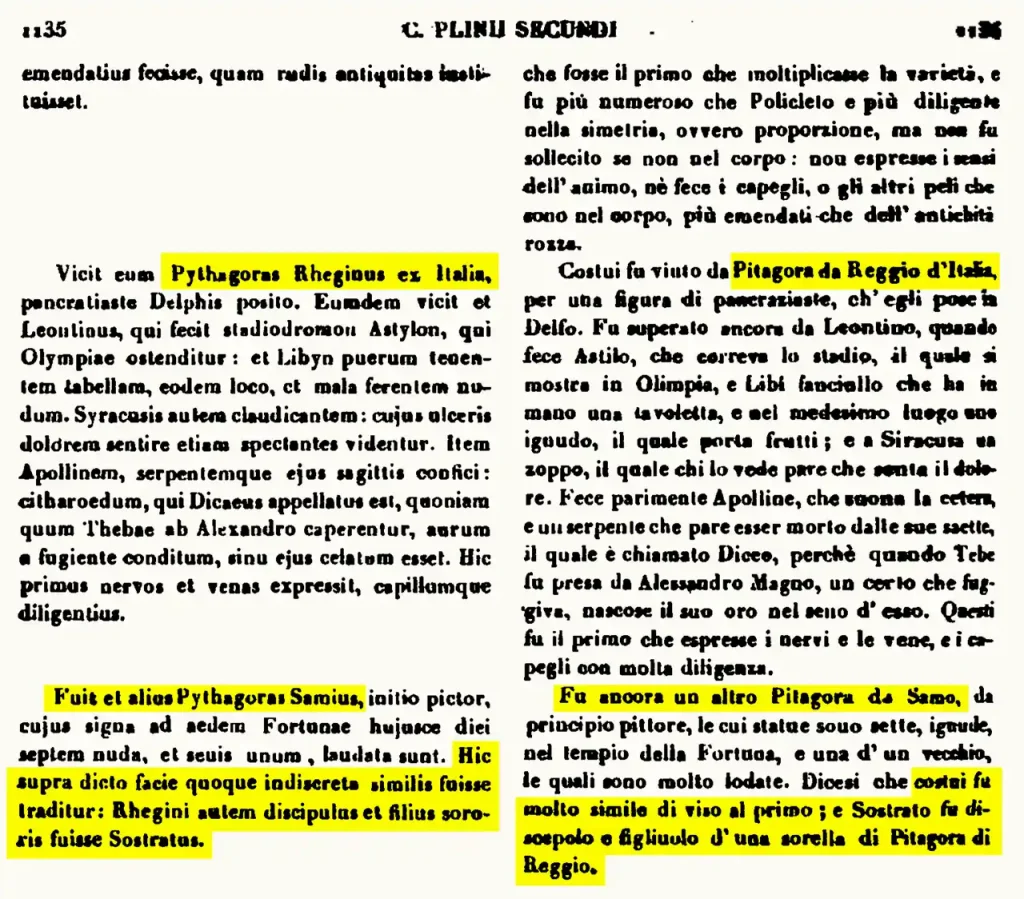
Nell’elenco dei migliori bronzisti greci di Plinio il Vecchio — il quale lo riprende da Senocrate di Sicione (III Sec. a.C.), “il padre della storia dell’arte” — a Pitagora Reggino viene assegnato un posto d’onore, accanto ad autentiche “star” come Fidia e Mirone; inoltre, riferendosi all’arte di Mirone, Plinio afferma: «[…] Lo superò Pitagora di Reggio in Italia col Pancratiaste dedicato a Delfi […]. A Siracusa fece poi uno Zoppo tale che anche a chi lo guarda sembra di sentire il dolore della sua piaga […]», e soprattutto, il passo decisivo per la supremazia tecnica di Pythagoras: «Hic primus nervos et venas expressit, capillumque diligentius (Pitagora fu il primo a riprodurre i tendini e le vene, e a trattare i capelli con maggiore diligenza)» (Plinio il Vecchio, Nat. Hist. XXXIV.59).
Il pensiero critico su scultura e pittura, formatosi in Grecia nel III Sec. a.C., è stato tramandato da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia. I giudizi critici che egli riferisce sono presi dai trattati della pittura e della scultura di Senocrate di Sicione (scultore della scuola di Lisippo) e di Antigono di Caristo, entrambi della prima metà del III Sec. a.C.. Prima di Senocrate tutte le arti erano pensate come prodotto d’ispirazione divina, per cui se ne tipizzavano le leggi in canoni di armonia e ritmo. A quest’ordine di leggi apparteneva anche il “canone” di Policleto della figura tetragona, cioè costruita secondo proporzioni numeriche di origine pitagorica (l’altro “Pitagora di Samo”, quello più famoso, il filosofo).
Dal pensiero estetico di Platone e Aristotele, Senocrate trasse alcune norme di giudizio. Poiché “l’arte è mimesi”, egli annotò il progresso nell’abilità tecnica dell’imitare la realtà; poiché “la bellezza ha carattere matematico” e “si identifica con la proporzione geometrica”, elencò diversi tipi di proporzioni; si occupò della bellezza come simbolo della moralità. Senocrate fissava l’attenzione agli aspetti dell’arte che avevano un rapporto con la tecnica: simmetria, ritmo, composizione prospettica, contrasto di colori, tono. Statica naturale di una statua, varietà delle immagini, difficoltà di rendere nel marmo o bronzo i capelli, delicatezza dell’esecuzione dei particolari: sono questi i criteri di giudizio di Senocrate.
Per prima cosa egli suggerisce di non curarsi degli scultori anteriori a Policleto, “quelli che fanno le statue poggianti su una sola gamba”. Poi è tutto un rincorrersi di vizi e virtù: Policleto usa proporzioni tozze, Mirone le ha migliorate; Mirone sorpassa Policleto per varietà ma non sa rendere i capelli; Pitagora migliora la fattura dei capelli, rappresenta nervi e vene, e ha trovato un rapporto tra simmetria e ritmo. Infine, senza alcuna remora di sbandierare piaggeria, secondo Senocrate il numero uno è il suo maestro Lisippo (ultimo tra i grandi maestri della scultura greca classica, attivo dal 372/368 a.C. fino alla fine del IV Sec. a.C.), che sa rappresentare perfettamente i capelli e la sua esecuzione è curata nei minimi dettagli.
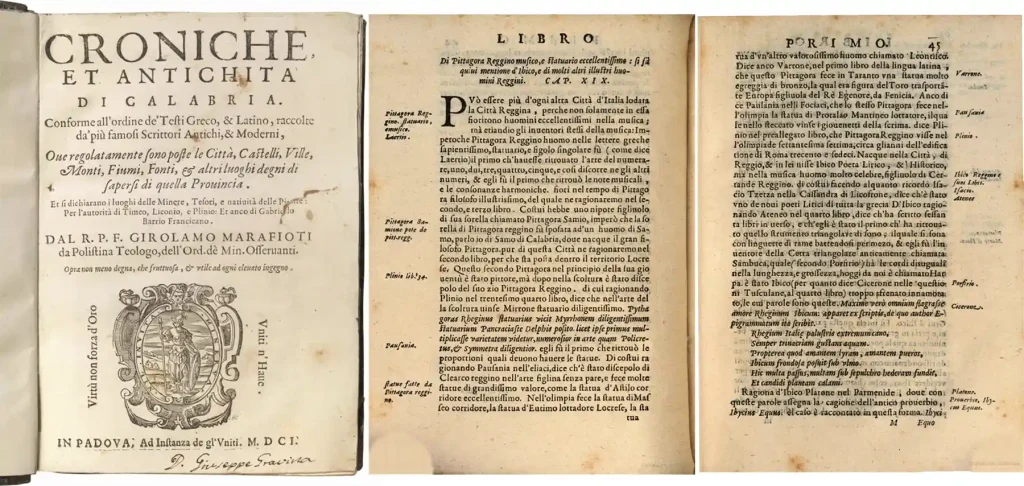
Pitagora viene indicato dunque come il primo scultore ad avere una cura minuziosa di particolari come capelli, tendini e vene, un’attenzione che è tipica dello “stile Severo” e che non riguarda il minuto particolare fine a sé stesso ma la struttura dell’anatomia umana indagata come un tutto organico. È esattamente ciò che si vede nei due Bronzi di Riace, nei quali la cura e precisione dei dettagli (vediamo riprodotte fedelmente anche cose assurde come le pellicine delle unghie) lascia l’osservatore sbalordito non meno del sorriso di Monna Lisa. Si può in ogni caso affermare che il motivo di arterie e vene sembra già conosciuto e diffuso all’inizio del V Sec. a.C.: le vene non sono visibili soltanto nella statua dell’Auriga di Delfi e in quella del Cronide di capo Artemisio, ma anche in alcuni frammenti di statue di bronzo a Olimpia.
Pythagoras come detto avrebbe realizzato la statua del pugilatore Eutimo di Locri, per la vittoria conseguita nel 472 a.C. (cfr. Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” VI.6.2), che lo stesso Castrizio nel 2000 aveva proposto come l’«eroe» raffigurato nel “Bronzo A” (cfr. Daniele Castrizio, “I Bronzi di Riace. Ipotesi ricostruttiva”, Reggio Calabria 2000). Avrebbe fra l’altro realizzato, secondo il resoconto che Pausania fa nel VI libro della sua Guida, diverse statue di altri atleti olimpici: il lottatore Leontisco di Messina, vincitore nel 456 e 452 a.C. (VI.4.3); Protolao di Mantinea (VI.6.1); Dromeo di Stinfale (VI.7.10); Astilo di Crotone (VI.13.1); Mnasea di Cirene libico, vincitore nel 456 a.C. (VI.13.7); Cratistene di Cirene, vincitore della corsa coi carri (VI.18.1). Per il figlio di Mnasea, Cratistene, Pitagora eseguì una quadriga bronzea; a Taranto in epoca romana esisteva ancora la sua pregiata Europa sul toro, celebrata da Varrone (De lingua latina V.31) e da Cicerone (In Verrem IV.60.135), vista anche da Taziano l’Assiro (Adversus Graecos 33); Siracusa possedeva un celebre Filottete ferito/zoppicante; non sappiamo dove sia stato posto un Perseo, ricordato retoricamente da Dione Crisostomo (Orat. XVII.10); l’unico simulacro divino di Pythagoras sembra esser stato quello di Apollo che uccide il Pitone, secondo la leggenda delfica: Plinio lo menziona senza dire ove fosse. Per dovere di cronaca bisogna dire che nessuna delle sue opere è oggi identificabile con sicurezza; solo possiamo vedere in lui un (eccelso) bronzista dello “stile Severo” peloponnesiaco; «da quanto possiamo intravedere nella tradizione, Pitagora Reggino fu uno dei poderosi innovatori che avviarono la scultura alla soluzione dei problemi di forma, per raggiungere il “grande stile” del V Sec. a.C.: egli realizzò nelle statue temi di movimento e d’espressione quali nell’età arcaica solamente la pittura o il rilievo avevano tentato» (M. Bieber in Thieme-Becker, Künstler-Lexikon, XXVII, Lipsia 1933, p. 481 e segg.).
Esule a Rhégion o nativo della città, Pythagoras era già certamente da un paio di decenni (496 a.C.) in Magna Grecia, quando Eschilo offrì al pubblico di Atene la propria versione del mito dei Sette contro Tebe (467 a.C.): il che in un certo senso “costringe” ad avvalorare l’ipotesi che lo scultore avesse attinto alla tradizione creata dal magnogreco Stesicoro.

LE TAPPE DEL GRUPPO STATUARIO DI PITAGORA REGGINO
Innanzitutto, la terra di fusione rinvenuta all’interno dei due celebri Bronzi oggi conservati al Museo di Reggio Calabria attesta in modo incontrovertibile che le opere furono realizzate nell’area di Argo, nel Peloponneso, dove Eteocle e Polinice venivano venerati nel mito fondativo. La prima prova, poi corroborata da successivi affinamenti e analisi, fu presentata nel novembre 1995 in un convegno all’Accademia dei Lincei a Roma (autori G. Lombardi e P.L. Bianchetti della Sapienza, M. Vidale dell’Istituto Centrale del Restauro, con la collaborazione di geologi greci). Il che spazza via buona parte delle altre teorie sull’origine dei Bronzi (attica, ateniese, “calabrese”, addirittura siciliana, etc.). Successivamente altri studiosi si sono spinti ad affermare che le terre di “A” e quelle di “B” erano state prese «da cave distanti appena duecento metri» — affermazione cui chi scrive reagisce con un’alzata di sopracciglio e un sorrisetto (ma immagino reagisca così lo stesso Castrizio).
Durante la guerra contro Mitridate, re del Ponto, e poi ancora nel corso della guerra civile tra Mario e Silla (entrambe nella prima metà del I Sec. a.C.), Argo e Atene vennero saccheggiate dai Romani, che portarono a Roma le opere d’arte più significative. Celebri anche le successive razzie di Lucio Mummio e Nerone.
La vittoria di Mummio distrusse sì Corinto, ma al tempo stesso portò via disordinatamente i bronzi da molte città della Grecia.
Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia” XXXIV.12-36
Durante l’edilità di Marco Scauro ci furono ben 3 mila statue sulla scena di un teatro provvisorio. Mummio, soggiogata la Grecia, ne riempì la città [di Roma]. Molte statue portarono anche i Luculli.
Come detto, secondo Castrizio è possibile che quando nel 92 d.C. il poeta Stazio scrisse la sua Tebaide avesse a mente (o vide coi propri occhi) una qualche testimonianza artistica trafugata in Grecia che faceva riferimento al Ciclo Tebano.
La “Statua B” ha un braccio interamente modificato e rifuso, probabilmente quattro o cinque secoli dopo la sua originaria realizzazione. Forse la statua fu modificata appositamente per assomigliare il più possibile alla “Statua A”, oppure accadde un danneggiamento di qualche altro tipo (una caduta). L’antico restauro coinvolse altri aggiustamenti (per es. alle labbra). Le analisi della terra contenuta nel braccio sostituito e della lega di rame utilizzata, inoltre, rivelarono che la sostituzione del braccio era avvenuta in un luogo diverso da quello della fabbricazione, probabilmente nella Grecia del nord oppure a Roma. Anche il “Bronzo A” subì interventi, ma di minor portata.
Riguardo al colore originario di queste due statue sappiamo che erano sicuramente policrome per la presenza di rame, argento, quarzo e pietra. Hanno particolari in altri materiali: labbra e capezzoli in rame, bulbi oculari in calcite e avorio; iride in pasta di vetro; caruncola lacrimale in pietra rosa. Quest’ultimo dettaglio è di rilievo, poiché soltanto nei due Bronzi e nel celebre Auriga di Delfi, fra le statue grecoantiche arrivate fino a noi, sono presenti caruncole lacrimali realizzate ad hoc. (Se si prova a fare una ricerca, il web è pieno della notizia “i Bronzi di Riace sono le uniche statue al mondo dotate di caruncola lacrimale”. Be’, è falso.)

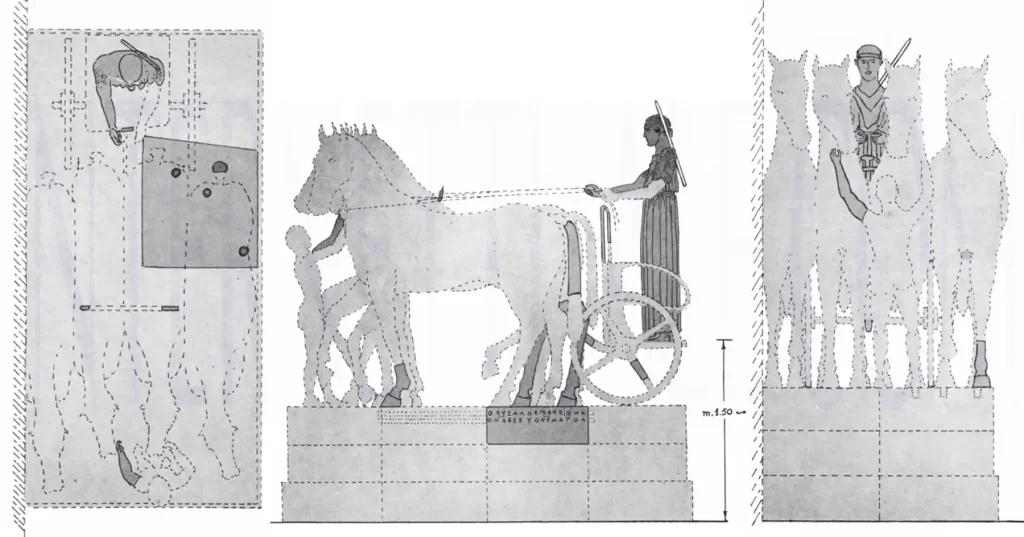
Considerando il colore simile a quello dell’elettro della lega di rame con una elevata quantità di stagno, si può ipotizzare che le due statue fossero rappresentate con i capelli biondi, mentre il corpo fu scurito mediante l’uso del “fegato di zolfo” (polisolfuro di potassio). Il “biondo” è il colore reso dal termine greco xanthos usato nelle fonti letterarie, che in latino è fulvus, quindi un biondo rossiccio. Fu probabilmente per mascherare le aggiunte e i difetti dell’antico restauro che i Bronzi furono ricoperti dallo strato di vernice allo zolfo, di cui è stata studiata la patina rimanente, che li rese simili ai bronzi di Corinto, di colore nero lucido.
Attorno al 165/170 d.C. il retore cristiano Taziano (Discorso ai Greci §33 e segg.) cita statue e gruppi statuari dell’arte greca come esempi dell’immoralità dei pagani; egli scrive che «peggiori dei loro costumi sono le produzioni artistiche dei Greci, fatte per smania di gloria» e fra gli altri cita — per denigrarlo — Pythagoras come scultore dei “fratricidi Ettore e Polinice”, affermando alla fine di aver visto tutte queste statue durante i suoi viaggi «nelle città dei Romani», al cui patrimonio culturale i Greci avevano contribuito.
Infatti non è difficile che il fratricidio sia tenuto in onore presso di voi, che, vedendo le statue di Polinice e di Eteocle, non distruggete il ricordo di quell’infamia, seppellendole con il loro autore Pitagora.
Taziano, “Adversus Graecos” 34 (trad. di A. De Franciscis)
Taziano conosceva anche l’Europa sul toro, altra opera di Pythagoras celebre nell’antichità. Quella del Siro è ritenuta la più preziosa testimonianza delle opere greche (o meglio: trafugate in Grecia!) effettivamente presenti a Roma e nelle altre città romane nell’antichità imperiale.
Per i restanti diciotto secoli, fino al ritrovamento in mare a Riace nel 1972, abbiamo il silenzio assoluto delle fonti. Disponiamo solo di una piccola, debole traccia di natura archeologica.
Si tratta di un frammento di una grossa parete di “pithos” tardoantica, ancora posta tra la mano destra e la coscia del “Bronzo A”, rilevata durante uno dei restauri alle statue: secondo Castrizio (ma teorizzato già da H. Weinstock, “Ein Torso in Brüssel und Riace B”, pagg. 85-86 in Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles LXIV, 1993), essa permette di ipotizzare un ultimo viaggio dei Bronzi, da Roma verso Costantinopoli, quando Costantino il Grande, agli inizi del IV Sec. d.C., trasferì nella nuova capitale dell’impero l’intera collezione di opere d’arte che si trovava a Roma. La testimonianza del trasloco sarebbe contenuta nel Libro II della celebre raccolta di epigrammi “Antologia Palatina”, dedicato alle statue dello Zeuxippos, il vasto ginnasio pubblico di Costantinopoli dotato di terme, costruite a partire dal 196 d.C. sotto Settimio Severo, dove forse anche i Bronzi erano destinati a essere esposti.
L’Antologia Palatina, in ogni caso, fu compilata a Bisanzio intorno alla metà del X Sec. e costituisce una copia arricchita della perduta antologia epigrammatica compilata da Costantino Cefala alcuni decenni prima (verosimilmente, fra l’880 e il 902): in ritardo di parecchi secoli sugli eventi in questione.
La ricostruzione del prof. Castrizio si conclude con un naufragio: in occasione dell’ultimo viaggio dei Bronzi da Roma verso Costantinopoli la nave oneraria che li trasportava, in prossimità del Porto di Kaulon/Kaulonia (oggi Porto Forticchio, in Località Agranci di Riace) venne investita da una mareggiata e andò a sbattere sulla diga foranea, disperdendo il suo carico.
* * * *
Fin qui la prima parte della “teoria Castrizio”, che ricostruisce in maniera convincente la nascita, il significato artistico e i primi secoli di vita delle due meravigliose opere bronzee. E che si ferma al particolare del naufragio per giustificarne la presenza nel fondale marino di fronte a Riace: le due statue rimangono sommerse per circa sedici secoli, finché nel 1972 vengono rinvenute dai sub.
L’ultimo libro del prof. Castrizio sul tema è disponibile qui.
In conclusione, Daniele Castrizio non “inventa” nulla (nel senso che non “tira fuori da zero” delle ipotesi originali: i Sette sono di Moreno, Pythagoras viene da Stucchi, l’ultimo viaggio Roma-Costantinopoli da Weinstock, etc.), eccezion fatta per la kynê, acutezza di sguardo che gli proviene dall’attività di insigne numismatico; però ha il merito di non dare nulla per scontato e, confidando nella propria cultura sterminata e multidisciplinare, spacca il classico capello in quattro sulle tesi di altri e giunge a un costrutto teorico che sta in piedi meglio di qualsiasi altro.
Un po’ come i giapponesi nel Novecento (e i cinesi oggi, meno bravi), che andavano all’estero a osservare le tecnologie nate in Occidente e una volta tornati a casa le rifacevano meglio.
LA SECONDA TEORIA: DAL MEDIOEVO A OGGI
È a questo punto che, per mio puro divertissement — ripeto, senza pretese —, si innesterebbe molto bene la seconda teoria, quella del prof. Giuseppe Roma.
Perché tanto per cominciare lascia assai perplessi il ragionamento che due statue del peso di ben 400 kg cadauna si adagino sul fondale marino “una accanto all’altra” nel corso di una tempesta e/o mareggiata (tale da causare il naufragio), in un tratto di mare già sferzato di suo da forti correnti, e per giunta a poche decine di metri dalla riva (quando non a riva, in funzione dell’epoca), zona in cui una nave da carico tale da poter trasportare le due pesantissime statue (e chissà cos’altro) avrebbe difficilmente potuto transitare.
Un carico prezioso che affonda o viene gettato in mare vicino alla terraferma (la profondità alla quale sono stati trovati i Bronzi era di appena sei metri) e non viene successivamente recuperato o dai probabili sopravvissuti o dall’armatore della nave — che plausibilmente è addirittura un imperatore? Quante possibilità ci sono che due statue gettate in acqua durante una tempesta vadano a posizionarsi a meno di mezzo metro l’una dall’altra (una distanza di gran lunga inferiore alla loro altezza) o, ancora, se si dà credito al naufragio, quante probabilità sussistono, per una nave che affonda e/o resta sospesa per la presenza di affioramenti rocciosi, che il carico (ammesso che trasportasse solo le due statue) si depositi in maniera così perfettamente ordinata, come si vede dal disegno?
Dal canto loro, i “230 metri” di distanza dalla battigia del 1972 sono da rivedere completamente in funzione dell’epoca. L’erosione costiera è continuata in seguito e continua ancora oggi su tutta la costa jonica reggina, come testimoniano le odierne carte dell’evoluzione della linea di costa anche nel tratto che interessa il territorio dell’attuale Comune di Riace. È certo, quindi, che la linea di costa nell’antichità fosse molto più avanzata rispetto all’attuale: forse la scogliera oggi sommersa era quasi a riva e addirittura emergente. (E magari è… ciò che resta del perduto porto di Kaulon/Kaulonia, stando alle ricostruzioni di Castrizio e di numerosi altri studiosi.)
La scogliera andrebbe accuratamente indagata. Ma non si è mai fatto.
Le statue giacevano sotto circa 6 metri di acqua, sotto uno strato di 1 metro di sabbia grossa di origine marina, ed erano posate su un livello di ghiaia fluviale, che a sua volta ricopriva un banco di sabbia fine spesso 1 metro e che il Lamboglia identifica come «un’antica spiaggia emersa, anteriore all’età storica».
Estrapolando dati noti, il calcolo del sollevamento del mare ci darebbe per il livello medio del Mediterraneo, nel periodo considerato, un innalzamento massimo di circa 3,50 m (1,50 mm per anno). Dall’analisi dei resti archeologici sappiamo peraltro con sufficiente sicurezza che l’innalzamento del mare calabrese è stato, fra l’età ellenistica e oggi, non di molto superiore a 1 metro (cfr. G. Schmiedt, Il livello antico del Mar Tirreno. Testimonianze e resti archeologici, Firenze 1972, specie pp. 212-214, e la parte quarta dello stesso volume: M. Caputo-L. Pieri, Innalzamento eustatico del livello marino nel Mediterraneo, pp. 307-316). Però tutto questo nulla ci dice sulle fondamenta dell’eventuale porto e sulla “organizzazione idrogeologica” del suo bacino di insediamento.

Immagine tratta da “Shoreline Evolutionary Trends Along Calabrian Coasts: Causes and Classification”, Giandomenico Foti, Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università della Calabria, scomparso nel 2018 all’età di 70 anni, Giuseppe Roma ha avuto il merito di affrontare il tema del luogo di rinvenimento delle due celebri sculture in maniera decisamente nuova, pubblicando nel 2007 un saggio (“I Bronzi di Riace. Alcune considerazioni”), sotto forma di articolo per la rivista “Ostraka”, che stabilisce un collegamento tra le due statue e il culto dei santi Cosma e Damiano, protettori di Riace. Una lettura, quella di Giuseppe Roma, che mette insieme archeologia, storia, storia del cristianesimo, etnoantropologia, tradizioni locali, geomorfologia: un approccio globale degno dei grandi studi classici. E che ha il pregio di rispondere a tutta una serie di quesiti che fino a lui erano rimasti senza risposta.
Il succo della teoria si può riassumere nel modo seguente.
I Bronzi sono stati rinvenuti nei pressi di una scogliera oggi non affiorante, identificata da sempre dalla popolazione locale come lo “Scoglio dei santi Cosma e Damiano” e meta, nel mese di maggio, di una processione durante la quale viene trasportato il reliquiario che si immerge nel mare: ne consegue che le due statue erano venerate fin dai tempi antichi dalla popolazione del luogo.
Molti studiosi ravvisano nei santi Cosma e Damiano il corrispettivo cristiano dei Dioscuri.
Càstore e Pollùce (o Polideuce), personaggi della mitologia greca, etrusca e romana, gemelli generati insieme con Elena dall’uovo di Leda, congiuntasi con Zeus trasformato in cigno, conosciuti soprattutto come i “Diòscuri” (Διὸς κοῦροι = figli di Zeus), erano considerati protettori dei naviganti nelle tempeste marine e sempre uniti nel compiere le loro gesta. Ognuno di essi, poi, aveva una specificità: Castore era domatore di cavalli, Polluce era valente nel pugilato — curiosamente, proprio come Eutimo di Locri, uno dei soggetti candidati a identificare uno dei Bronzi —. Notiamo, sempre a titolo di pura curiosità, l’assonanza del nome Pollùce/Polideuce (in greco antico: Πολυδεύκης,Polydéukēs) con “Polinice” (in greco antico: Πολυνείκης,Polyneikēs), uno dei due eroi identificati dal prof. Castrizio quali soggetti raffigurati dai Bronzi.
Anche nei luoghi di culto dei Dioscuri veniva praticata l’incubatio (usanza magico-religiosa che consiste nel dormire in un’area sacra allo scopo di sperimentare in sogno rivelazioni sul futuro — “oniromanzia” — oppure di ricevere cure o benedizioni di vario tipo). E i Dioscuri erano stati venerati, fino alla chiusura del tempio, nel Foro Romano, centro politico, giuridico, religioso ed economico di Roma, oltre che centro nevralgico dell’intera civiltà romana: lo stesso luogo in cui plausibilmente erano esposti i Bronzi “di Riace”, stando alla ricostruzione di Castrizio, in seno al più ampio gruppo scultoreo dei “Fratricidi” di Pitagora Reggino.
Nel sito romano di Carsulae in Umbria il ruolo svolto dai due templi dedicati a Castore e Polluce (ruolo associato alla salute e alle cure, si pensi alla vicina San Gemini), viene ereditato direttamente dai santi Cosma e Damiano, la cui chiesa sorge nei pressi del Foro stesso, eretta per volere di papa Felice IV (526–530) nel Foro Romano riadattando strutture appartenenti al tempio della Pace e del Divo Romolo. Nella lunetta sovrastante la porta d’ingresso del sito di Carsulae, in un bassorilievo altomedievale, ai lati di una croce greca si osservano due figure nimbate, probabilmente i santi Cosma e Damiano, che recano in mano due ampolle su cui compaiono due stelle: proprio i Dioscuri a volte vengono rappresentati sotto forma di stelle. Le due stelle, raffigurate sopra tre personaggi in barca, sono dipinte già su un amphoriskos beotico a figure nere della fine del V Sec. a.C. proveniente dal Kabirion di Tebe (altro punto di congiunzione con la “teoria Moreno/Castrizio”) e, quindi, anche con il significato di divinità protettrici dei marinai. A Taranto verso la fine del IV Sec. vengono emesse monete in oro con i Dioscuri sormontati da stelle: anche i santi Cosma e Damiano vengono festeggiati dai pescatori e dai marinai della borgata di Sferracavallo a Palermo come santi protettori delle loro attività in mare e, in Calabria, da Cariati, centro abitato sulla costa jonica cosentina, i pescatori si recano alla festa dei santi Cosma e Damiano a Taranto.
I due culti, pagano e cristiano, si incontrano significativamente anche nella Locride e sul territorio dell’attuale Comune di Riace. Narra la leggenda che nella battaglia presso il fiume Sagra tra locresi e crotoniati (la datazione oscilla tra il 560 e il 535 a.C.) l’intervento dei Dioscuri fu decisivo per le sorti dello scontro a favore dei locresi, che erano schierati in numero esiguo (diecimila uomini), contro le soverchianti forze dei crotoniati (centotrentamila soldati). Strabone tramanda che i locresi, grati per la vittoria, innalzarono altari ai Dioscuri nei pressi del luogo ove si era svolta la battaglia. Nella stessa Locri, in contrada Marasà, l’archeologo Paolo Orsi rinvenne il gruppo scultoreo dei Dioscuri che decoravano il fronte occidentale del tempio, anche se non si è stabilito con esattezza quale fosse la loro precisa collocazione (cfr. A. De Franciscis, “Il Santuario di Marasà in Locri Epizefiri. Il Tempio arcaico”, Napoli 1979). La diffusione del loro culto a Lavinio, nel Lazio, è stata ritenuta di sicura provenienza italiota e, secondo Heurgon (cfr. J. Heurgon, “La Magna Grecia e i santuari nel Lazio”, in “La Magna Grecia e Roma in età arcaica”, Atti dell’VIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 6-11 ottobre 1968, Napoli 1969, II.2), da Locri. Non vi è dubbio, quindi, che sul territorio della Locride il culto dei Dioscuri fosse molto sentito e praticato ed è lecito ipotizzare che, come altrove, con l’avvento del cristianesimo i santi Cosma e Damiano abbiano sostituito il primo culto. Non sappiamo esattamente quando ciò sia avvenuto, ma il periodo non dovrebbe essere anteriore, secondo il prof. Roma, al VI Sec. d.C..
Tra la Tarda Antichità e l’Alto Medioevo sono numerosi gli esempi di statue nascoste per essere sottratte alla distruzione che la cristianizzazione dei luoghi imponeva. Con il procedere della “sostituzione sincretistica” e con i templi trasformati in chiese, gli stessi pagani fecero tutti gli sforzi per salvare le statue, nascondendole nelle spelonche, nelle grotte, sotto qualche palmo di terra; cosicché in epoche recenti gli archeologi hanno portato alla luce delle vere e proprie “necropoli di statue” (per esempio a Cipro, a Benevento, a Capua).
La processione che da Riace Superiore si snoda fino allo Scoglio dei santi Cosma e Damiano, che si compie ogni anno nella seconda domenica di maggio (e la data convive con una seconda ricorrenza, quella “ufficiale cristiana” di fine settembre: perché due ricorrenze in un anno?), copre un percorso di 6 chilometri circa. Se fosse una cerimonia legata soltanto al mare, sarebbe più logico seguire un percorso più breve e andare sulla spiaggia di fronte alla strada che scende da Riace Superiore: invece si cerca l’area dove insiste la scogliera per immergere le sacre reliquie dei santi protettori, e tornarsene poi a Riace Superiore. Quello spazio evidentemente è considerato dalla comunità riacese un sito sacro in cui celebrare il rito, slegato dalla liturgia religiosa cristiana.
Nessuno, osserva Giuseppe Roma, si è mai chiesto se vi sia un rapporto tra la tradizione religiosa che in quello spazio si svolge e il contesto in cui sono stati rinvenuti i Bronzi. Costituiscono due episodi separati, o sono piuttosto due momenti di UN’UNICA TRADIZIONE, la cui memoria è andata persa, ma che hanno il medesimo significato? Se la persecuzione cristiana degli “idoli pagani” fu l’evento scatenante che condusse al seppellimento dei Bronzi di Riace, è probabile che l’impresa fu portata a termine senza violenza né traumi. Ossia, le statue non furono “prese e gettate” in mare ma la deposizione fu molto rispettosa e ordinata: si scelse un luogo riparato, facilmente identificabile per chi ne era al corrente, in attesa di tempi migliori per il recupero. (Tempi che non vennero più.) Quante possibilità ci sono, si chiede Giuseppe Roma, che due statue finite in acqua durante una tempesta vadano a posizionarsi una accanto all’altra a “40 cm di distanza” (F. Pallarès, “Relazione del prof. Nino Lamboglia sullo scavo archeologico sottomarino nelle acque di Riace dal 28 agosto al 4 settembre 1973. Giornale di scavo”, in RStudLig, 1974, 20)? In sostanza, appunto accanto alla scogliera ancor oggi conosciuta come “Scoglio dei santi Cosma e Damiano”, che all’epoca poteva persino essere affiorante — o appena sotto la superficie del mare (o ancora essere un porto) —. Il punto in cui sono state ritrovate nel 1972, insomma, e il cui ricordo era andato perso nell’oblio dei troppi secoli, tranne che per il particolare della processione di maggio.
L’ipotesi della nave naufragata, secondo il prof. Roma, al di là delle altre considerazioni non appare credibile per il fatto che non sia stata (ufficialmente) trovata alcuna traccia né del relitto della nave, né del carico o di sue parti. Si potrebbe obiettare che in un millennio e mezzo il mare ha potuto facilmente trascinare via qualsiasi cosa eccezion fatta per le uniche cose davvero pesanti (le due statue: quasi mezzo quintale ciascuna). Senonché c’è l’altra “nota stonata” del rilievo eseguito dal Lamboglia (N. Lamboglia, “Relazione sulla campagna di ricerche archeologiche sottomarine svolta nelle acque di Riace dal 28 agosto al 4 settembre 1972”, in Archivio Soprintendenza Archeologica per la Calabria, 1 — vd di nuovo figura qui sopra), secondo il quale le statue appaiono allineate, una accanto all’altra, adagiate in uno spazio ristretto circondato da affioramenti rocciosi. Aggiunge Giuseppe Roma: «come fosse una deposizione “sepolcrale”, ordinata. Il che rende del tutto improbabile la casualità della disposizione: furono messe lì di proposito, e in modo controllato». In accordo con l’occultamento dovuto alle persecuzioni cristiane.
Andò davvero così?

UNA SCOPERTA CONTROVERSA
Il ritrovamento del 1972, come si conviene a ogni scoperta archeologica di fama, è ammantato da un alone di leggenda e anche da qualche “mistero”. Il primo dei quali riguarda l’integrità: non è mai accaduto che un’antica statua bronzea o marmorea venga ritrovata intera (e in questo caso erano pure due), a parte piccolissimi dettagli come l’occhio mancante e il dito indice spezzato di “B”.
La storia moderna dei due Bronzi inizia il 16 agosto del 1972, quando, in seguito a una vicenda dai risvolti mai completamente chiariti, presso la località Porto Forticchio di Riace Marina furono ritrovate due statue in bronzo, apparentemente senza nessun reperto coevo nei dintorni. Il loro recupero fu eseguito con una imbarazzante leggerezza e con mezzi non appropriati, al punto che venne “dimenticato” sulla spiaggia un grosso pezzo di ceramica tardo antica, posto tra l’avambraccio destro e il bacino del “Bronzo A” per impedire che il braccio stesso potesse danneggiarsi durante il trasporto.

La località di ritrovamento, presso un antico porto mai studiato scientificamente ma che sembra esser stato attivo già dall’epoca greca, è altamente significativa. La sua funzione di porto è resa certa dalla presenza della Torre di Casamona, di epoca angioina, anche se datata erroneamente al XVI Sec., la cui funzione era quella di proteggere l’approdo e fungere da luogo di esazione delle tasse. Il ritrovamento delle due statue nei pressi del porto avvalora le teorie che mettono in relazione la presenza a Riace dei due Bronzi con il loro trasporto da o verso Roma. Altri particolari, come la presenza della ceramica per proteggere l’integrità della “Statua A”, sembrano attestare che le due opere erano in viaggio per essere esposte in un altro luogo.
Il giornalista d’inchiesta Giuseppe Braghò, autore di ben due libri sull’argomento (il più noto è “Facce di Bronzo” del 2007, con una ricca sezione documentale), ipotizza un vero e proprio furto con destrezza, molto hollywoodiano, che avrebbe privato l’Italia di almeno una terza statua, e di almeno un corredo completo di scudi, lance ed elmi. In base alle circostanziate ricostruzioni di Braghò, l’allora Soprintendente di Reggio Calabria (Giuseppe Foti) e lo scopritore ufficiale dei Bronzi, un sub romano (Stefano Mariottini), gestirono la scoperta e le successive fasi di recupero in modo da garantirsi il tempo sufficiente per fare sparire almeno un terzo bronzo e tutto il corredo; i veri scopritori sarebbero stati 4 ragazzi del posto, che malgrado una denuncia ai Carabinieri di Monasterace (e perfino una causa penale, conclusa nel ’77) vennero raggirati. La terza statua sarebbe negli USA, nei magazzini del Getty Museum di Malibu: sarebbe stato Paul Getty in persona ad acquisirla. Ulteriori reperti, poi, sarebbero in vario modo presenti in altri contesti USA, in parte finendo addirittura nello studio del presidente Bush sr., legato a doppio filo a Getty (interessi petroliferi).
Edit del 10 gennaio 2023 – Come segnalatomi direttamente dal giornalista, lui non ha mai detto che i «veri scopritori» sarebbero stati i 4 ragazzi, ma solo che la loro “irruzione” sulla scena, in quel 16 Agosto 1972, interruppe un traffico che stava avvenendo nel frattempo.
Fra la famiglia Getty e la Calabria c’erano del resto… “solidi collegamenti”.
Nell’estate successiva al ritrovamento dei Bronzi, Paul Getty III, nipote di John Paul Getty I, petroliere miliardario a capo della Getty Oil Company e uomo che era stato il più ricco al mondo (lo aveva nominato tale nel 1966 il Guinness dei Primati), venne rapito a Piazza Farnese a Roma. Fu un caso che per cinque mesi rimase sulle prime pagine di tutti i giornali italiani e culminò in un gesto macabro destinato a rimanere per molto tempo nell’immaginario comune: i rapitori tagliarono l’orecchio destro dell’ostaggio — che aveva 16 anni — e lo inviarono a un giornale per convincere la famiglia a pagare il riscatto (il plico arrivò con 28 giorni di ritardo a causa di uno sciopero delle poste).
La notte del 10 luglio 1973 il giovane Paul Getty non tornò a casa. Dopo due giorni sua madre ricevette una telefonata dai rapitori che le chiedevano 17 milioni di dollari per liberare suo figlio. Quando andò a denunciare il rapimento la polizia non le credette e non le credette nemmeno il nonno di Paul. Lei stessa raccontò che quando al telefono gli chiese di pagare il riscatto, John Paul Getty I le rispose: «Vai a cercare i soldi a Londra», dove all’epoca viveva il padre del giovane. Il vecchio Getty continuò a lungo a rifiutarsi di pagare. Disse che aveva 14 nipoti e che se avesse pagato «anche un solo penny» prima o poi sarebbero stati rapiti tutti. Era peraltro noto per l’avarizia leggendaria — non aveva esitato a far mettere un telefono a gettoni per gli ospiti in una sua magione londinese (testimoni Federico Zeri e Alvar González-Palacios), non accettava lettere con l’affrancatura a carico del destinatario e non aveva mai più di 25 dollari in tasca — ma anche per una smodata passione: il collezionismo d’arte antica, preferibilmente greca.
I rapitori chiamarono ancora molte volte la madre di Paul, abbassando continuamente la cifra richiesta. In qualche modo (anche grazie a una missiva sgrammaticata) vennero identificati come un gruppo di calabresi e si sospettò che fossero legati alla Ndrangheta. Vennero organizzate massicce operazioni di polizia sui monti della Sila, in Calabria, per cercare di localizzare il nascondiglio — chissà perché non si pensò mai di cercare più a sud, in Aspromonte —. Nel frattempo la richiesta di riscatto era stata abbassata a 3 milioni dollari. Il nonno decise di pagare: sborsò il massimo deducibile dalle tasse, ovvero 2,2 milioni; il resto lo mise John Paul Getty Jr. (padre di Paul e figlio del miliardario), che però si impegnò a restituire il danaro al padre con un interesse del 4%.
In dicembre, seguendo le indicazioni dei rapitori, un emissario lasciò tre sacchi contenenti il denaro in una zona vicino Rivello nel potentino; 72 ore dopo il ragazzo venne rilasciato e ritrovato da un camionista sulla Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Lauria. Era il 15 dicembre 1973 (compleanno del nonno). Il processo di primo grado si concluse nel 1976 con l’assoluzione dei principali indiziati: Girolamo “Mommo” Piromalli (ai vertici della mafia calabrese insieme a Antonio Macrì che controllava la Locride e a Domenico Tripodo che controllava la zona di Reggio Calabria) e Saverio Mammoliti, e con la condanna di altri due imputati in qualità di esecutori materiali del sequestro. In Corte di Appello, a Potenza, le pene vennero ridotte a tutti. Il denaro, a parte poche banconote, non fu mai ritrovato. Quando morì, nel 1976 a 83 anni, John Paul Getty I lasciò quasi tutti i suoi averi al Getty Museum di Malibu, da lui fondato due anni prima nell’elegante cittadina californiana alle porte di Los Angeles.
I depositi del Getty Museum sono inviolabili. Negli anni Ottanta-Novanta almeno una decina di persone ha invano provato a vederli: tutti respinti, dal celebre archeologo ed etruscologo Adriano La Regina a Giuseppe Proietti, allora ai vertici dei Beni Culturali, dall’ex sostituto procuratore Paolo Giorgio Ferri agli archeologi Daniela Rizzo e Maurizio Pellegrini, che ne hanno condiviso le indagini. Il Getty, pur dopo la restituzione al nostro Paese nel tempo di una sessantina di oggetti, conserva ancora almeno 350 reperti di provenienza italiana senza precise discendenze accertabili e dunque assai probabilmente frutto di scavi clandestini, acquistati da mercanti già sotto indagine, dagli anni Settanta in poi (uno risale al 1958). Come l’Atleta vittorioso (o “bronzo Getty”) attribuito a Lisippo, pescato al largo di Fano, ormai confiscato dall’Italia come ha stabilito una sentenza della Cassazione che il museo non intende onorare pur dopo vari processi.
Magari non ci sarà alcun nesso ma è molto curiosa la concatenazione ravvicinata delle date: nel 1972 sono ritrovati i due (solo due?) capolavori bronzei a Riace, nel 1973 la famiglia Getty ha a che fare con la mafia calabrese, nel 1974 John Paul Getty I (collezionista di capolavori artistici antichi) fonda in California quel Getty Museum che contiene centinaia di opere trafugate in Italia…
(C’è anche di più. A quanto si dice, “nonno” Getty, che non era intenzionato a pagare il riscatto, si convinse solo quando i rapitori — con la collaborazione/intercessione/supervisione di qualche boss mafioso locale — gli offrirono il “terzo bronzo”. Cioè Paul Getty usò i miliardi per riavere indietro il nipote con in più l’omaggio di una meravigliosa statua appena ripescata sull’altra costa calabrese…!)
Negli archivi della Soprintendenza di Reggio Calabria, «che nessun esterno ha mai visionato in 34 anni», è conservato il verbale di denuncia che attesta la presenza in mare di un «gruppo di statue» (non solo quindi la “coppia” che conosciamo). Tale verbale traccia il ritrovamento in un modo che non corrisponde a quanto effettivamente recuperato. Per prima cosa, si fa infatti cenno a una statua «con le braccia aperte e la gamba sopravanzante» (nessuno dei due celebri Bronzi sembra avere questo aspetto), e a un’altra «che presenta, sul braccio sinistro, uno scudo» (nessuno scudo è stato mai recuperato). Il verbale, nel racconto di Braghò (il quale, va detto, nel suo libro esibisce una gran quantità di prove fotografiche e fotostatiche), afferma poi che le statue «sono pulite e prive di “incrostazioni evidenti”»: dai filmati dei recuperi e dalle prime foto dei Carabinieri risultano invece piene di incrostazioni, poi eliminate nel corso del primo restauro a Firenze (1975/1980, a cura dell’Opificio delle Pietre Dure). Nei fantomatici carteggi ufficiali del 1972 ci sono infine altre stranezze e incongruenze, come il cenno a un elmo e la posizione che cambia di continuo da “supina” a “prona” a “su un fianco”. «Una statua di 400 kg non si gira su sé stessa con le correnti marine», conclude beffardamente il giornalista, protagonista di una annosa quanto infruttuosa battaglia presso uffici ministeriali, convegni e tribunali.

Peraltro, se vi recate a Riace Marina, vi può capitare di imbattervi in anziani del posto che raccontano aneddoti sorprendenti. Per esempio: il motivo per cui i due Bronzi sono stati ritrovati “tranquillamente adagiati uno accanto all’altro” non è una deposizione sepolcrale e neanche un liberarsene da parte di una nave in difficoltà. Erano lì e in quella posizione perché qualcuno stava tentando di rimorchiare le statue a riva, ma sul più bello sono rimaste incagliate fra gli scogli. Il gossip riguarda anche «4 motori di barca bruciati in stretta sequenza». Un po’ come quando si getta la lenza con la canna da pesca dalla spiaggia in una zona di mare pietrosa, e a un certo punto la canna si piega perché il vostro mulinello non riesce più a tirare amo e piombo (e pesce!) perché avete “roccato”, come si dice da queste parti…
(Prima con una antica nave romana a vela e schiavi rematori, poi con una moderna barca a motore: sarebbe il secondo incidente consecutivo dei Bronzi contro le strutture dell’antico porto!)

Se la vicenda raccontata dagli indigeni che ancora ricamano sugli eventi del 1972 (e ampiamente denunciata da Braghò) restituisce un fondo di verità, allora l’«assenza di tracce del relitto della nave e/o del carico e/o di sue parti» andrebbe quantomeno rivista: da qualche parte, su quel fondale, erano (sono ancora?) presenti sia il relitto che eventualmente altre statue. Pare siano stati effettuati anche degli studi ufficiali, con tanto di attrezzature supertecnologiche statunitensi, che hanno rilevato delle “anomalie metalliche” sugli stessi fondali del ritrovamento dei Bronzi. E dunque si sarebbe trattato effettivamente di un naufragio (del IV Sec.?), un trasloco finito male (e senza polizza assicurativa).

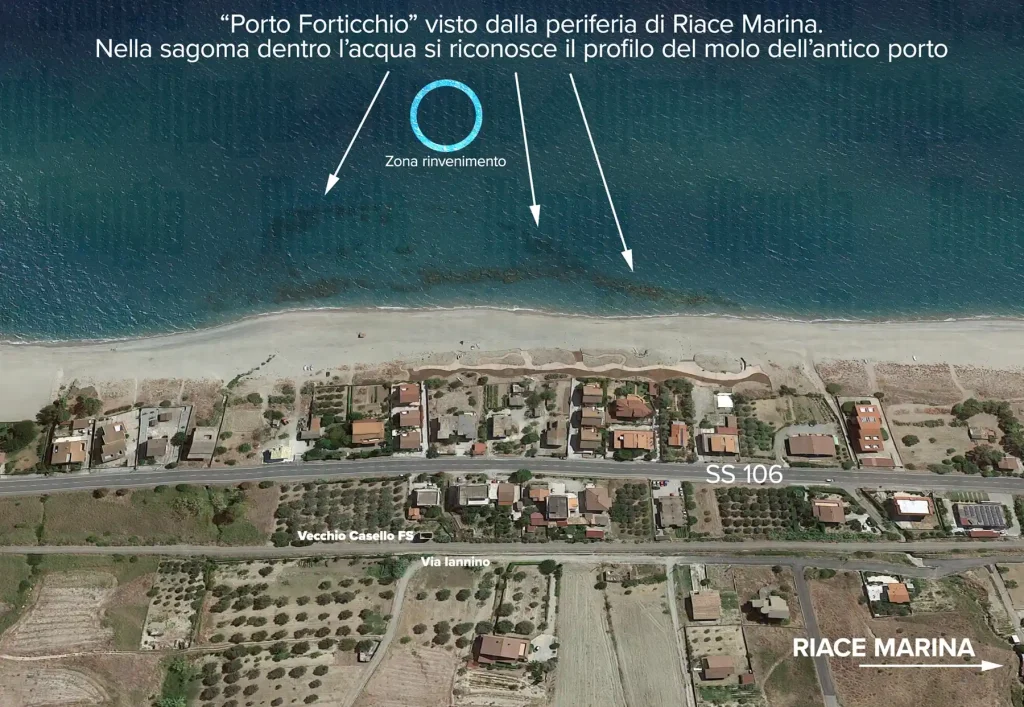

IL “BUCO”: COME ARRIVARONO A RIACE
Se però facciamo a meno del “naufragio”, resta da spiegare l’arrivo delle due statue (e solo di quelle due, rispetto a un gruppo scultoreo che è sospettato d’essere molto più ricco) nella Locride. Se erano ancora in una città romana nel 165/170 d.C., viste da Taziano l’Assiro, oppure nell’Argolide come dice Pausania (per almeno una di esse) negli stessi anni, come mai le ritroviamo “adorate” in qualità di Dioscuri a oltre 600 km di distanza, culto poi sostituito, come accaduto dappertutto a causa del Sincretismo cristiano, da quello di Cosma e Damiano?
Sulla vita di Cosma (o Cosimo) e Damiano non si hanno dati storici certi, le poche notizie disponibili si possono rintracciare soprattutto nei Martirologi e nei Sinassari. Teodoreto vescovo di Cirro — la fonte agiografica più antica — fa risalire la nascita dei due, definendoli «fratelli», alla seconda metà del III Sec. d.C. a Egea, dove esisteva un tempio di Asclepio, dio della medicina, presso il quale i sacerdoti praticavano cure mediche anche attraverso la pratica dell’incubatio. Nella sua “Legenda Aurea” Jacopo da Varagine narra quello che viene indicato come il primo trapianto della storia: un devoto con una gamba malridotta, avendo sognato i due santi che gli applicavano la gamba di uno schiavo etiope morto, si risvegliò con la gamba sana e di colore scuro.
Nati in Arabia, si dedicarono alla cura dei malati dopo aver studiato l’arte medica in Siria. Ma erano medici speciali: spinti da un’ispirazione superiore, infatti, non si facevano pagare — di qui il soprannome di anàrgiri (dal greco anargyroi, “senza argento”, ossia senza denaro) —. Ma questa attenzione ai malati era anche uno strumento efficacissimo di apostolato. Missione che finì per costare la vita ai due fratelli, che vennero martirizzati: durante il regno dell’imperatore Diocleziano, forse nel 303, il governatore romano li fece decapitare. Successe a Cirro, dalle parti di Antiochia in Siria; un’altra tradizione attesta invece che furono uccisi a Egea di Cilicia, in Asia Minore, per ordine del governatore Lisia, e poi traslati a Cirro.
Sulla loro tomba sorse una chiesa, meta di ininterrotti pellegrinaggi: uno dei più illustri pellegrini fu Giustiniano, il restauratore dell’Impero Romano d’Oriente. Guarito da una perniciosa malattia, andò in preghiera preso la tomba dei “santi taumaturghi”, promosse a basilica la loro chiesa e dispose la fortificazione della città di Cirro.
Il culto dei santi Cosma e Damiano iniziò subito dopo la loro uccisione. Il vescovo di Cirro, Teodoreto (morto nel 458), parla già della divisione delle loro reliquie, inviate alle numerose chiese già sorte in loro onore (a Gerusalemme, in Egitto, in Mesopotamia); il patriarca Proclo dedicò loro una basilica di Costantinopoli che scatenò altri pellegrinaggi. Rapidamente il culto si estese a tutto l’Oriente bizantino. Gli scambi commerciali che intercorrevano con Roma facilitarono la fama dei martiri gemelli anche in Occidente: la prima cappella in loro onore nella città eterna risale all’epoca di Papa Simmaco (498–515 d.C.). Poco tempo dopo (528 d.C.), a opera del citato Papa Felice IV, le loro reliquie furono spostate a Roma e fu edificata la grande basilica nel Foro.
La diffusione del culto in epoca posteriore (Secc. X–XIII) è attestata in Bulgaria, Romania e nelle regioni bizantine dell’Italia meridionale, tra cui la Calabria. In Toscana la famiglia Medici, intorno alla metà del ’400, li scelse come propri santi patroni contribuendo a determinarne e diffonderne l’iconografia attraverso opere commissionate a importanti artisti dell’epoca. Nella liturgia occidentale la festività dei SS. Cosma e Damiano è fissata al 27 settembre. A Brattirò di Drapia, un piccolo paese in provincia di Vibo Valentia, una grande festa religiosa e civile viene celebrata ogni anno e vede la partecipazione di migliaia di fedeli provenienti da tutta la Calabria, con processione il 27 settembre; pure Bivona, piccola frazione di Vibo Valentia, festeggia solennemente l’ultima domenica di settembre, mentre lì vicino, a Badia di Nicotera, la ricorrenza cade il 26. Anche nella citata comunità di Sferracavallo (PA) giochi, celebrazioni liturgiche e processione avvengono nell’ultima domenica di settembre. A Reggio Calabria si festeggia nella frazione di Bocale il 26 settembre. A San Cosmo Albanese (CS) la festa viene celebrata due volte: il 27 settembre e la seconda domenica di novembre. A Cittanova (RC) si festeggia la terza domenica di ottobre, mentre a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) i gemelli medici sono venerati la prima domenica di agosto. A Satriano (CZ) la ricorrenza cade nei giorni 26 e 27 settembre, e pare che il culto sia molto antico; la locale statua lignea risale al 1871, a opera di Nicola Drosi, famoso scultore locale il cui figlio, Pietro, scolpirà nel 1879 le statue tuttora presenti a Riace. Paese che vede ben due celebrazioni durante l’anno: quella comune agli altri luoghi, con una gran festa di tre giorni a settembre (25–27), e la già citata processione verso il mare della seconda domenica di maggio.

Una delle leggende di fondazione del Santuario di Riace tramanda che “un certo giorno di mille anni fa” un pastorello vide avvicinarsi due uomini che si presentarono dicendo di essere Cosimo e Damiano, due fratelli medici, quindi lo invitarono a lasciare il gregge per andare ad avvisare la gente di Stignano che due medici provenienti dall’Oriente volevano edificare una chiesa. Il pastorello obbedì, ma invece di andare a Stignano si fermò nel più vicino paese: Riace. Molti uomini lo seguirono, ma giunti là dove si era intrattenuto con i due fratelli, non trovarono nessuno. Il ragazzo non si perse d’animo e chiese agli uomini di aiutarlo a edificare la chiesa. Iniziarono la costruzione, lavorando fino al tramonto, ma al mattino successivo tutto era crollato, così dovettero iniziare daccapo: ma nuovamente, durante la notte, tutto andò giù. E così anche il terzo giorno. Durante la terza notte al pastorello apparvero in sogno i due santi medici che gli consigliarono di andare a prendere nel luogo in cui si erano incontrati una delle pietre su cui si erano seduti, e di inserirla nella costruzione. Seguite le indicazioni dei santi e collocata la pietra in un lato della costruzione, l’edificio di culto non crollo più.
I festeggiamenti nel Santuario si fanno risalire al 1669, quando le reliquie di san Cosma furono portate da Roma, ma Cosimo e Damiano furono istituiti Santi Patroni di Riace solo nel 1734. I santi vengono festeggiati due volte l’anno secondo modalità differente. La “festa di maggio” — anche detta “festa del Braccio” — coinvolge soprattutto la comunità riacese (l’altra un gran numero di persone dai centri vicini). Ogni anno, la seconda domenica di maggio, a ricordo di quanto accaduto al pastorello, le reliquie dei Santi vengono portate in processione al “castedu”. Una teca d’argento a forma di braccio viene trasportata lungo un itinerario campestre attraverso i sentieri della campagna di Riace, dalla Chiesa Matrice fino a raggiunge la spiaggia di Riace Marina. Una volta giunti sulla spiaggia, la teca viene imbarcata e portata nei pressi dello scoglio dove l’agiografia cristiana racconta che sia rimasta l’impronta del piede di San Cosimo/Cosma, dopo la traversata a nuoto dall’Arabia (probabile origine della protezione di marinai e pescatori).
Non è chiarissima l’origine di questo “braccio” (la teca d’argento con la reliquia è a forma di braccio), tuttavia a puro titolo di curiosità ricordiamo che i due Bronzi furono entrambi oggetto di un poderoso restauro (intorno al I/II Sec. d.C.) che riguardò proprio le braccia.
Eteocle e Polinice: fratelli figli di re che finiscono per uccidersi a vicenda. Castore e Polluce, gemelli figli di Zeus, dèi protettori dei marinai. Cosma e Damiano, gemelli, medici, santi protettori dei medici e dei farmacisti, ma in alcune zone anche di marinai e pescatori… Difficile districarsi alla ricerca dei punti di contatto, oltre al fattore fratellanza: la prima e la seconda coppia, una semi-mitologica e l’altra leggendaria, sono di origini greche, la terza è araba; la gemellanza e la protezione dei marinai riguardano la seconda e la terza coppia, ma non la prima (sul web non di rado si trova la notizia — infondata, poiché nessuna fonte antica lo attesta — che Eteocle e Polinice fossero gemelli)…
Possibile però che la “coincidenza” della scogliera di Cosma e Damiano con il luogo di ritrovamento dei Bronzi sia da imputare proprio alla presenza dell’antico porto: sarebbe così il perduto porto di Kaulon, il vero denominatore comune fra i santi cristiani gemelli (protettori di marinai), i Dioscuri (ugualmente protettori di marinai) e i Bronzi di Riace (arrivati via mare), con buona pace della parte della seconda teoria del prof. Roma in cui si ipotizza un «ordinato seppellimento in mare». Anche perché l’antica ceramica ancora presente fra il braccio e la coscia della “Statua A” depone a favore di un trasporto, allontanando l’ipotesi dell’occultamento da parte della popolazione autoctona: la pithos era un pezzo dell’imballo — una sorta di polistirolo degli antichi.
In altre parole…
Nel IV Sec. una nave che trasporta sculture da Roma a Costantinopoli naufraga davanti al Porto di Kaulon (situato a poche decine di metri a nord dell’odierna Riace Marina); la gente del posto già da molto tempo venera i Dioscuri, e il loro luogo sacro è esattamente quello stesso porto, essendo le due divinità protettrici delle attività marine; a causa del Sincretismo cristiano alto-medievale, il culto di Castore e Polluce (due gemelli) dopo il V/VI Sec. viene quasi automaticamente sostituito dalla venerazione dei santi cristiani Cosma e Damiano (ancora due fratelli), senza soluzione di continuità per quanto riguarda i riti: si finisce sempre al porto. Con i secoli, si perde memoria degli eventi, ma non la forma: ancora oggi la prima processione annuale, slegata dalla liturgia ufficiale cristiana, scende sempre nello stesso posto, anche se nessuno può più sapere perché (si è perso il ricordo anche del porto).
Non ci sarebbe dunque alcun legame fra i Bronzi e la popolazione con i suoi riti e miti. È sempre colpa delle tre dispettose sorellacce Cloto, Làchesis e Àtropos: hanno piazzato lì, esattamente nel punto focale della processione, a pochi metri di profondità, due perfetti totem per dare concretezza alla venerazione… e nessuno dei riacesi in tutti questi secoli ne è mai stato consapevole. Può esistere una beffa più potente e canzonatoria di questa?
Certo, resterebbe da spiegare la stranezza della vicinanza delle due statue sul fondo marino. Tuttavia, come si è visto, ci sono pesanti indizi sul fatto che quella non fosse la sede in cui i Bronzi avevano trascorso i loro secoli sott’acqua: qualcuno, nelle ore precedenti, forse aveva tentato un primo recupero trascinando verso riva le statue alla bell’e meglio. Con l’unico risultato di rompere l’indice del “Bronzo B” e fondere più di un motore di barca…
Lo Jonio reggino e magnogreco è un mare ricco di sorprese, un autentico “paradiso degli archeologi” (in gran parte inesplorato, comunque) che negli anni ha restituito celebrità assolute come i Bronzi di Riace, misteriose figure in pietra come le “facce” di Capo Bruzzano (probabili falsi, o comunque raffigurazioni di santi trafugate da decorazioni edilizie, come in questo caso di cui sono stato testimone oculare insieme alla mia compagna), altri reperti di arte antica, e che nasconde ancora chissà quante meraviglie inattese.
Per esempio, il favoleggiato “cavallo alato”, forse sempre in bronzo: un ritrovamento del genere farebbe passare in second’ordine perfino due opere come Eteocle e Polinice.

LA VILLA ROMANA DI CASIGNANA È IL TRAIT D’UNION?
Più o meno nella stessa zona, leggermente più a sud, lungo l’assolata Statale 106 che da Reggio risale la costa jonica calabrese, in piena Locride, si incontra la Villa Romana di Casignana, un’area archeologica incredibilmente preziosa. La residenza ritrovata nei pressi nel piccolo centro della provincia reggina, davanti a uno splendido mare e lontana da mete turistiche rinomate, è il secondo sito archeologico di epoca romana del Sud Italia per importanza dopo Piazza Armerina, per la stupefacente bellezza dei suoi mosaici.
Copre un’area di circa 8.000 mq: un vero e proprio parco delle meraviglie che si estende ai due lati della SS 106, sul versante mare e in direzione monte, oggi aperto al pubblico. Sono circa venti gli ambienti fino a ora rinvenuti, che si sviluppano intorno a un cortile centrale; sono stati individuati quelli che un tempo dovevano essere le terme, un giardino decorato con una fontana monumentale, le latrine, altri vani di servizio e la zona residenziale.
Nel 1963 lavori infrastrutturali della statale tra Locri e Reggio Calabria portarono alla luce i primi resti, e successivi scavi fecero emergere il nucleo di una lussuosa dimora risalente al I Sec. d.C.. Edificata in un’area già frequentata nel periodo greco, in quella che era una importante via di comunicazione tra Rhégion e Lokroi Epizephyrioi, si sviluppò ampiamente durante la dominazione romana, fino a quando, nel V Sec. d.C., non fu abbandonata.
Certo, definire “villa” una residenza di queste dimensioni è un po’ riduttivo: era una vera e propria città, estesa per circa 12 ettari; attorno a essa si era sviluppata anche una statio, cioè un centro di sosta per i funzionari della burocrazia imperiale che viaggiavano da Locri a Reggio.
Non sappiamo chi ne fosse il proprietario originario, né quanti altri ne ebbe eventualmente nel tempo: nella Villa non è stata rinvenuta nemmeno un’iscrizione. Molto probabilmente dovette inizialmente trattarsi di un senatore, forse un membro della famiglia imperiale, a giudicare dalla straordinaria qualità delle decorazioni che sono affiorate dal sottosuolo: mosaici policromi e marmi preziosi che rivestono i pavimenti di ambienti un tempo affacciati sul mare.
Sappiamo però che da sempre la località dove sorge l’area archeologica è denominata “Palazzi”: toponimo senza dubbio legato alla presenza grandiosa delle costruzioni greco-romane di quest’area, tra le quali la Villa. Secondo l’archeologo Emilio Barillaro, a un personale “Casinius” o a una gentilizia “gens Casinia” fa capo la voce toponomastica “Casiniana” (villa o fattoria di un casinius), da cui l’odierna Casignana.
L’odierno Bruzzano Zeffirio, piccolo comune adiacente all’antico Zephyrion Acra (Capo Zefirio, oggi Capo Bruzzano: da Zéphyros, nome del vento di ponente conosciuto già nell’antichità da Omero, Esiodo e Ovidio), ha origini molto antiche. Città fondata da coloni greci, costretti in seguito da una carestia o dall’esiguità di risorse a un destino di emigrazione (già allora!): una parte della popolazione si spostò all’interno per fondare Bruzzano, una seconda parte andò in direzione del litorale per fondare Locri “Zefiria”, proprio in contrada Palazzi, e da là nel VII Sec. a.C. un terzo troncone si spostò pochi chilometri più a nord per fondare la celeberrima Locri “Epizefirii”. È perciò possibile che i Romani si insediarono in un sito greco preesistente.
Ma c’è di più.
Nel 1987 alcuni giornalisti, tra i quali Antonio Delfino su Gazzetta del Sud, Aldo Varano su l’Unità e Giuseppe Zaccaria su La Stampa, mettono in guardia le autorità calabresi contro “i predatori del cavallo alato”.
«Qualcuno ha fatto sapere che lì, alla foce del Bonamico, da tempo c’era chi saccheggiava un patrimonio enorme», scrive Giuseppe Zaccaria su La Stampa del 2 aprile del 1987. Otto giorni dopo Antonio Delfino su Gazzetta del Sud si spinge oltre con una storia molto interessante: «Il 4 settembre 1974 Giovanni Carlino (20 anni) andò nel tratto di mare di Contrada Palazzi di Casignana con un amico a praticare la pesca subacquea; dopo la prima immersione uscì sconvolto dicendo all’amico: “Ho visto interi palazzi sommersi e delle cose meravigliose”». Giovanni Carlino rivela anche di aver riconosciuto un CAVALLO ALATO insabbiato nel fondale marino e, nonostante accusi un leggero malore, si immerge di nuovo. Colpito da embolia e trasportato prima a Locri e poi a Taranto, muore 5 giorni dopo. È un’epoca di… archeo-euforia: i Bronzi di Riace sono stati ritrovati da due anni, gli Indiana Jones evidentemente si scatenano alla ricerca di altri tesori nelle stesse località e in quelle attigue.
Del resto, erano state già diverse le immersioni e gli scavi nella zona di Casignana (sono accertate almeno 2 necropoli): dal maggiore inglese della RAF che, in volo sulla foce del Bonamico durante un duello aereo contro un Messerschmitt tedesco, riesce a distinguere a pelo d’acqua il “cavallo alato” (vi fa ritorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si immerge ma non trova nulla), a numerosi studiosi tedeschi.
Scrive sempre Delfino nel 1987: «Negli ultimi anni pescherecci siciliani hanno rastrellato la zona, mentre un vasto commercio d’anfore si svolgeva liberamente senza l’intervento di alcuno. Una preziosa statuetta bronzea, anni fa, fu venduta per poche migliaia di lire».
Già Paolo Orsi, l’archeologo scopritore della Locri antica, appuntava nel 1909 che gli era stato riferito dell’esistenza del porto di Locri in Contrada Palazzi, verosimilmente in prossimità del fiume Bonamico. Ma come pronosticato da Aldo Varano su l’Unità (1 aprile 1987), la sovrintendenza lavora solo per qualche settimana, senza coordinate precise e fin quando durano i finanziamenti a disposizione: «Tutto il resto è in mano agli abusivi, compresi quelli stranieri».
La Procura di Reggio Calabria (sostituto procuratore Fulvio Rizzo) torna allora a interessarsi del tratto di mare che va dai resti di epoca imperiale di Casignana alla foce del Bonamico. E blocca il lavoro dei sommozzatori, anche se nel frattempo circola la notizia dell’individuazione di tratti di muri che proseguono in mare continuando il percorso di quelli della Villa Romana. Il sostituto Rizzo dichiara di esser certo che nella zona ci siano inestimabili tesori archeologici e si dimostra sicuro anche dell’esistenza di complesse strutture sommerse.
Ma finisce lì. Sono già passati oltre tre decenni, e da allora nessuno si è più interessato a questo potenziale patrimonio sommerso. Eppure quando visitate la Villa Romana di Casignana, le guide che vi accompagnano accennano a un imperatore romano “a riposo” da quelle parti (il che spiegherebbe l’enormità del sito, tuttora al 90% inesplorato) e raccontano con disinvoltura che i muri sepolti a terra e sott’acqua restituiscono una mappa più estesa della stessa Locri. Ma la cosa più sorprendente è che nessun testo antico faccia il minimo cenno a un sito del genere.
Alla luce di tutto questo bendidìo di misteri, la butto là: esiste un legame fra i Bronzi di Riace (e forse pure il “cavallo alato”) e la Villa Romana di Casignana? È così peregrino indagare in questa direzione, per scoprire magari che i due Bronzi arrivarono inizialmente da Roma proprio al seguito della “gens Casinia”, ovvero gli occupanti della Villa, e non attraverso il controverso (almeno, fino a oggi) naufragio di una nave diretta a Costantinopoli? Per poi giungere infine e per chissà quale motivo là vicino, a Riace (seguendo la linea costiera si tratta di appena 45 km), dal momento che la Villa risulta del tutto abbandonata attorno al V Sec. d.C.?

Certo, poi torneremmo punto e a capo: perché finirono in mare? Stavano esposte nel porto e ci fu un terremoto? Ma il punto della mia provocazione è un altro. Con molto meno materiale storico a disposizione, in altre parti del mondo si riescono a creare incredibili flussi di turismo. Si veda l’esempio del minuscolo villaggio francese di Rennes-le-Château, appollaiato in vetta a una collina a una quarantina di chilometri da Carcassonne, nella regione francese dell’Aude: pur contando solo una manciata di abitanti, il paesino ogni anno è meta di migliaia di amanti del mistero e cercatori di tesori, attirati sul luogo da un corpus leggendario creatosi dal sovrapporsi di tematiche provenienti da ambienti culturali molto diversi ma in gran parte esoterici e di pura fantasia (il mitologico “Priorato di Sion” e la bubbola della “discendenza di Gesù”, con tanto di documenti cartacei falsificati ad arte). Perché qui in Calabria, disponendo di millenni di storia e di un patrimonio archeologico di tutto rispetto (e affatto fantastico!), non siamo capaci di mettere in piedi una “narrazione” che sappia ugualmente attirare frotte di turisti?

EDIT - LUGLIO 2022 / NEL CINQUANTENARIO DELLA SCOPERTA
Lo… stato dell’arte (è il caso di dirlo)
I punti fermi di ciò che a oggi sappiamo
Aggiorno il blogpost a 50 anni dalla scoperta dei due magnifici Bronzi nei fondali costieri di Riace. Nel frattempo, l’ipotesi “Eteocle/Polinice” del prof. Daniele Castrizio è diventata largamente accettata in ambito accademico e mediatico, tanto da essere inserita sul sito ufficiale del Museo Archeologico di Reggio Calabria. E dunque, se così si può dire (si parva licet), a quanto pare a suo tempo avevo scommesso sul cavallo vincente. Sebbene, come vedremo, tanto per rimanere nel “frasifattismo”, non è tutto oro quel che riluce: anch’io ho studiato un bel po’, da allora…
(E purtroppo, sempre nello stesso periodo, oltre ad aver sofferto di una storica pandemia mondiale, ci siamo pure persi le grandi figure di Paolo Moreno e Carlo Odo Pavese, voci di primissimo piano della ricerca sui Bronzi. Due udinesi appassionati al tesoro archeologico calabrese: a dimostrazione di come la cultura sappia abbattere barriere e campanilismi meglio di qualsiasi politica.)
Sono stati altresì fissati dei “canoni”, grazie anche alle ultime analisi effettuate sulle due opere, che è utile riassumere qui di seguito. Traggo tali punti fermi dal testo degli Atti del Convegno Internazionale di Studi Reggio Calabria-Messina (RC, 25-26 ottobre 2018), citando l’intervento di Ludovico Rebaudo, professore associato di Archeologia greca, Storia dell’arte antica, Archeologia greca e romana all’Università di Udine.
Nel mondo antico le opere perdute sono molto più numerose di quelle conservate, o anche semplicemente menzionate, dunque le probabilità di cogliere nel segno sono poche. Basterebbe ricordare il caso della razzia neroniana a Delfi, quando secondo Pausania furono portate via cinquecento statue di bronzo, sia di dèi che di uomini: durante la sua visita un secolo dopo Pausania ne vide molte meno.
Pare, che dapprincipio il tempio di Delfo fosse da molte genti insidiato. Questo ladrone Euboese, e negli anni seguenti la nazione de’ Flegj, ed inoltre Pirro di Achille lo assalirono; e una porzione dell’armata di Serse, e quelli, che per più tempo specialmente le ricchezze del Dio invasero, i potenti de’ Focesi; e l’esercito de’ Galli. E non dovea essere esente da quel disprezzo, che per tutte le cose Nerone mostrava, il quale tolse ad Apollo cinquecento statue di bronzo di Iddii, e di uomini.
Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” X.7.1
L’identificazione di una scultura giunta fino a noi con un monumento noto per via letteraria non è che l’associazione di due elementi selezionati dal caso all’interno di un insieme di grandezza ignota, cosa che da un punto di vista statistico è priva di senso. Allo stesso modo, quando attribuiamo una statua ai pochi maestri conosciuti — sempre gli stessi —, ci comportiamo come se i numerosissimi artisti di cui sappiamo il nome ma non abbiamo opere, e quelli forse ancora più numerosi di cui è andato perduto anche il nome, non fossero mai esistiti. Dunque il solo modo di affrontare il problema è combinare le evidenze archeologiche e i risultati delle indagini diagnostiche in modo tale che ciascun gruppo di dati contribuisca a delimitare il perimetro di interpretazione dell’altro. Archeologia e archeometria forniscono dei punti fermi da cui il discorso deve partire.
I punti fermi emersi dalle indagini diagnostiche:
- le terre di fusione provengono dallo stesso bacino geologico ma da microambienti diversi;
• gli alti valori di cromo nelle terre di entrambi i nuclei collegano i Bronzi alla Grecia continentale, dove l’elemento è presente in grandi quantità;
• la sostanziale identità nelle percentuali di ossidi e di metalli delle terre rare dimostra che le terre provengono dallo stesso bacino geologico, cioè dalla medesima regione;
• le differenze strutturali e composizionali fra le argille, che nella “Statua A” hanno una matrice carbonatica con frammenti grossolani di quarzo e granitoidi, nella “Statua B” una pasta scura di matrice argillosa fine con pochi cristalli di quarzo e piccole lamelle micacee, escludono la provenienza dallo stesso microambiente, cioè dallo stesso giacimento.
Fra le aree di provenienza sono da escludere la Sicilia, la Magna Grecia, le isole egee, la Grecia settentrionale, Olimpia e Corinto: in tutte queste regioni la composizione chimica dei suoli è diversa. L’Attica non può essere esclusa, ma è poco probabile. I candidati più plausibili sono, allo stato attuale, l’Argolide, specialmente la piana orientale di Argo, e la Megaride, anche se la corrispondenza chimica non è perfetta neppure in questi casi. Peraltro la compatibilità chimica è valutata sulla base delle carte geologiche, in quanto la campionatura dei suoli delle località interessate non è mai stata effettuata. Sussiste quindi un margine di indeterminatezza, seppur residuo.
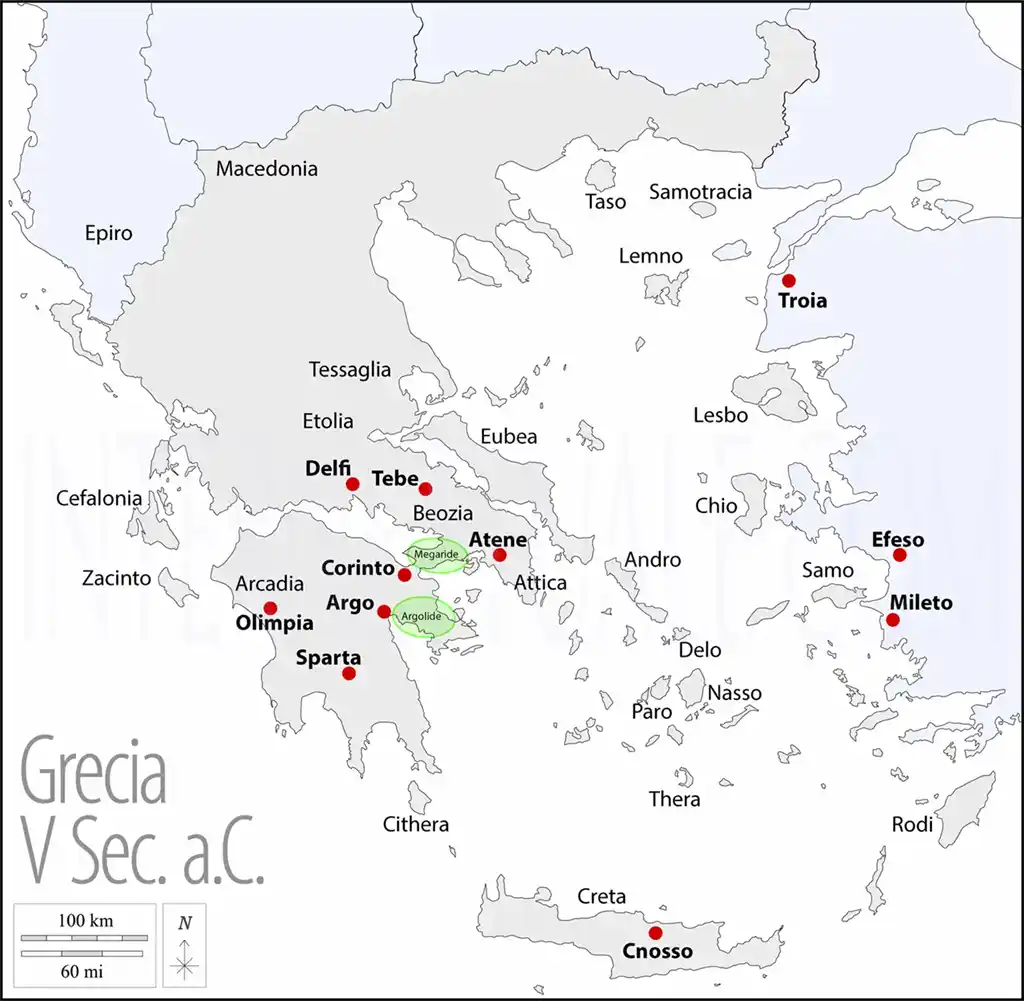
- il rame utilizzato nelle leghe di fusione proviene dal bacino del Mediterraneo, ma da regioni molto lontane fra loro. Una decina di frammenti di bronzo prelevati durante lo scavo del 1993–1996 è stata analizzata dal punto di vista chimico e tessiturale dal gruppo di ricerca di archeometallurgia dell’Università di Padova nel 2015. Per quanto riguarda il rame, i rapporti isotopici del piombo in traccia, indagati con il metodo della spettrometria di massa a plasma accoppiato (MC-ICPMS) grazie al quale è possibile individuare la provenienza dei minerali da cui il rame è stato ricavato, mostrano che il metallo del “Bronzo A” proviene dall’area egea, probabilmente da un giacimento cipriota, mentre quello del “Bronzo B” da miniere occidentali, localizzate in Sardegna o, in alternativa, nella penisola iberica. In termini archeologici ciò significa che le reti di fornitura delle officine erano diverse, o lo sono state in questo caso. Quella del “Bronzo A” faceva capo al sistema di rotte e approdi provenienti dall’Egeo orientale (convenzionalmente “levantino”), quella del “Bronzo B” al circuito tirrenico e del Mediterraneo occidentale (convenzionalmente “punico”).
- il piombo dei tenoni di fissaggio alle basi proviene dallo stesso giacimento. Due frammenti dei tenoni in piombo rimossi nel 1980 (e oggi colpevolmente non esposti al Museo che ospita i Bronzi: pare giacciano abbandonati in scatoloni nei sotterranei — ndr) sono stati sottoposti all’esame degli isotopi assieme ai campioni di lega di bronzo. L’analisi ha dato esiti completamente diversi. È risultato infatti che il piombo è in entrambe le statue identico e proviene dallo stesso giacimento, identificato con certezza nelle miniere del Laurion, in Attica sud-orientale. Il piombo, notoriamente un prodotto di risulta della raffinazione dei minerali argentiferi, costituiva una voce importante per l’economia ateniese: quello del Laurion era esportato in grandi quantità in tutti gli insediamenti greci del Mediterraneo dal IV Sec. a.C., ma il suo utilizzo è attestato già dalla piena Età del Bronzo.
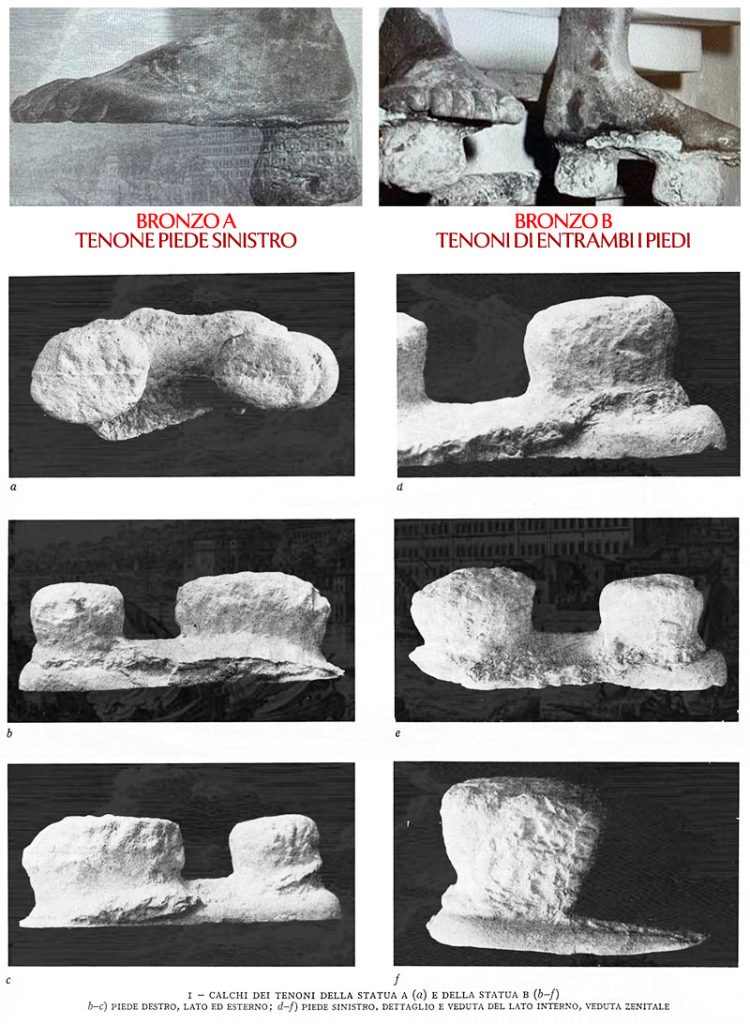

- la datazione mediante Carbonio 14 delle componenti organiche dei nuclei colloca l’esecuzione delle statue nel V Sec. a.C., senza possibilità di ulteriori raffinamenti. Nel 2010 e nel 2012 l’équipe del Centre for Dating and Diagnostics dell’Università del Salento (CEDAD) ha analizzato un numero significativo di campioni prelevati nel 1996 per datare con il metodo del 14C le componenti organiche incluse. Il range cronologico calibrato che ne risulta corrisponde con probabilità del 95,4% al 511–400 a.C. per il “Bronzo A” e al 512–398 a.C. per il “Bronzo B”. L’ampia estensione dipende dal fatto che i Bronzi cadono all’interno di un periodo (760–420 a.C.) in cui la curva di calibrazione presenta un profilo piatto, il cd. Plateau di Hallstatt, che non consente datazioni più precise. È però significativo che i due range coincidano praticamente ad annum. Ciò aumenta le probabilità che il punto di inserimento nella curva sia per entrambi lo stesso.
Chiosa del redattore
“Plateau di Halstatt” è un termine usato in archeologia che si riferisce a un’area costantemente piatta sui grafici che tracciano le datazioni al radiocarbonio rispetto alle date del calendario. Prende il nome dal periodo della Cultura di Hallstatt in Europa centrale con cui coincide.
Le date al radiocarbonio di circa 2450 BP (Before Present) sono sempre calibrate a circa 800–400 a.C., senza poter individuare l’anno o il decennio nell’intervallo, indipendentemente dalla precisione della misurazione. Il metodo di datazione al Carbonio 14 è dunque impedito da questo grande “piattume” sulla curva di calibrazione in un periodo critico dello sviluppo tecnologico umano. Nelle date prima e dopo il plateau, la calibrazione è accurata; durante il plateau solo una tecnica chiamata “wiggle matching” può produrre date utili per il calendario.
«La conclusione immediata è che è impossibile risolvere in modo sensato le date al radiocarbonio di qualsiasi campione la cui vera età sia compresa tra il 400 e l’800 a.C.. Si tratta di una catastrofe per l’archeologia della tarda età del bronzo/età del ferro, sebbene sia stata prevista da tempo» (Peter James, archeologo).
Il “wiggle matching” (corrispondenza dell’oscillazione) consiste nel prendere una serie di date al radiocarbonio in cui le conoscenze pregresse sulle vere date di calendario dei campioni possono essere espresse come differenze di età note tra i campioni stessi, o occasionalmente come differenze di età con una piccola incertezza. La serie di date al radiocarbonio può quindi essere abbinata alla curva di calibrazione per fornire una stima relativamente precisa dell’età. Quando i risultati vengono tracciati su un grafico, le “oscillazioni” nella sequenza di date al radiocarbonio dei campioni corrispondono alle “ondulazioni” nella curva di calibrazione — da qui il nome.
Questo “wiggle matching” per i Bronzi non è stato fatto. Ai comuni mortali non è dato sapere perché.
I Bronzi presentano anche differenze tecnico-esecutive non trascurabili:
- Le argille del “Bronzo A” sono state “smagrite”, cioè rese meno fluide, con l’aggiunta di pelo animale, in gran parte lana ovina. Quelle del “Bronzo B”, invece, con elementi vegetali, prevalentemente foglie, paglia e piccole scaglie lignee.
- Il nucleo del “Bronzo A” ha una superficie esterna priva di volumetrie e la modellazione anatomica è stata limitata alle cere. Il nucleo del “Bronzo B” presenta, soprattutto nella parte anteriore delle gambe, un modellato sommario ma riconoscibile, ottenuto rifilando gli strati di terra più esterni con uno strumento tagliente che ne ha asportato la superficie.
- Il getto del “Bronzo A” è tecnicamente migliore di quello del “Bronzo B”. Il numero degli affioramenti gassosi accertati, e dei relativi tasselli di risarcitura, è definito «irrilevante» su tutta la superficie. Il “Bronzo B” ne presenta invece un numero «altissimo» nel settore busto-gambe, con particolare densità nella gamba destra e lungo la fascia inguinale della gamba sinistra, specialmente sulla parte esterna della natica.
- Nel braccio sinistro del “Bronzo A” il metodo di brasatura standard “a fascia continua”, ovvero con il saldante colato nella fessura fra le parti da unire, è stato sostituito da quello “a pozzetti collegati”, in cui il saldante è colato in piccole vasche scavate sulla superficie esterna, a cavallo della linea di giuntura. Questa tecnica, di esecuzione complessa, richiede una rifinitura accurata ma produce un giunto più resistente.
- La testa del “Bronzo A” è fusa in un solo getto. I capelli sono modellati anche nelle parti nascoste dall’elmo, che era sostenuto da un perno passante per un foro al centro dell’occipite (circa 1,5 × 1,7 cm) e ancorato al nucleo argilloso tramite una bietta bronzea fissata con piombo colato. È probabile che servisse al fissaggio dell’elmo anche il foro di piccole dimensioni al centro dell’area frontale. La testa del “Bronzo B” è fusa in due parti: la calotta cranica è stata gettata separatamente e saldata per colatura, è priva di capelli e presenta una superficie irregolare interessata da lacune, sia passanti che superficiali. La zona occipitale ha una forte protrusione, con un profilo schiacciato nella parte sinistra: la deformazione riproduce il profilo di un elmo sollevato sopra la testa, secondo l’iconografia tipica del guerriero a riposo, oppure di un copricapo voluminoso nella parte posteriore. Nella zona frontale sono state applicate due placchette in rame con finitura martellata (cfr. foto in alto). Quella inferiore, ancorata a un’indentatura immediatamente sopra l’attaccatura dei capelli (alcune ciocche sfuggono al di sotto), è di forma triangolare e misura nello stato attuale circa 4 × 12,5 cm. Quella superiore è quasi rettangolare, misura 4,3/4,5 × 9,0/9,3 cm ed è alloggiata in una mortasa scavata nella superficie del bronzo per circa 2 mm. È stata rimossa durante il restauro del 1975–1980 e ricollocata solo nel 2009–2011, di modo che la maggior parte delle fotografie della testa del “Bronzo B” mostra la mortasa vuota. È probabile, come ipotizzava Sabbione già nel 1984, che le due placchette vogliano simulare una cuffia in pelle o in tessuto indossata sotto l’elmo. Esse sono posizionate in modo da risultare visibili sotto il frontale e attraverso i fori per gli occhi di un elmo corinzio sollevato, oppure in corrispondenza di eventuali aperture di un copricapo di altro tipo.
- Le soluzioni di finitura della testa del “Bronzo A” sono molto più ambiziose e complesse di quelle del “Bronzo B”. Nel “Bronzo A” la bocca semiaperta ha comportato, oltre all’inserzione delle labbra in rame (presenti in entrambe), la fabbricazione dei denti in lamina d’argento sbalzati a freddo e ancorati a una struttura portante per la quale è stato scavato un alloggiamento nel nucleo argilloso. Nel “Bronzo B” le labbra sono chiuse e i denti non visibili. Le ciocche esterne dei capelli e della barba del “Bronzo A” sono tridimensionali, gettate a parte e fissate mediante giunti a coda di rondine, nascosti nei capelli dalla fascia che cinge il capo. La modellazione della barba e dei capelli del “Bronzo B” è piatta, ricavata nello spessore della cera di fusione. I capelli sono limitati alle ciocche frontali sfuggenti dalla placchetta inferiore e a pochi ciuffi sul collo, visibili al di sotto di una superficie aggettante irregolare nella parte posteriore.
- Chi ha fatto “B” ha messo sulla forma interna ricoperta di cera dei salsicciotti di argilla a simulare le costole, in modo tale da modellarle facilmente.
- Entrambi i Bronzi vennero restaurati, probabilmente a Roma e probabilmente nel I Sec. d.C., un restauro molto complesso (un braccio e un avambraccio di “B” sono risalenti all’epoca romana). Forse sono stati fatti dei calchi sulle braccia rotte, poi fuse e rimesse al loro posto. Questo ha comportato che le due statue non si potessero lasciare del loro colore originario, perché avevano colori molto diversi tra loro: quindi furono dipinte di nero. La dimostrazione è nella patina di zolfo lucida trovata dal prof. Giovanni Buccolieri dell’Università del Salento: è stato il prof. Koichi Hada dell’Università di Tokyo a capire che questa patina era la prova che i Bronzi erano stati dipinti tutti di colore nero.
Due autori distinti o solo le officine?
Due officine distinte ma culturalmente collegate sono coerenti con la natura chimica e mineralogica dei nuclei. Un territorio con suoli chimicamente omogenei, cioè una “regione” geologica, è in generale abbastanza circoscritto da condividere elementi della cultura materiale, come accade nei Bronzi. Questo potrebbe significare che sono stati prodotti nell’ambito della medesima “scuola” artistica, anche se l’identità “regione/scuola” è tutt’altro che scontata. Ma se le argille dei nuclei provengono da giacimenti diversi è quasi automatico dedurre che si tratti di due officine distinte, dato che un materiale comune e a basso costo come l’argilla veniva sempre prelevato il più vicino possibile alla fornace. Del resto è fuor di dubbio che i Bronzi tradiscono due “saperi” diversi: quei saperi empirici che ogni “maestro”, partendo dalle consuetudini di “scuola”, elaborava in base alla propria esperienza, come mostrano Benvenuto Cellini e Orfeo Boselli nei loro trattati.
È invece quasi certo che i Bronzi siano appartenuti allo stesso monumento. Abbiamo visto che hanno le stesse dimensioni, lo stesso peso, lo stesso soggetto, la stessa posa e si trovavano sulla stessa nave. Da sole queste circostanze rendono un’associazione casuale inverosimile. Ma a esse si aggiunge il dato fondamentale che il piombo dei tenoni di ancoraggio è isotopicamente identico e proviene dal medesimo giacimento. Quest’ultima circostanza non è dirimente in sé perché il piombo del Laurion era largamente diffuso, ma agisce come fattore di moltiplicazione del peso delle altre coincidenze. Rovesciamo la questione: quante probabilità ci sono che due statue identiche per soggetto, posa, dimensioni e peso, trasportate sulla stessa nave e ancorate con lo stesso piombo provengano da due monumenti diversi? Se non zero, poche.
Chiosa del redattore
Nella statuaria greca e soprattutto in quella romana in marmo, l’uso dei tenoni dipendeva dall’esigenza di garantire la stabilità della statua, soprattutto nel caso di repliche in marmo derivate da più leggeri prototipi in bronzo.
Dalle gammagrafie e dagli esami autoptici effettuati sui Bronzi di Riace, emerse che l’intelaiatura era costituita non da aste massicce di ferro ma da tubi, sempre in ferro, a sezione quadrata: una lunga lamina di ferro era stata ripiegata su sé stessa per martellatura intorno a un’anima forse di legno. La sbarra principale della “Statua A” andava dal piede fino al collo, fermandosi nel punto esatto dov’era stata eseguita la giuntura della testata; nella “Statua B”, la sbarra si fermava all’altezza del petto: il pezzo mancante fino al collo fu probabilmente estratto in antico, durante il restauro del braccio, il quale non era riempito della terra di fusione, così come lo spazio superiore del torace, che fu anch’esso svuotato in sede di restauro. Probabilmente le sbarre al momento della fusione sporgevano dai talloni e se è vero che nell’istallazione delle statue di bronzo si utilizzava, in età antica, la sbarra di ferro sporgente per un certo tratto oltre il tallone, si potrebbe pensare che la rottura ed estrazione della parte sporgente sia avvenuta al momento di una seconda sistemazione delle statue, per la quale si utilizzarono dei tenoni in piombo.
Piombo del Laurion, che Atene esportava in tutto il Mediterraneo: e che dunque potrebbe benissimo indicare un’origine non necessariamente attica ma romana. Ossia, i tenoni trovati ai piedi dei Bronzi di Riace potrebbero essere semplicemente risalenti alla loro “ultima” esposizione (a Roma?), non a quella originale (ad Argo?).
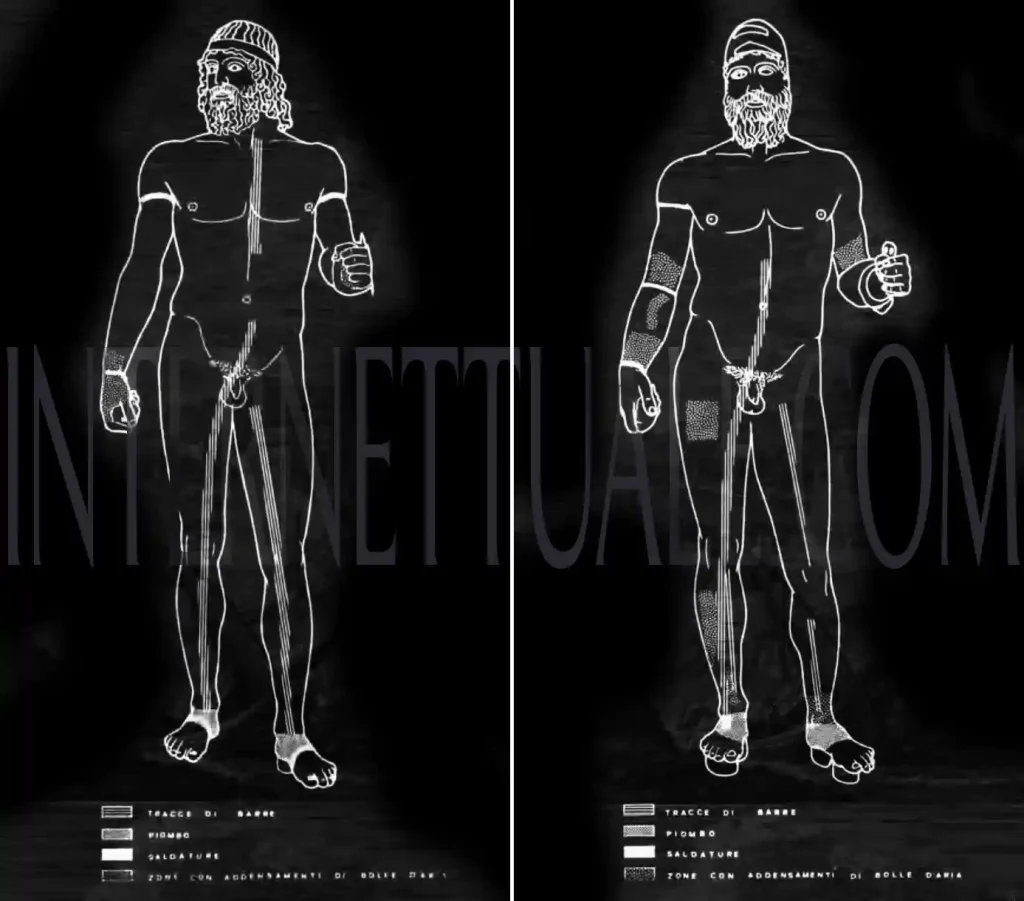
La pertinenza allo stesso monumento non contrasta con il fatto che i Bronzi siano stati prodotti da officine diverse e indipendenti. Il coinvolgimento a titolo individuale di più artefici in una medesima commissione è una prassi ben attestata nel mondo greco, specialmente dalla seconda metà del V Sec. a.C. in poi. Vi rientrano casi notissimi come le Amazones volneratae di Efeso (Plinio, XXXIV.53) e il Mausoleo di Alicarnasso (Plinio, XXXVI.30-31), ma i monumenti che ci offrono le analogie più interessanti sono alcuni grandi donari delfici nei quali le notizie letterarie hanno trovato il riscontro dell’archeologia e dell’epigrafia. Il Donario di Lisandro (Pausania, X.9.7-10), dedicato dopo la vittoria di Egospotami (405 a.C.), con le sue trentotto o trentanove statue è il più grande monumento votivo di cui sia rimasta memoria. Nell’impresa furono coinvolti ben nove bronzisti: Theokosmos di Megara, Antiphanes di Argos, Pison di Kalaureia, Athenodoros di Kleitor, Dameas di Kleitor, Teisandros di cui non si conosce l’etnico, Alypos di Sicione, Patrokles di Sicione e Kanachos il Giovane di Sicione, che firmano insieme. Di nessuno di loro abbiamo più di qualche notizia letteraria e, talvolta, la firma.
Una questione è cruciale: dove hanno lavorato i bronzisti? Ciascuno nella propria città oppure a Delfi, in una sorta di “cantiere” simile a quelli che si formavano intorno alle cattedrali medievali? Alcuni decenni prima due coppie di scultori peloponnesiaci, Atotos e Argeiadas di Argos, Athanodoros acheo e Asopodoros di Argos, avevano allestito il Donario di Prassitele di Mantinea lavorando a Olimpia. Con i Bronzi di Riace non è accaduto così, dal momento che il restauro delle braccia di “B” è stato eseguito in un luogo diverso da quello di fabbricazione della statua. È possibile che le figure di uno stesso monumento venissero eseguite nella città del committente, o in quelle d’origine degli artefici, e poi trasferite nella località in cui sorgeva il monumento? La risposta è sì. Lo dimostrano altri importanti monumenti delfici. Primo fra tutti il Donario degli Arcadi che fronteggiava quello di Lisandro sulla via Sacra. Dedicato fra il 369 e il 362 a.C. per celebrare la vittoriosa campagna della confederazione arcadica contro gli Spartani al fianco di Epaminonda (369/68 a.C.), era costituito da nove statue poste su una base di tre assise di blocchi di calcare grigio-blu e di calcare di Sant’Elia (le pietre più comuni a Delfi) che gli scavi hanno restituito quasi per intero.
Le statue rappresentavano Apollo, Nike, l’eroe eponimo Arkas, sua madre Kallisto, i suoi figli Elatos, Apheidas, Azan, Triphylos ed Erasos, eponimi delle tribù arcadi. Il monumento è stato affidato a quattro bronzisti, ciascuno dei quali ha firmato le proprie opere: Pausanias di Apollonia, Daidalos di Sicione, Antiphanes di Argos e Samolas arcade. Pausanias (Apollo, Kallisto) e Samolas (Azan, Truphylos) sono ignoti. Antiphanes (Elatos, Apheidas, Erasos) lo abbiamo visto all’opera nel monumento di Lisandro e sappiamo che ha collaborato ad altri donari delfici. Daidalos (Nike, Arkas) ha lavorato soprattutto per Olimpia. Negli anni Sessanta del IV Sec. entrambi questi ultimi erano anziani: la loro carriera si estende dalla fine del V alla metà del IV Sec. a.C.. Lo schema della commissione è lo stesso del monumento spartano, con le figure affidate a bronzisti di città e regioni diverse. Se Antiphanes e Daidalos rappresentano Argos e Sicione, Samolas sembra confermare che in Arcadia fra V e IV Sec. a.C. è esistita una tradizione di bronzisti di buon livello. Non c’è modo invece di sapere se Pausanias, originario dell’Epiro, appartenesse a una delle scuole principali e dove lavorasse. Tuttavia l’altro Pausania, ossia il nostro affezionato Periegeta, fornisce un dettaglio fondamentale:
ταῦτα μὲν δὴ οἱ Τεγεᾶται ἔπεμψαν ἐς Δελφούς, Λακεδαιμονίους ὅτε ἐπὶ σφᾶς ἐστρατεύσαντο αἰχμαλώτους ἑλόντες. (Queste statue i Tegeati le hanno inviate a Delfi, avendo preso prigionieri i Lacedemoni quando combatterono contro di loro.)
Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” X.9.3
Anche se il monumento era stato votato dall’intera confederazione arcadica e non dai soli Tegeati, il senso è inequivocabile: le statue, finanziate col riscatto dei prigionieri, sono state eseguite altrove e poi spedite a Delfi. Dove ciascun artefice abbia lavorato, se nella propria città, come sarebbe plausibile, oppure in un altro luogo deciso dai committenti, non è dato sapere: certo però non nel santuario.
Nota: Pitagora di Reggio aveva un nipote di nome Sostrato, come abbiamo già letto da Plinio:
Fuit et alius Pythagoras Samius, initio pictor, cujus signa ad aedem Fortunae hujusce diei septem nuda, et seuis unum, laudata sunt. Hic supra dicto facie quoque indiscreta similis fuisse traditur: Rhegini autem discipulus et filius sororis fuisse Sostratus. (Ci fu ancora un altro Pitagora da Samo, inizialmente pittore, le cui statue sono sette, ignude, nel Tempio della Fortuna, e una d’un vecchio, le quali sono molto lodate. Dicesi che costui fu molto simile di viso al primo: e Sostrato fu discepolo e figliuolo d’una sorella di Pitagora di Reggio.)
Plinio, “Naturalis Historia” XXXIV.60
Il prof. Castrizio ritiene che Sostrato abbia aiutato Pitagora, lavorando «a compartimenti stagni»: secondo lo studioso le proporzioni sono identiche, il sistema di lavorazione simile, e dunque i Bronzi stanno nello “stesso ritmo” perché sarebbero stati concepiti dalla “stessa mano” (anche se, aggiungo io, il nipote che… “mandò avanti la ditta” era evidentemente meno bravo dello zio — ndr).
La lunga discussione può essere sintetizzata in questo modo.
L’incrocio dei dati tecnici (peso, misure, modalità esecutive), analitici (composizione chimica e mineralogica dei nuclei, composizione chimica dei metalli, radiocarbonio), archeologici (contesto di rinvenimento) e storico-artistici (iconografia, stile) concorrono a indicare che i Bronzi sono sculture del V Sec. a.C., quasi contemporanee, collocate sullo stesso monumento. Quale fosse tale monumento, dove si trovasse e quando sia stato allestito è impossibile dire sulla base dei dati noti. È invece sicuro che i Bronzi sono stati prodotti da officine diverse, quindi da artefici diversi, distinguibili sotto il profilo degli approvvigionamenti, della tecnica e dello stile.
È sicuro anche che le officine erano localizzate in un’area abbastanza circoscritta e con una certa omogeneità nella cultura materiale, ma in località diverse, forse in città diverse. I Bronzi sono stati prodotti in un luogo che non coincide con quello del monumento che le ospitava.
Il modello di riferimento sono i grandi anathemata come il Donario di Lisandro o il Donario degli Arcadi a Delfi, ai quali erano chiamati a collaborare artefici di scuole, città ed età diverse e le cui le figure potevano essere inviate al santuario pronte per essere installate sulle basi, dopo essere state eseguite altrove.
Sperare che la nostra conoscenza dei Bronzi possa progredire unicamente grazie alle risorse della ricerca storico-artistica è un’illusione. In oltre quarant’anni di tentativi l’analisi stilistica si è dimostrata impotente. Il progresso può venire solo da un ampiamento dei dati analitici, a condizione che essi siano sottoposti a una corretta lettura archeologica — cosa che non sempre è avvenuta finora.
È necessaria in primo luogo la campionatura dei suoli delle aree indiziate come possibili luoghi di esecuzione, a partire dall’Argolide e dalla Megaride, che le carte qualificano come le più promettenti dal punto di vista chimico (fra l’altro sia Argos che Megara sono fra le città d’origine degli artefici del Donario di Lisandro).
Altrettanto necessario è lo studio chimico e mineralogico dei nuclei del braccio e dell’avambraccio di restauro del “Bronzo B”. In quanto ellenistici essi sono stati trascurati: nessun campione è mai stato oggetto di analisi, né dal punto di vista chimico, né da quello mineralogico. Eppure è chiaro che solo quelle argille possono fornire indicazioni attendibili sul luogo in cui sorgeva il monumento al quale i Bronzi sono appartenuti. Senza contare che la presenza di elementi organici lascia concrete speranze di definire, attraverso la misura del Carbonio 14, il momento del restauro. Esso infatti ricade fuori dall’intervallo del Plateau di Hallstatt ed è plausibile che ne risulti un responso preciso.
Ciò significherebbe fissare il terminus ante quem dell’ultimo viaggio dei Bronzi. Quel viaggio che insperatamente li ha portati fino al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dopo forse due millenni di sonno nella sabbia del mare di Riace Marina.

L’ULTERIORE TEORIA SUI BRONZI COME “FOTO ANATOMICHE”
Pericle e Temistocle?
Di recente è stata elaborata una nuova ipotesi, presentata in varie conferenze a Reggio Calabria (il sottoscritto ha assistito di persona a una di queste, il 19 Luglio 2022), che trascende quella dei “Sette contro Tebe” di Moreno/Castrizio (che qui ho denominato “Teoria 1”, e dunque per comodità battezzeremo l’ultima come “Teoria 3”). Elaborata da Riccardo Partinico, ex docente di Scienze Motorie e Sportive (quindi non un’autorità “di settore” come lo storico e numismatico prof. Castrizio o gli archeologi Roma e Moreno), essa propone di identificare i due Bronzi di Riace come sculture di personaggi storici dell’epoca, i celeberrimi Pericle e Temistocle.
È l’indagine di punta di una nuova disciplina (da lui inventata, a quanto sembra) che egli definisce “Anatomia Archeo-Statuaria”, attraverso la quale si studierebbero la gestualità, lo scheletro, i muscoli, la postura, la fisionomia e la somatometria dei corpi rappresentati dalle statue di interesse archeologico. Il tutto viene poi comparato sia con i risultati delle analisi sui Bronzi effettuate dal Ministero per i Beni Culturali che con le fonti storiche della Grecia Antica: le “Storie” di Erodoto, “I Chironi” di Cratino, frammenti delle opere di Protagora, “Guerra del Peloponneso” di Tucidide, “Guida della Grecia” di Pausania e “Vite Parallele” di Plutarco.
Nel V Sec. a.C. il tema centrale dell’arte greca era la raffigurazione dell’uomo. La tradizione letteraria e quella figurativa testimoniano che non solo i miti e gli atleti olimpici ma anche i militari, i politici, i filosofi e gli scrittori indicati come i grandi uomini del loro tempo furono raffigurati con statue. Le pubblicazioni di Pausania, Erodoto & C. descrivono l’identità e i tratti somatici di personaggi che hanno reso “grande” la Grecia V Sec. a.C..
Sostanzialmente, in base all’ipotesi di Partinico, l’artista grecoantico sarebbe stato alla ricerca dei particolari anatomici del personaggio cui lavorava onde poter perfezionare la propria raffigurazione: nel risultato finale (la statua in bronzo) l’identità del personaggio raffigurato doveva essere inconfondibile, e sarebbe testimoniata da questa ossessiva ricerca di “verismo”. (Come vedremo alla fine di questa dissertazione, la convinzione accademica e le prove archeologiche ci dicono tutt’altro, ma andiamo avanti.) Partinico ne deduce che le perfette proporzioni dei muscoli scheletrici, la corretta collocazione delle vene, le tipicità dei crani, e, soprattutto, le alterazioni scheletriche che si osservano nei corpi delle due statue conservate al Museo di Reggio Calabria siano la raffigurazione di due persone reali delle quali si è ricercata e rappresentata con ostinazione l’identità. I Bronzi di Riace non sarebbero i personaggi mitologici individuati da altri studiosi — Eteocle e Polinice, Anfiarao e Tideo, Castore e Polluce, Eretteo ed Eumolpo —, bensì personaggi storici “fotografati” come farebbe un cronista dei nostri tempi con un John F. Kennedy o un Mario Draghi.
Come abbiamo testé visto, dai dati del MiBAC pubblicati dopo il recente restauro delle due statue emergono informazioni incontrovertibili ormai date per scontate dalla comunità scientifica. L’analisi chimica dell’argilla rimossa dall’interno delle due statue, lo studio minuzioso dei materiali, dei metalli e delle tecniche di realizzazione, gli stili artistici differenti (Severo e Classico) stabiliscono che:
- I due Bronzi sono stati realizzati nel V Sec. a.C.;
- da due équipe di artisti e/o bronzisti;
- nell’area geografica circoscritta tra Atene e Argo.
In particolare, in base a un quarantennio di studi stilistici e artistici (cfr. più avanti), la statua cosiddetta “Bronzo A” (o “il Giovane”) risale a circa il 460 a.C., mentre il “Bronzo B” (o “il Vecchio”) risale a circa il 430 a.C.: con buona pace del Carbonio 14 e dei suoi margini di incertezza, gli studiosi dell’arte ci dicono che intercorrerebbero circa trent’anni fra le due realizzazioni.
Come detto, le statue appaiono fuse con rame di diversa provenienza e sono opera di fonditori diversi (soprattutto per la minore abilità tecnica e la minore cura poste nel suo lavoro dal fonditore della “B”). Si tratterebbe quindi di artisti diversi se questi avessero realmente fuso essi stessi la loro opera, il che peraltro, perlomeno nel caso della “B”, è opinabile.
Tutto ciò, contrariamente alle succitate conclusioni del prof. Ludovico Rebaudo, potrebbe significare che non facessero parte di una singola rappresentazione artistica (per es., i “fratricidi di Tebe”). Ma soprattutto, oltre ogni ragionevole incertezza, significa che il momento di realizzazione coincide esattamente con la cosiddetta “Età di Pericle”, quel luminoso lasso del V Sec. a.C., generalmente ricondotto al periodo tra il 480 e il 404 a.C. — e in particolare proprio a quello tra il 460 e il 430 a.C. —, in cui Atene raggiunse il suo massimo splendore sotto la guida di Pericle. E appunto su questa corrispondenza Partinico poggia quasi per intero la solidità della propria argomentazione.

Muscoli, mignoli, schiene e mascelle
I Bronzi sono noti per la loro bellezza e armonia. Ma ciò che è davvero stupefacente è la precisione anatomica che fotograferebbe non soltanto dettagli minuziosi come la barba ma perfino apparenti “difetti”: ossia malformazioni molto umane. In definitiva, una sorta di iper-realismo anatomico/patologico.
Per esempio, secondo Partinico, il “Bronzo A” sembra affetto da iperlordosi e progenismo.
L’iperlordosi è la riduzione della curvatura della colonna vertebrale causata dalla contronutazione permanente dell’osso sacro. Tale alterazione scheletrica modifica la postura: i glutei appaiono sollevati e gli addominali avanzati. Può essere causata dal progenismo mandibolare, malformazione del volto che si manifesta quando la mandibola, eccessivamente sviluppata, è avanzata rispetto all’osso mascellare e determina una malocclusione dentale. Tale patologia produce disturbi della masticazione, della respirazione e della fonazione. Sono visibili i denti dell’arcata superiore.

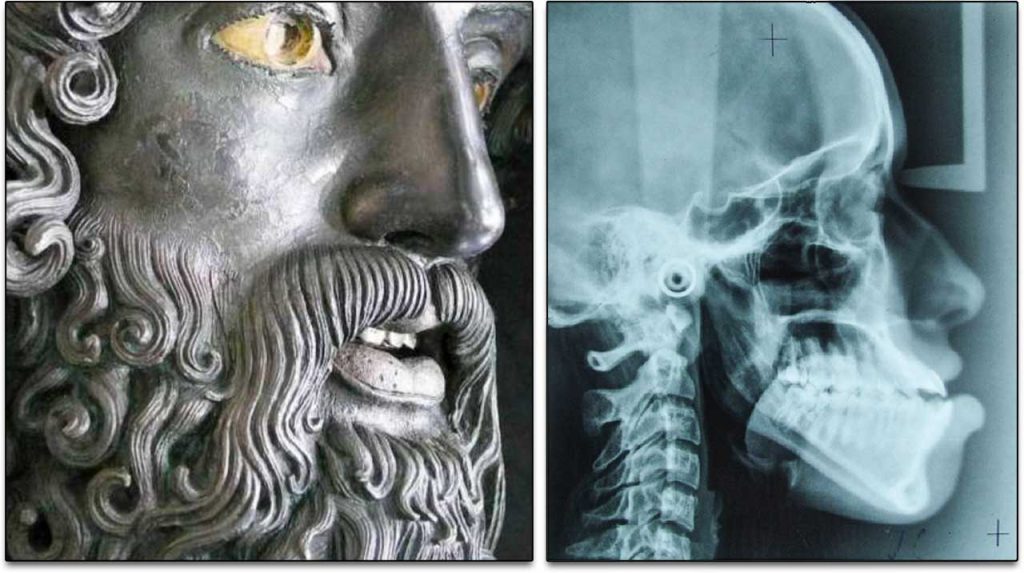
Anche l’altro Bronzo avrebbe “difetti anatomici” iper-realistici: varismo, scoliosi e dolicocefalia.
Il 5° dito varo è una deformità del piede che si caratterizza con una prominenza ossea a livello della regione dorso-lombare dell’avampiede del primo osso metatarsale che porta il 5° dito ad avvicinarsi al quarto con una deviazione angolare. Il varismo del 5° dito del piede può essere causato da fattori ereditari o da particolari calzature che costringono le dita del piede ad assumere una posizione scorretta per lungo tempo. La “Statua B” presenta il varismo del 5° dito in entrambi i piedi. Cosa che non avviene invece per la “Statua A”, dotata di un perfetto “piede greco”.



Il nome scoliosi deriva dal termine greco skoliosis (incurvamento), che sua volta deriva da skolíos (curvo). Si tratta di una deviazione laterale, permanente, della spina dorsale associata alla rotazione dei corpi vertebrali. Tale patologia determina anche accorciamenti e allungamenti delle strutture muscolo-legamentose. La “Statua B” appare appunto come affetta da questa malformazione della colonna vertebrale.
La dolicocefalia (dai vocaboli greci kephalé = testa, cranio e dolichos = allungato) è una condizione nella quale la scatola cranica assume una forma stretta e allungata in senso antero-posteriore. Il cranio dolicocefalo era comune nell’antico Egitto (i… “vicini di casa” dei Greci) e tra le popolazioni dell’Europa del nord, in particolare tra Britannici e Scandinavi. Nelle antiche civiltà — per es., Aztechi, Maya e gli stessi Egizi — era diffusa la pratica di allungare i crani dei neonati con l’ausilio, inizialmente, di fasciature “rituali”, e in seguito di vere e proprie assi di legno che modificavano con la crescita le normali saldature delle ossa del cranio rendendolo appunto allungato. Si credeva di poter aumentare così le capacità cerebrali del soggetto. Anche se con tutta probabilità inizialmente dotata di un elmo oggi perduto — e c’è dunque la concreta possibilità che l’allungamento cranico della scultura fosse funzionale alla stabilità dell’elmo —, la testa della “Statua B” a parere di Partinico sembra appartenere al tipo dolicocefalico.


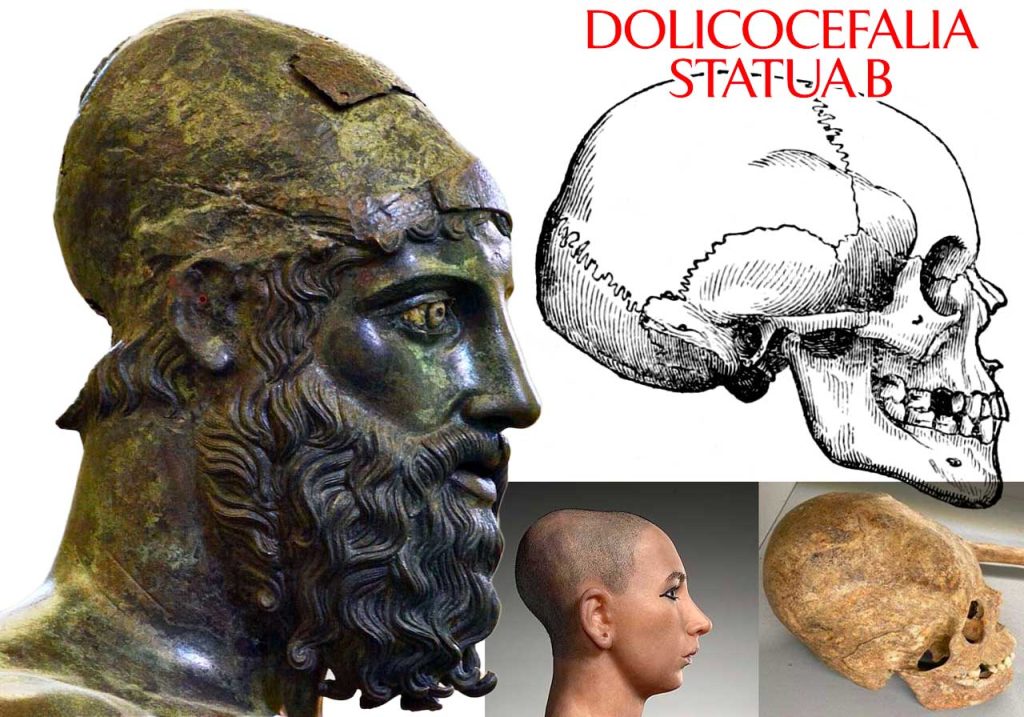
Si chiede il Partinico: per quale motivo, nel momento di massimo splendore dell’arte greca antica, un gruppo di artisti avrebbe dovuto rappresentare un mito o divinità con particolari anatomici che vanno ben oltre il celebre “idealismo” della Classicità? Come mai, in altre parole, si sarebbe dovuto raffigurare un personaggio “ideale” appioppandogli difetti fisici — e perché, spaccando il classico capello, proprio quei difetti?
Perché, spiega Partinico, proprio di personaggi storici si tratta. E non medi calibri o atleti di Olimpiadi ma i massimi uomini politici contemporanei al momento della realizzazione dei due Bronzi.
Andiamoli a vedere.
Pericle, figlio di Xantippo e Agariste, nacque a Colargo nel 495 a.C. e morì ad Atene nel 429 a.C. (in pratica, dopo il funerale gli dedicarono il “Bronzo B di Riace”). Generale, stratego e statista iniziò governare Atene nel 460 a.C. portandola al massimo splendore culturale, sociale e artistico. Favorì lo sviluppo delle arti e della letteratura e questa fu la principale ragione per la quale Atene detiene la reputazione di centro culturale dell’antica Grecia. Promosse, allo scopo di dare lavoro a migliaia di artigiani e cittadini, un ambizioso progetto edilizio che portò alla costruzione di molte opere sull’Acropoli, abbellì la città, esibì la sua gloria. Inoltre, sostenne la democrazia (nell’accezione aristotelica) a tal punto che i critici contemporanei lo definiscono un populista, soprattutto a seguito dell’introduzione di un salario per coloro che ricoprivano gli incarichi politici e per i rematori della flotta. Incaricò lo scultore Fidia di coordinare i lavori di ristrutturazione del Partenone e degli edifici di Atene distrutti dai Persiani e di realizzare statue in bronzo e criselefantine (cioè in avorio e oro) per onorare gli eroi che avevano combattuto per Atene.
Ebbe una così profonda influenza sulla società ateniese che Tucidide, storico suo contemporaneo, lo acclamò come «primo cittadino di Atene». Pericle fece della Lega delio-attica un impero comandato da Atene che esercitava la sua egemonia sulle altre città alleate, e guidò i suoi concittadini durante i primi due anni della guerra del Peloponneso.
Così Pausania il “Periegèta” (presso gli antichi greci il periegèta era la persona incaricata di guidare i forestieri nella visita di templi e monumenti — una odierna guida turistica, insomma, ma per nostra fortuna anche prezioso scrittore) nel II Sec. d.C. sulle statue che raffiguravano Pericle:
Nella cittadella di Atene sta Pericle figlio di Xantippo, e Xantippo stesso, che combatté in mare contro i Medi a Micale. La statua di Pericle è dall’altra parte.
Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” I.25.1
Oltre le statue da me descritte, due ve ne sono decime offerte dagli Ateniesi nelle loro guerre: una di bronzo di Minerva, opera di Fidia, e decima delle spoglie de’ Medi, che discesero in Maratona; sullo scudo della Dea è la battaglia dei Lapiti, e de’ Centauri, la quale, come tutti gli altri ornati, si dicono intagli di Mis, ed a lui sì queste, che tutte le altre opere sue, si vuole che fossero disegnate da Parrasio di Evenore. Fino dal Sunio veggono i naviganti la punta dell’asta, ed il cimiero di questa statua. L’altra opera decima delle spoglie de’ Beozj, e de’ Calcidesi di Eubèa è un carro di bronzo. Vi sono poi due altri doni, il Pericle figlio di Xantippo, e la opera di Fidia più degna di esser veduta, la statua, cioè di Minerva, che da quelli, i quali la dedicarono, appellano Lemnia.
Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” I.28.2
Anche Plutarco nelle celebri “Vite Parallele” cita le raffigurazioni scultoree di Pericle, ma soprattutto fornisce questo interessante aneddoto anatomico:
Costei [Agarista, moglie di Xantippo e madre di Pericle — ndr] sognò una notte di partorire un lione, e pochi giorni appresso partorì Pericle nell’altre membra sì ben formato, che biasimare non si sarìa saputo, sì la testa ebbe lunghetta e disproporzionata; e per questa cagione le imagini sue quasi tutte hanno la celata, non avendo, per mio avviso, voluto gli artefici rimproverargli questo difetto; e’ poeti ateniesi l’appellarono alcuna volta Schinocefalo, perché quella cipolla, che in lingua comune appelliamo squilla, nominarono talora Schinos.
Plutarco, “Vite Parallele” – Pericle, III
I commediografi dell’epoca, Cratino, Teleclide ed Eupoli, nelle loro commedie soprannominavano Pericle “testa di cipolla marina”. (La scilla marittima, nota anche come cipolla marina, è una pianta della famiglia delle Asparagacee caratteristica del bacino del Mediterraneo, che vive allo stato selvatico in prossimità delle coste.) Ossia, il più grande statista greco dell’antichità, l’«inventore della democrazia», aveva un cranio dolicefalico.
In più, la somiglianza somatica fra il “Bronzo B” e le coeve statue di Pericle arrivate fino a noi sembra lampante: i parallelismi riguardanti naso, arcata sopracciliare, zigomi, labbra e mimica facciale lasciano in apparenza pochi dubbi al riguardo. Inoltre, a parere di Partinico, la fisionomia degli arti inferiori della statua, per l’evidente ipertrofia e definizione muscolare degli adduttori, dei glutei e dei tricipiti della sura, è compatibile con un uomo aduso ad andare a cavallo.

Temistocle, il “Bronzo A”
Personaggio storico fondamentale (e che personaggio!) sarebbe raffigurato anche nell’altra statua, “il Giovane” o “Bronzo A”.
Figlio di Neocle, appartenente al demo di Phrearrioi e alla gente nobile dei Licomidi, Temistocle nacque intorno al 530-525 a.C. (si dice che morì a 65 anni, ma questa notizia è incerta, ed è incerta del resto la data della morte; con sicurezza sappiamo solo che nel 493-92 a.C., quando fu arconte, doveva avere oltrepassato i 30 anni). Sua madre era una straniera, ciò che ha dato origine alla favola che egli fosse bastardo. Generale e statista, trasformò Atene in una grande potenza navale (dal 493 a.C.) e fu soprattutto l’eroe delle battaglie di Maratona, Capo Artemisio e Salamina: il condottiero che più di tutti contribuì alla vittoria della Grecia contro la Persia del Re Serse. Morì in esilio, attorno al 459 a.C.; tuttavia già Pericle qualche anno dopo ne riabilitò la memoria riconoscendolo come un eroe della causa ateniese.
Tucidide (Guerra del Peloponneso I.135-138) scrive che Temistocle fu «l’uomo più grande dei Greci». Secondo Erodoto (Storie VIII.124.1) «ebbe per tutta la Grecia grande fama di essere l’uomo di gran lunga più accorto (σοφώτατος) di tutti i Greci». E più tardi, I Sec. a.C., Diodoro Siculo, forte di una tradizione celebrativa delle gesta di Temistocle, afferma che a questi «per giudizio unanime veniva attribuito il merito della vittoria» (Bibliotheca historica XI.19.5), e che Temistocle risulta senz’altro l’uomo più eccellente di tutti quelli in cui si è imbattuto nella sua ricerca (XI.58.5). Altre fonti storiche testimoniano dell’esistenza di sculture e raffigurazioni di Temistocle: statua nell’agorà di Magnesia (Tucidide, Nepote, Plutarco); dipinto dedicato nel Partenone dai figli (Pausania, I.1.2); eikonion nel tempio di Artemide Aristoboule vicino alla dimora di Temistocle a Melite (Plutarco, Vite Parallele – Temistocle 22.1-2), in cui i tratti eroici erano visibili non solo nell’animo ma anche nell’aspetto («opsis heroikos»); ritratto nel Pritaneo con Milziade e riconosciuto pur con la metegrapsan in un Trace (Pausania, I.18.3); ritratto nel teatro di Dioniso, ancora insieme a Milziade, ognuno con un Persiano catturato (schol. Publio Elio Aristide Or. 46, 161.13).
I figli di Temistocle, al loro ritorno ad Atene dopo la morte del padre, dedicarono una statua in bronzo di Artemide Leukophryene sull’Acropoli (Pausania, I.26.3), nonché un dipinto di Temistocle nel Partenone. Non sussiste dubbio sulla natura privata dell’iniziativa, probabilmente un pinax votivo, sotto l’egida di Pericle che autorizzò il rientro dei figli dall’esilio.
Sono sopravvissute fino a noi opere come il busto conservato nei Musei Vaticani, copia in marmo di un originale greco V Sec. a.C., e monete coniate a Magnesia nel 465–459 a.C. circa.
Vicino è il Pritanèo, dove sono scritte le leggi di Solone, e si veggono i simulacri della Pace, e di Vesta: fra le statue vi è quella del Pancraziasta Autolico. Imperocché trasformarono ne’ ritratti di un Romano, e di un Trace quelle di Milziade, e di Temistocle.
Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” I.18.3
Di converso, però, abbiamo un’asserzione di Demostene (Fil. 23.196), il massimo oratore greco e uno dei più grandi di tutti i tempi, il quale afferma che:
…a Temistocle e Milziade, seppur più grandi degli strateghi loro contemporanei, gli ateniesi non innalzarono alcuna statua.
È un’affermazione molto significativa, poiché Demostene appartiene al IV Secolo (384–322 a.C.) e quindi fu molto vicino agli eventi, vivendo le testimonianze quasi di prima mano, molto più vicino rispetto per esempio a Pausania o a Plutarco (vissuti quattro secoli dopo). Il che potrebbe significare che le statue temistoclee viste dagli altri autori successivi appartenevano all’epoca ellenistica, quando ormai era stata ridata la meritata dignità alla memoria di Temistocle — in ogni caso, troppo in là coi secoli per lo stile Severo che si vede nel “Bronzo A”.

Esiste anche un busto, detto “Erma di Temistocle”, di epoca romana in stile Severo, basato su un originale greco, ospitato nel Museo Archeologico di Ostia. L’opera riporta addirittura il nome Temistocle scolpito alla base. L’originale perduto di questo busto, datato intorno al 470 a.C. (appena un decennio prima del “Bronzo A”), è stato descritto dagli studiosi come «il primo vero ritratto di un individuo europeo». Come si può vedere dalla foto (cliccare per ingrandire), l’aspetto diverge totalmente dallo standard delle altre sculture raffiguranti il condottiero di Maratona e Salamina.
L’ipertrofia dei muscoli del corpo umano “disegna” la fisionomia di un atleta. Un maratoneta (a sinistra nella foto successiva) sviluppa forme muscolari diverse da un lottatore (al centro) o da un culturista (a destra).
Il “Bronzo A”, secondo Partinico, è una figura di lotta: muscoli adattati alla capacità fisica forza/resistente. Azioni dinamiche svolte dall’apparato locomotore, caratterizzate da spinte e trazioni, prese e torsioni, piegamenti ed estensioni, avvinghiamenti.


Che Temistocle fosse avvezzo fin dalla giovinezza a questo sport lo veniamo a sapere ancora una volta da Plutarco nelle “Vite parallele”:
Muscoli del volto come carta d’identità grecoantica
I muscoli facciali-mimici sono trentasei e le loro contrazioni o decontrazioni possono determinare numerose espressioni del volto: felicità, tristezza, stupore, paura, rabbia, disgusto, imperturbabilità.
Nel “Bronzo A” la contrazione di tre muscoli mimici — frontale, corrugatore del sopracciglio, elevatore del labbro superiore — determina nel soggetto rappresentato dalla statua un’espressione aggressiva. La contrazione dell’elevatore del labbro superiore e anche il lieve progenismo mandibolare mettono anche in evidenza i denti dell’arcata superiore. È un guerriero, un condottiero militare.
Al contrario nel “Bronzo B” la decontrazione di almeno quattro muscoli mimici — frontale, corrugatore del sopracciglio, orbicolare dell’occhio, elevatore del labbro superiore — determina nel soggetto raffigurato dalla statua un’espressione imperturbabile. Un capo, uno statista.
Queste due definizioni caratteriali concordano con la tesi ufficiale pubblicata sul sito web del Museo di Reggio Calabria e formulata dal prof. Castrizio.
Attraverso gli scritti di Protagora (481–411 a.C.), filosofo “padre della sofistica” e amico di Pericle, e di Plutarco (46/48 d.C.–125/127 d.C.), apprendiamo qualcosa sulla mimica facciale di Pericle. Protagora lo definisce «imperturbabile»: non solo quale dato caratteriale ma come esempio etico e politico da ostentare; quattro secoli più tardi Plutarco definisce l’espressione del volto di Pericle «immobile al riso».
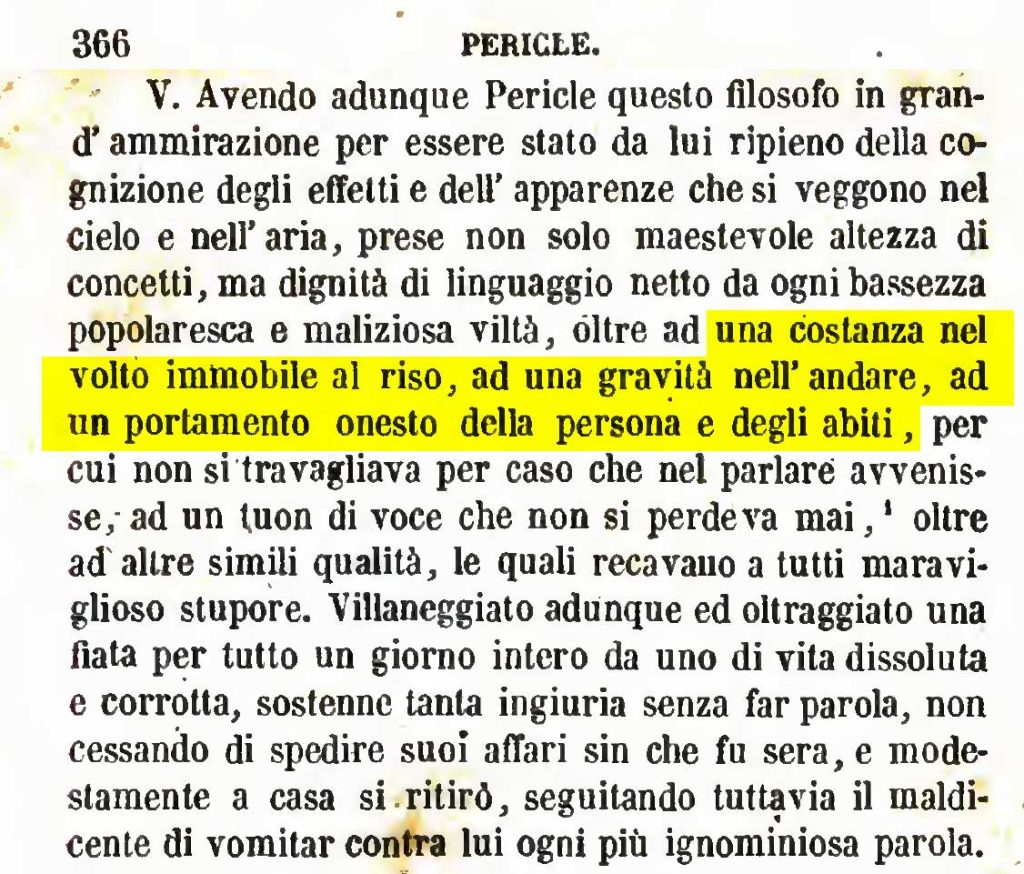

(Castrizio in varie interviste segnala che il gruppo bronzeo dei “Sette contro Tebe” ha lasciato dei confronti letterari tutti provenienti da Roma e tutti pertinenti, e che in ognuno di questi i tre personaggi principali — Eteocle, Polinice e la loro madre in mezzo — sono sempre presenti. Ma fa soprattutto notare che in tutti i confronti Polinice è sempre arrabbiato, e la mimica facciale nel “Bronzo A” presenta un soggetto dello stesso tipo: «è l’unica statua del mondo greco pervenutaci a essere rappresentata mentre digrigna i denti, probabilmente in segno di astio. Ha anche l’occhio sinistro vagamente strizzato», conclude Castrizio.)
Come abbiamo visto, quando nel 1972 le due statue vennero ritrovate nelle acque di Riace erano dotate di una struttura di piombo, a forma di zoccolo, che fuoriusciva dalla pianta dei piedi e serviva per ancorarle a un basamento. E le analisi chimiche hanno rilevato che il metallo di tali “tenoni” proveniva dalle miniere del Laurion, circa 50 km a sud di Atene.
L’ipotesi — non solo di Partinico ma praticamente della totalità degli studiosi — è che i Bronzi fossero esposti insieme in Grecia nella stessa agorà QUANTOMENO APPENA PRIMA di essere rimosse e caricate su un’imbarcazione che naufragò in Calabria. Tuttavia Partinico diverge rispetto per esempio alla ricostruzione offerta dal prof. Castrizio: non c’è bisogno di ipotizzare un complicato periplo fra Tirreno e Jonio, con naufragio finale nelle acque di Riace, le statue provenivano direttamente dalla Grecia, con una rotta esclusivamente jonica.

La colonia magnogreca di Locri e l’isola di Cefalonia si trovano sullo stesso Parallelo 38°14’N. Tra i due antichi porti di Locri e di Kaulon sulla costa calabrese e quello greco di Sami intercorrono circa 350 km: pur lunga e difficoltosa per un’epoca in cui l’unico motore nautico era il vento, la rotta era ed è la traversata più breve tra la Calabria magnogreca e la Grecia.
Proprio perché condizionate dal vento, le traversate erano favorevoli solo dalla Grecia verso la Calabria (quando soffiava vento di levante) mentre venivano spesso ostacolate in senso inverso (dai frequenti forti venti di scirocco).
La rotta ipotizzata al IV Sec. d.C. (Weinstock/Castrizio) per trasportare il gruppo scultoreo bronzeo comprendente Eteocle e Polinice da Roma a Costantinopoli era un viaggio lunghissimo, interrotto da numerose tappe intermedie, denso di insidie; volendo attraversare in modo diretto e “risparmiare strada” (anzi, onde marine), il porto di Locri — e in alternativa quello di Kaulon, qualche miglio più a nord — offrivano verosimilmente l’ultima sosta in Italia prima della lunga traversata fino a Sami, all’epoca il principale centro dell’isola di Cefalonia. Altrimenti si poteva continuare a costeggiare in sicurezza la terraferma dello Jonio, attraccando in sosta nei vari altri porti magnogreci, fino a raggiungere l’imboccatura dell’Adriatico, e attraversare dove la distanza fra le coste italica e greca è più breve (circa 75 km), poco a nord dell’isola di Corfù, più o meno fra le odierne Otranto e Valona. In entrambi i casi, arrivati a Sami o in Albania, si era solo a metà strada per Costantinopoli.
La rotta contraria ipotizzata da Partinico è più “naturale”: molto più veloce, in linea retta, favorita dal “vento in poppa”. Impossibile stabilire il periodo (e il motivo) del viaggio di Pericle e Temistocle da Atene (o Argo, o qualsiasi altro posto in Grecia) alle colonie della Magna Grecia: ma del resto anche l’input dell’imperatore Costantino databile al IV Sec. d.C. è solo teorico. Semplicemente, non abbiamo (né mai avremo, a meno di improbabili scoperte di testi antichi oggi perduti) alcuna prova di nulla, all’infuori dell’esistenza di due fenomenali sculture e di un probabile antichissimo naufragio avvenuto in prossimità della costa calabrese.
In conclusione
I punti di forza di questa “terza teoria” sono:
— la perfetta coincidenza con l’età d’oro di Pericle, preceduta (e in un certo senso favorita) dai successi militari di Temistocle;
— la somiglianza con alcuni volti coevi riprodotti nell’arte e nella numismatica;
— la testimonianza, in certi autori antichi, dell’esistenza di statue di Pericle e di Temistocle;
— la kynê del “Bronzo B”, che è prova non di un dio o mito o atleta ma di “capo militare”.
I punti di debolezza sono ahimé sostanziosi e appartengono al campo della critica artistica mainstream, che nel caso dell’arte greca è corposissima (se non la più corposa in assoluto).
Tanto per fare un esempio, uno scultore famoso di quella stessa antichità classica come Mirone di Eleutère, attivo proprio tra il 480 e il 440 a.C. e uno dei più elogiati rappresentanti dello stile “severo”, attraverso la creazione di figure in movimento specie di atleti (sua fonte principale d’ispirazione) cercava di legittimare, con l’azione violenta compiuta dal soggetto, l’aspetto vivo e vibrante della figura che era il suo ideale. La “muscolatura” e le tensioni mimiche del “Bronzo A”, in altri termini, non sarebbero testimonianza storica, nel senso di personaggio realmente esistito, bensì frutto di idealismo — una scelta stilistica, insomma.
Stessa scelta stilistica che caratterizza lo splendido «Ares/Teseo» della Villa Adriana a Tivoli (foto in basso), che non a caso gli studiosi situano, cronologicamente e artisticamente, a metà fra il “Bronzo A” e il “Bronzo B” per dimensioni, impostazione e trattamento del nudo. Anche questa mirabile scultura è caratterizzata da iperlordosi, scoliosi e atteggiamento del tutto pacifico, “imperturbabile” — pur trattandosi (anche se l’identificazione è incerta) del dio Ares, il nume della guerra!
Ritroviamo peraltro i “difetti anatomici iper-realistici” ancora a Villa Adriana, a Tivoli, nella statua dell’«Hermes», e poi, uscendo da Tivoli, nel meraviglioso «Doriforo» di Policleto (altro celeberrimo scultore dello stesso periodo — cfr. foto successive), sempre databile attorno alla metà del V Sec. a.C. e oggi purtroppo noto solo da copie marmoree postume — in grado però da sole di… provocare ugualmente sindrome di Stendhal. Tutte opere dotate, nei piedi, di 5° dito varo.
E c’è un altro ostacolo insormontabile: perché Pericle da buon capo sarebbe raffigurato con la kynê, mentre Temistocle (che fu un capo militare come e più di Pericle) ne sarebbe sprovvisto?
Cosa ci dice la storia della scultura greca antica
La scultura è l’aspetto più conosciuto dell’arte greca. Ciò è dovuto al maggior numero dei reperti archeologici pervenuti fino a oggi rispetto, per esempio, a quelli della pittura, che ha una minore resistenza dei materiali impiegati. Tuttavia, come già detto, solo una piccola parte della produzione scultorea greca è giunta fino a noi. Molti dei capolavori descritti dalla letteratura antica sono ormai perduti, gravemente mutilati, o ci sono noti solo tramite copie di epoca romana.
Ciò nondimeno, l’arte dell’antica Grecia divenne il pilastro e il fondamento su cui crebbe l’intera civiltà europea. E la scultura ne è un soggetto speciale. Senza la scultura antica, non ci sarebbero capolavori geniali del Rinascimento ed è difficile immaginare l’ulteriore sviluppo di questa forma d’arte.
I Greci decisero molto presto che l’uomo era il soggetto più importante per lo sforzo artistico. Considerando i loro dèi come aventi forma umana, nell’arte c’era poca distinzione tra sacro e profano: il corpo umano era sia secolare che sacro. Un nudo maschile di Apollo o Eracle aveva solo lievi differenze di trattamento rispetto a uno dei campioni olimpici di pugilato o lotta di un dato anno. La statua, originariamente singola ma nel periodo ellenistico (dalla morte di Alessandro Magno, 323 a.C., in poi) sempre più spesso a gruppi, era la forma dominante, sebbene importanti fossero anche i rilievi , spesso così alti da essere quasi autoportanti.
Nel periodo “classico”, nel V e IV Sec. a.C., la scultura monumentale era composta quasi interamente da marmo o bronzo, con il bronzo fuso che divenne il mezzo preferito per le opere principali all’inizio del V Sec. a.C. (come riporta Plinio, la statuaria bronzea si chiamava holosphyraton); molti pezzi di scultura conosciuti solo nelle copie marmoree realizzate per il mercato romano erano originariamente realizzati in bronzo. Le opere minori erano in una grande varietà di materiali, molti dei quali preziosi, con una produzione molto ampia di statuine in terracotta. I territori dell’antica Grecia, fatta eccezione per la “Magna” Grecia (Sicilia e Italia meridionale), contenevano abbondanti scorte di marmi pregiati. Anche i minerali per il bronzo erano relativamente facili da ottenere.
Ci sono diverse testimonianze del fatto che nella Grecia del V Sec. a.C. le sculture in bronzo venissero realizzate in officine in cui si riproducevano in serie, grazie a una tecnica chiamata “fusione a cera persa” (che è stato possibile ricostruire anche grazie ai Bronzi). Semplificando molto, lo scultore creava prima un modello di cera, da cui poi ricavava uno stampo di argilla in cui venivano praticati dei fori. Quando l’argilla si era asciugata, scaldando lo stampo la cera colava via, e il bronzo fuso veniva versato nei fori: solidificandosi nello stampo creava la statua; spesso veniva utilizzata un’anima in argilla tra la cera e lo stampo, in modo che il metallo fosse un guscio sottile rendendo la statua leggera.
L’arte greca è anzitutto techne, ossia capacità dell’artigiano di domare la materia, che sia legno, bronzo, pietra, marmo o altro ancora, e plasmarla per ottenerne un oggetto, una figura animale o umana. L’artigiano è dunque un technites che non crea seguendo un impulso personale, ma si forma faticosamente in bottega, inserendosi in una tradizione produttiva (al cui sviluppo può certamente contribuire con la sua maestria e il suo particolare ingegno), tradizione produttiva che però risponde anzitutto alle esigenze e alla sensibilità della comunità committente dell’oggetto artistico. È in questo quadro in cui materia prima, tecnica, know how e sensibilità culturale dello specifico momento storico svolgono un ruolo fondamentale, che dobbiamo inserire lo sviluppo dell’arte greca nei secoli per comprenderne le costanti ricerche volte dapprima alla resa della figura umana, quindi del movimento, infine del movimento nello spazio.
La bronzistica fu continua applicazione e progresso; dobbiamo a sperimentazioni costanti e a successivi tentativi l’affermazione, nella Grecia del VI Sec. a.C., della statuaria in bronzo a fusione cava. Partendo dal metodo cosiddetto “diretto”, che consisteva nell’applicare la cera su un abbozzo di argilla prossimo nella forma e nelle dimensioni alla statua che si voleva realizzare, si arrivò nel corso del V Sec. a.C. al metodo “indiretto”, che permetteva di utilizzare una minor quantità di bronzo. La tecnica diretta, infatti, presentava l’inconveniente di richiedere uno spessore di cera piuttosto alto, sul quale veniva formata la statua, e, di conseguenza, una quantità notevole di bronzo. Con il metodo indiretto, utilizzato ancora oggi dalle fonderie artigianali, lo scultore partiva invece da un modello originale in argilla, già completamente rifinito nei dettagli, dal quale ricavava dei negativi o matrici, nei quali applicava a pennello uno strato sottile di cera; consolidata la cera, otteneva i positivi, che andavano riempiti con la “terra di fusione”, un miscuglio composto da terra unita a materie organiche, peli di animali, paglia, corda, che avevano la funzione di rendere compatta l’anima interna durante l’essiccazione e, bruciando durante la fase di liquefazione della cera, di mantenerla porosa ed elastica. A questo punto, come per le statuette di piccole dimensioni, lo scultore formava la camicia esterna d’argilla, posizionando nel contempo i “chiodi distanziatori” — conficcati nella cera fino a raggiungere il nucleo interno di terra, per tenerlo in posizione durante la fase di scioglimento dello strato di cera — e i “canali di colata”, per fare arrivare il metallo a tutte le estremità della statua; erano piccoli bastoncelli di cera che, liquefacendosi, lasciavano una rete di canali per l’entrata del metallo allo stato fuso. Una volta indurito il rivestimento esterno, si poteva procedere alla cottura dell’intera forma e alla liquefazione della cera, che lasciava il posto a un’intercapedine, vuota, tra il nucleo interno e la camicia esterna. Solo a questo punto si procedeva al getto del metallo.
Terminata la colata e raffreddato il metallo, lo scultore doveva prima di tutto eliminare la camicia esterna di argilla, e poi procedere alla ripulitura della superficie del bronzo, che si presentava scura, scabra e rugosa, e recava ancora attaccati i canali (ora diventati sbarrette metalliche) e i chiodi distanziatori. Con raschiatoi di varia forma, pietra pomice, ossi di seppia e con l’aiuto di tasselli della stessa lega, il bronzista era in grado di sistemare le imperfezioni e portare il metallo alla lucentezza voluta.
Nell’antichità era molto apprezzata la policromia, anche per le statue di bronzo; molti particolari, sia anatomici, sia legati alla caratterizzazione del personaggio raffigurato (elementi del vestiario, della corazza, armi, accessori) venivano inseriti in metalli o in leghe di colore contrastante per rendere più viva e realistica l’immagine. Anche la patina poteva essere sfruttata in questo senso. La patina è infatti la reazione del metallo, che è un composto instabile, agli agenti esterni; reazione che porta all’alterazione del colore originario, che da giallo oro può diventare verde, bruno, nero, blu con varie sfumature.
La patina piaceva agli antichi, che erano in grado di produrre anche patinature artificiali: Plutarco riporta che i visitatori del santuario di Delfi ammiravano il gruppo dei Navarchi, realizzato per commemorare la battaglia di Egospotami del 403 a.C., proprio per la particolare patina blu dei bronzi che faceva sembrare i personaggi delle creature del mare.
Il metodo indiretto costituì un’importante innovazione tecnica, perché permise l’esecuzione di statue di grandi dimensioni con una minore quantità di metallo e, grazie ai negativi, che potevano essere conservati in bottega, la produzione di più copie di una stessa statua.
Gli scultori ingaggiati per la realizzazione delle sculture, provenendo dalle varie regioni del Mediterraneo ellenizzato, operavano prevalentemente nei centri di maggiore consumo, com’è ampiamente documentato dalle dediche presenti sulle basi di statue ritrovate nei luoghi della frequentazione panellenica (specialmente Olimpia e Delfi) che ci restituiscono i nomi degli artefici più attivi e richiesti nella prima metà del V Sec. a.C. (prevalentemente egineti a Olimpia e argivi a Delfi). La pratica diffusa di apporre la firma sulla base delle sculture è già in sé indizio della piena consapevolezza che gli scultori avevano del loro ruolo sociale, destinato a crescere ulteriormente nei decenni successivi.
Esisteva una fitta rete di relazioni tra i committenti della grecità occidentale e le maestranze attive tra la fine del VI e la metà del V Sec. a.C. su suolo greco continentale, anche se non è sempre possibile leggere rapporti privilegiati. In alcuni casi, però, nella scelta delle maestranze la continuità della tradizione artistica, che è sottesa alla continuità di vita delle officine e dell’attività dei maestri in un determinato luogo, sembra prevalere su altri condizionamenti. Ne è prova, per esempio, il ricorrere a scultori argivi da parte di Taranto per la realizzazione dei donari delfici sia prima che dopo la svolta politica del 473 a.C., quando per la trasformazione della compagine sociale della città, seguita alla pesante sconfitta dei Greci a opera degli Iapigi, ci si sarebbe potuto aspettare un cambio di interlocutori anche sul piano artistico.
Su un diverso livello di lettura la documentazione (letteraria, epigrafica e archeologica) disponibile per la ricostruzione storica consente di dedurre informazioni sui meccanismi di produzione e sul grado di specializzazione degli ateliers degli scultori, capaci di far fronte a commesse impegnative che spesso erano duplicate anche in altri santuari e nella patria del dedicante. Nel caso delle statue bronzee ciò riveste una grande importanza poiché permette di dedurre che tra la fine del VI e i primi decenni del V Sec. a.C. era ormai avvenuta in tutto il Mediterraneo la diffusione del metodo indiretto della tecnica di fusione a cera persa. Questa tecnica, infatti, a differenza del metodo diretto, rendeva possibile la duplicazione da uno stesso modello. La ben nota kylix attica a figure rosse del “Pittore della Fonderia” conservata a Berlino, rappresenta una fonte di grande importanza poiché ci fornisce la più completa documentazione iconografica coeva del processo di produzione e del grado di specializzazione di un’officina di bronzisti greci dell’inizio del V Sec. a.C. impegnati proprio nella produzione di statue virili di grandi dimensioni.
Nel mondo antico la mobilità degli artisti tra le sponde del Mediterraneo è una caratteristica fondamentale della professione dello scultore. Ciò accadde per motivi strategici ma anche per motivi tecnici ed economici, legati alle laboriose fasi del processo produttivo di una scultura bronzea che poteva avvenire con minore dispendio economico nello stesso luogo di destinazione finale della scultura. Schiere di scultori viaggiarono tra una sponda e l’altra del Mediterraneo trasferendo la propria officina per esempio da Reggio a Olimpia (Pythagoras), a Delfi, ad Atene, con le conseguenze che questo avrà avuto nell’inevitabile e naturale interscambio tra formazione e produzione, tra contesti e linguaggi artistici di provenienza e di approdo, che caratterizza la diffusione dello stile Severo in tutto il mondo greco.
Al generale consenso accordato agli spostamenti degli scultori tra le sponde del Mediterraneo, si deve aggiungere ormai anche la tesi diffusa che a circolare fossero pure i modellini, riproduzioni di piccolo formato che servivano da prototipo e spunto. Tale prassi può ritenersi, in effetti, una costante del processo produttivo artistico nel mondo antico, e specialmente di quello greco, dall’età classica a quella ellenistico-romana.

I Bronzi di Riace seguirono il processo abituale: venne realizzata prima la parte centrale della statua, che comprendeva tronco e gambe, e poi tutte le altre parti separatamente, che venivano successivamente fuse al nucleo centrale. Non solo le braccia, la testa e i pezzi più grossi, ma anche i dettagli più piccoli: a un’analisi approfondita si è scoperto che anche i riccioli delle barbe e dei capelli del “Bronzo A” furono realizzati uno per uno e saldati singolarmente alla testa. Altri dettagli venivano eseguiti con colori diversi per rappresentare meglio il corpo umano: nei Bronzi di Riace per esempio i capezzoli sono in rame, così come le labbra; i denti (presenti in una sola delle due statue) erano d’argento; la parte bianca degli occhi, la sclera, era fatta con pietre chiare (avorio e calcare), l’iride con una pietra colorata.
Nelle città greche uscite vittoriose dalle Guerre Persiane era frequente l’esaltazione degli antenati o fondatori della città attraverso statue singole e in gruppo. Le statue venivano esposte principalmente in santuari, in collezioni private, oppure nelle agorà, le piazze delle città greche in cui illuminavano in modo spettacolare il resto del paesaggio, per effetto dei raggi del sole.
Secondo l’interpretazione prevalente, i Bronzi di Riace viaggiavano su una barca proprio per essere esposti come opere d’arte: dopo la conquista della Grecia da parte dei Romani (II Sec. a.C.) furono moltissime le opere che fecero lo stesso tragitto — dalla Grecia a Roma — per finire in luoghi pubblici o nelle collezioni di imperatori, senatori e altri romani facoltosi.
Le immagini del periodo “classico” mostravano movimento controllato e armonia tra tensione e rilassamento. Per questo effetto veniva utilizzato il contrapposto: una posizione rilassata e naturale che porta il peso su una gamba in modo che l’anca opposta sia sollevata per produrre una curva rilassata nel corpo.
La schiena è leggermente curva in quella posizione. Venivano presi in considerazione diversi punti di vista: un’immagine poteva essere ammirata da tutti i lati, non era più pensata per essere fruita solo da una posizione frontale, come nella scultura più arcaica. Durante questo periodo, l’arte greca raggiunse il suo apice. La scultura classica è nota per la sua flessibilità e lo studio completo della rappresentazione del movimento. L’armonico connubio tra l’energia del movimento e la maestosità della figura segna il momento in cui l’età dei grandi classici supera il periodo “arcaico”.
La pietra miliare più significativa di questo passaggio è forse la creazione del “Cronide di Capo Artemisio”, la statua di Poseidone o Zeus (da qui, nell’incertezza, il nome Cronide, ossia “figlio di Crono”: lo erano entrambi), risalente al 490/470 a.C., ritrovata nel 1926 nei fondali marini antistanti Capo Artemisio, nell’odierna Eubea, nei pressi di un relitto databile intorno al 200 a.C., ennesima nave romana affondata in un naufragio, forse destinata ad arricchire le collezioni reali di Pergamo. Delle sculture del periodo classico sopravvissute fino a noi, la più conosciuta e meritatamente famosa è comunque quella del Discobolo di Mirone (455 a.C., praticamente contemporaneo al “Bronzo A”), che è l’incarnazione perfetta del modello di atleta ideale immaginato dagli antichi greci. Questa statua raffigura il giovane atleta in procinto di lanciare il disco: si può apprezzare la tensione di tutte le parti del corpo che precede lo scatto vero e proprio. Il perfetto equilibrio fisico deve rispecchiare il valore morale dell’atleta stesso, disposto ad andare oltre i propri limiti ed esaltare le proprie virtù.
Le grandi realizzazioni artistiche avvenivano per commissione da parte della comunità religiosa o statale, tuttavia in Grecia il privato cittadino, che concepiva l’arte come offerta in onore degli dèi o dei defunti, poteva investire le proprie pur modeste risorse per dedicare opere nei santuari, mentre nelle civiltà orientali l’iniziativa dei privati nel campo dell’arte rimase del tutto sconosciuta. Le statue testimoniavano della continua presenza del devoto, benché slegate da ogni riferimento personale restando concepite secondo una tipologia astratta, quella del kouros (figura umana maschile nuda e stante, idealmente priva di azioni e di attributi simbolici) o della kore (corrispondente femminile dei kouroi). I temi erano gli stessi che venivano svolti nelle altre arti — la figura umana, il mito e le scene di vita quotidiana —, mentre la rappresentazione delle battaglie storiche avveniva in prevalenza tramite i racconti mitici e solo raramente in modo diretto, come invece avveniva presso Egizi e Assiri.
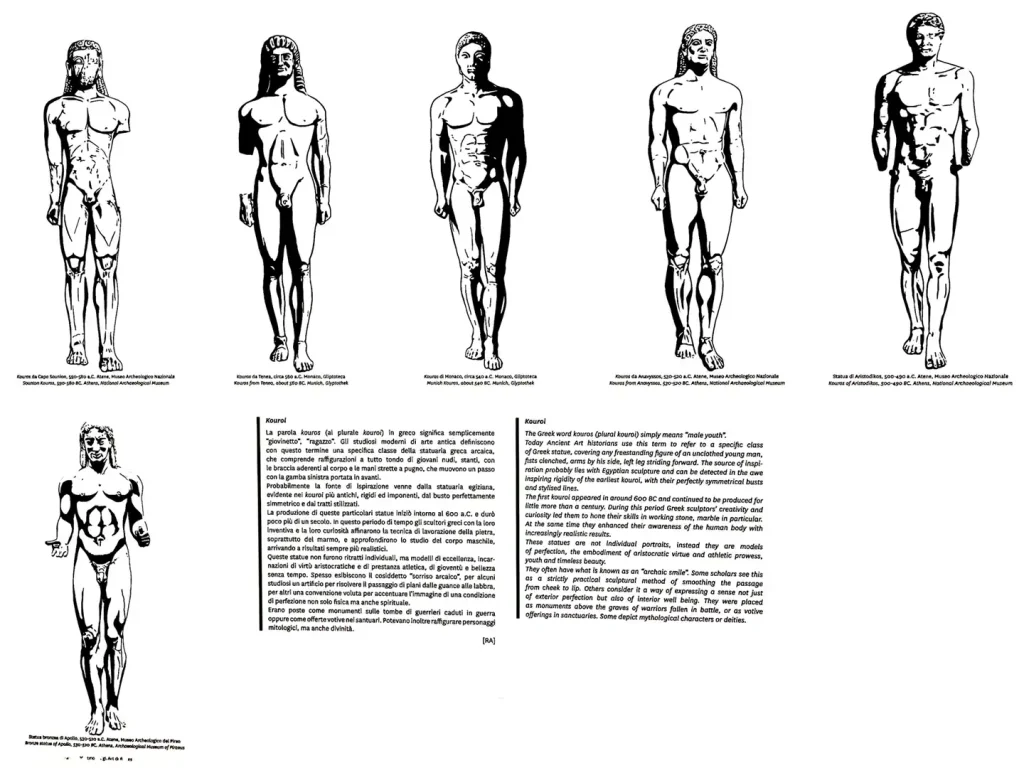
La statua, in nudità eroica, è in posizione stante, benché presenti la gamba sinistra avanzata, ad accennare un passo, unico segno, anche se tenue, di movimento. Ulteriore fatto caratterizzante i kouroi sono le braccia addossate al corpo, che terminano con pugni chiusi. Risalta sul volto il cosiddetto “sorriso arcaico”, appena accennato; i primi studi dedicati all’argomento mettevano in relazione il sorriso con la pace interiore del soggetto della statua facendo prevalere interpretazioni di tipo psicologico; in seguito l’impiego del sorriso venne ricondotto principalmente all’incapacità degli scultori di rendere realmente curve le superfici e quindi a problematiche di tipo tecnico: la curvatura delle labbra portava ad arrotondare tutte le fattezze facciali e particolarmente quelle della bocca stessa e degli occhi. Inoltre la figura del kouros greco è idealizzata non proponendosi alcun intento naturalistico di tipo imitativo, anche se vi si nota nelle articolazioni inferiori una maggiore attenzione alla muscolatura.
I vari Mirone, Policleto, Fidia, Pitagora di Reggio, Skopas, Prassitele e Lisippo esaltano la perfezione della muscolatura e studiano accuratamente l’armonia e la proporzione fra le parti del corpo. Le divinità hanno forma umana, il corpo è rappresentato nel pieno della giovinezza e del vigore, il quale comunica l’idea di una bellezza perfetta e immortale.
In più, in base a Plinio sappiamo che per i Greci non era da tutti godere di una statua somigliante:
Non si soleva rappresentare l’umana effigie se non di coloro i quali avessero meritato l’immortalità per qualche illustre cagione, in primo luogo per la vittoria delle sacre gare, massimamente d’Olimpia; dove di tutti i vincitori era uso dedicare le statue, e di quelli poi che avevano vinto tre volte, le statue riproducevano la somiglianza delle membra: le chiamano iconiche.
Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia” XXXIV.16
È solo dal III Sec. a.C. in avanti che l’ideale dell’uomo greco “perfetto” viene abbandonato: ci si allontana dalla bellezza e le immagini riproducono anche i difetti fisici; i corpi rappresentati non sono più solo quelli giovani e atletici. Si sviluppa la ritrattistica per tramandare il volto degli uomini illustri.
Alla luce di tutto questo, è arduo sostenere l’idea che soltanto i due Bronzi di Riace, già nel V Sec. a.C., fra le opere idealistico-astratte — tutte dedicate a miti o ad atleti vincenti — del periodo Severo e Classico fossero la “fotografia” di celebri personaggi politici del loro tempo (Pericle e Temistocle).
Mi si consenta una boutade. In pratica, la teoria prende inconsapevolmente spunto da Senocrate di Sicione (i cui trattati furono la fonte di Plinio il Vecchio per la scultura), secondo il quale i Greci, con la mimesis, inaugurarono l’imitazione della realtà: non conoscendo le possibilità dei sali d’argento — Niépce, Daguerre, il cloruro d’argento e l’alogenuro d’argento sarebbero arrivati oltre due millenni dopo —, per questa primitiva fotografia usavano il bronzo…
Da un lato, è vero, abbiamo Pausania il Periegeta che cita le statue sia di Pericle che di Temistocle, e soprattutto vediamo sulla testa del “Bronzo B” il classico copricapo (kynê) dei comandanti militari — il che ci dice che potremmo essere in presenza della raffigurazione di un primario personaggio storico; dall’altro tuttavia abbiamo una sterminata produzione di dèi, miti e atleti olimpici che occupa quasi interamente il panorama delle (non molte, ma statisticamente significative) sculture sopravvissute fino alla modernità. C’è inoltre la testimonianza di Demostene nel IV Sec. a.C., in anticipo di 4 secoli su Pausania, Plutarco, Erodoto & C., che esclude la presenza ad Atene di statue quantomeno di Temistocle: se è vero come è vero che il “Bronzo A” fu realizzato a metà del V Sec. a.C. nella zona del Peloponneso orientale, e respingendo l’idea che potesse passare inosservato, o non è Temistocle, o se lo è allora non era stato realizzato ed esposto ad Atene, Argo e dintorni. Improbabile. Più probabile che le statue di Pericle e Temistocle viste da Pausania (e dagli altri autori) fossero opere successive, di periodo ellenistico.
L’argomento “scoliosi” e “iperlordosi” appare pretestuoso, e può benissimo essere lasciato da parte, poiché le testimonianze di queste caratteristiche anatomiche non riguardano solo i Bronzi di Riace ma numerose altre opere — la postura è con tutta evidenza una questione stilistica, perdipiù in un’epoca in cui le conoscenze scientifiche erano quel che erano.
E anzi a questo proposito, paradossalmente, è possibile che uno di questi fantomatici “difetti”, il varismo al 5° dito del piede, segnali come autore del “Bronzo B” il celebre Policleto: anche la copia romana in marmo del suo Doriforo presenta identico varismo — a dirla tutta, i piedi del Doriforo e del “Bronzo B” paiono identici (cfr. foto successive) —. Mentre i piedi del “Bronzo A” non hanno difetti anatomici.
I “tenoni” ai piedi dei due Bronzi ci dicono che, in un dato momento, fecero parte della medesima… expo d’antan. Ma nemmeno questi costituiscono argomento decisivo sull’identità delle due statue.
Da ultimo — ma nozione fondamentale ben nota a chi mastichi anche solo un po’ di storia dell’antica Grecia —, c’è un evidente anacronismo sfuggito all’autore della tesi. Contrastato nel suo programma politico e sospettato di atteggiamenti tirannici, Temistocle fu ostracizzato ed esiliato da Atene nel 472 a.C. e qualche anno dopo condannato a morte anche dagli Spartani; fuggì prima in Magna Grecia, poi venne accolto dal re Artaserse I di Persia. Alla fine trovò dimora a Magnesia, dove morì in date e circostanze sconosciute, secondo molti suicida per non aver tenuto fede alle promesse fatte al re persiano. Era dunque un rinnegato, in fuga dalla Grecia e condannato a una generale damnatio memoriae del resto confermata da Demostene: com’è possibile che già nel 460 a.C. (data di realizzazione del “Bronzo A” che raffigurerebbe Temistocle) qualcuno gli abbia dedicato una statua in bronzo?
Ovviamente — ça va sans dire — sia la Teoria 1 (Eteocle & Polinice o Tideo & Anfiarao, proff. Castrizio/Moreno) che la Teoria 3 (Pericle & Temistocle, Partinico) si interfacciano senza attriti a una buona parte della Teoria 2 del prof. Roma (Bronzi rinvenuti presso una struttura oggi non affiorante, ossia i resti dell’antico porto di Kaulon, identificati da tempo immemore dalla popolazione locale come lo “Scoglio dei santi Cosma e Damiano”), che spiega cosa poté avvenire secoli dopo l’arrivo in Calabria. E dunque che i Bronzi di Riace fossero indifferentemente Eteocle e Polinice oppure Pericle e Temistocle (o chissà chi altro ancora!), arrivati una prima volta nella Locride, con una nave romana naufragata oppure al seguito della Gens Casinia della Villa Romana di Casignana, e adorati come Castore e Polluce (per poi venire di nuovo occultati durante i momenti più bui del Medioevo, “seppelliti ordinatamente in acqua”), con l’avvento del cristianesimo finirono in ogni caso per essere venerati come i santi Cosma e Damiano.

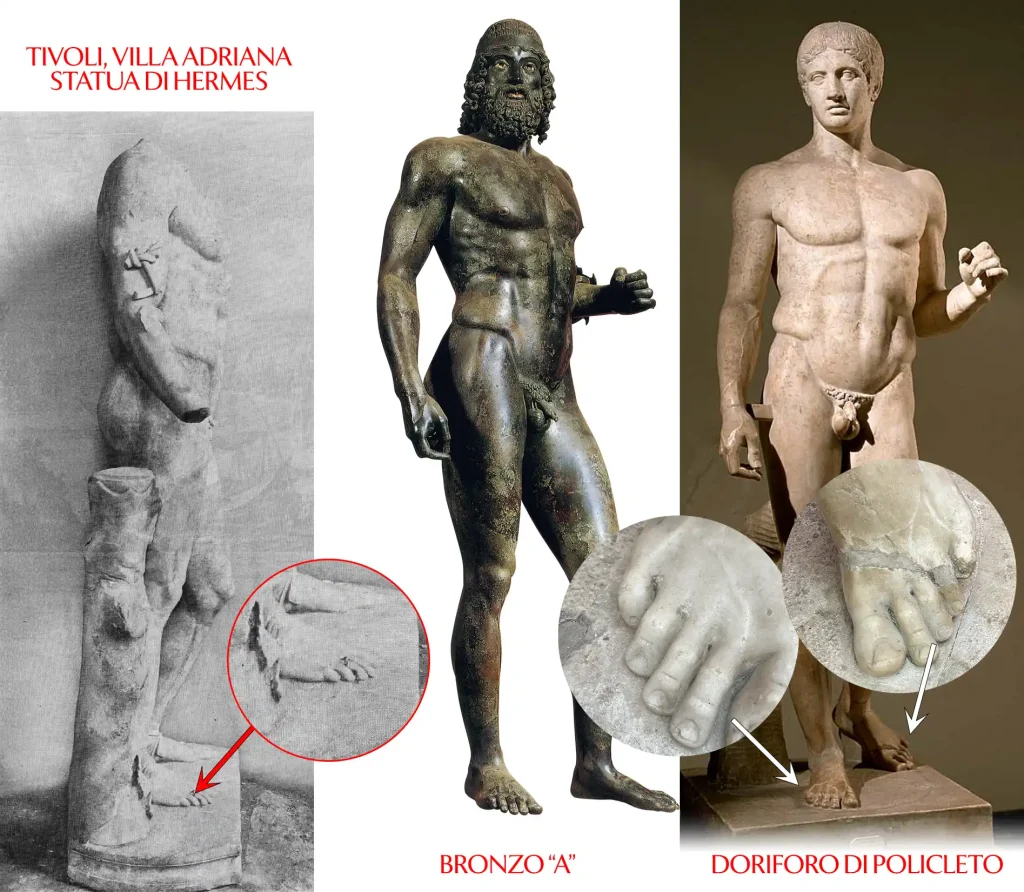


EXCURSUS 1 / DECISIVI OGGETTI PERDUTI
I luminari del settore e i massimi esperti mondiali di Grecia antica hanno un’altra visione del modo di risolvere l’enigma dell’identità dei due Bronzi di Riace. E sebbene tuttora lontani anch’essi dall’effettiva soluzione (peraltro, senza saper nemmeno spiegare perché e da quanto tempo si trovassero nei bassi fondali della costa calabrese), val la pena approfondire questa loro prospettiva, non foss’altro perché ricca di dettagli interessanti e caratterizzata da una solida congruità di analisi, tipica di studiosi che nel formulare le loro ipotesi adottano con rigore il metodo scientifico.
La forma della testa del “Bronzo B”, con buona pace della tesi di Partinico sul cranio dolicocefalico, presso gli accademici non lascia dubbi di sorta sulla presenza originaria di un elmo. Ma anche il “Bronzo A” era dotato di elmo. La “tenia”, ossia la benda, presenta infatti due fori per chiodi, in alto e in basso, a partire dal punto nel quale sull’orecchio sinistro fu fatto violentemente saltare un ricciolo. Inoltre è consumata, come consumato appare il dorso superiore dei grossi riccioli che, fortemente rigonfi, scendono sulle spalle da un orecchio all’altro. Se a ciò aggiungiamo che alla sommità della calotta cranica il bronzo presenta un foro circolare entro cui fu colato del piombo, al centro del quale si ebbe cura però di risparmiare una profonda cavità a sezione quadrata, allora la spiegazione di questi dati di fatto non può che essere una e una soltanto. Il “Bronzo A”, come poi l’«Ares/Teseo» di Villa Adriana e certamente il “Bronzo B”, portava un elmo a paragnatidi a metà alzato sulla testa, il cui paranuca era stato saldato e poggiava — gonfiandoli così come mai avrebbe potuto fare una benda — sui ricchi capelli che scendevano sulle spalle, e che era stato fissato, sul lato destro, con i due chiodi di cui restano i fori nella benda e, alla sommità del capo, mediante un perno. Questo era stato saldato all’elmo a una estremità e incastrato con l’altra nella mortasa riservata nel piombo versato all’interno della testa attraverso il foro che era stato risparmiato a tale scopo al momento della fusione.
Questa “tenia”, poi, non va intesa come benda dell’eroe e neppure benda del vincitore, ma è da considerare ancora un significativo tratto di realismo voluto dall’artista. Essa è in effetti la larga, semplice fascia di lana che proteggeva la testa dall’elmo, come sappiamo dalle immagini conservate dai coevi vasi attici a figure rosse di oplitodromi che la portano mentre si esercitano nella palestra. Immagini che ci attestano poi con larghezza e in perfetta concordanza con le fonti come gli oplitodromi fossero scelti fra gli uomini adulti e perciò essi appaiono spesso rappresentati con ricca barba, oltre che provvisti di fluenti capelli, come era di moda ad Atene proprio negli anni intorno al 460 a.C..





L’oplitodromia era un’antica disciplina di corsa, una vera e propria “corsa armata”, parte dei Giochi Olimpici e di altri giochi ellenici, ultima aggiunta tra le gare di corsa a partire dalla 65ª Olimpiade nel 520 a.C.. A differenza delle altre corse generalmente disputate da atleti nudi, l’oplitodromia imponeva ai corridori di indossare gli schinieri, l’elmo e lo scudo pesante (hoplon), da cui la traeva il nome la classe di fanteria degli opliti. Dal 450 a.C. la pratica di indossare gli schinieri (quella parte dell’armatura che protegge parte della gamba, dal malleolo al ginocchio e che serviva per proteggere la parte che rimaneva al di fuori dello scudo) cadde in disuso, ma scudo ed elmo furono mantenuti. Nel 450 a.C., in accordo con questa parte di studi, il “Bronzo A” esisteva da circa un decennio: sulle sue gambe però non ci sono tracce delle presenza di schinieri. E dunque di entrambi i Bronzi sono andate perdute con certezza “soltanto” tre cose: lo scudo, l’elmo e l’oggetto — qualunque cosa fosse (una lancia?, l’alloro e/o la palma del vincitore?) — che tenevano nella mano destra.
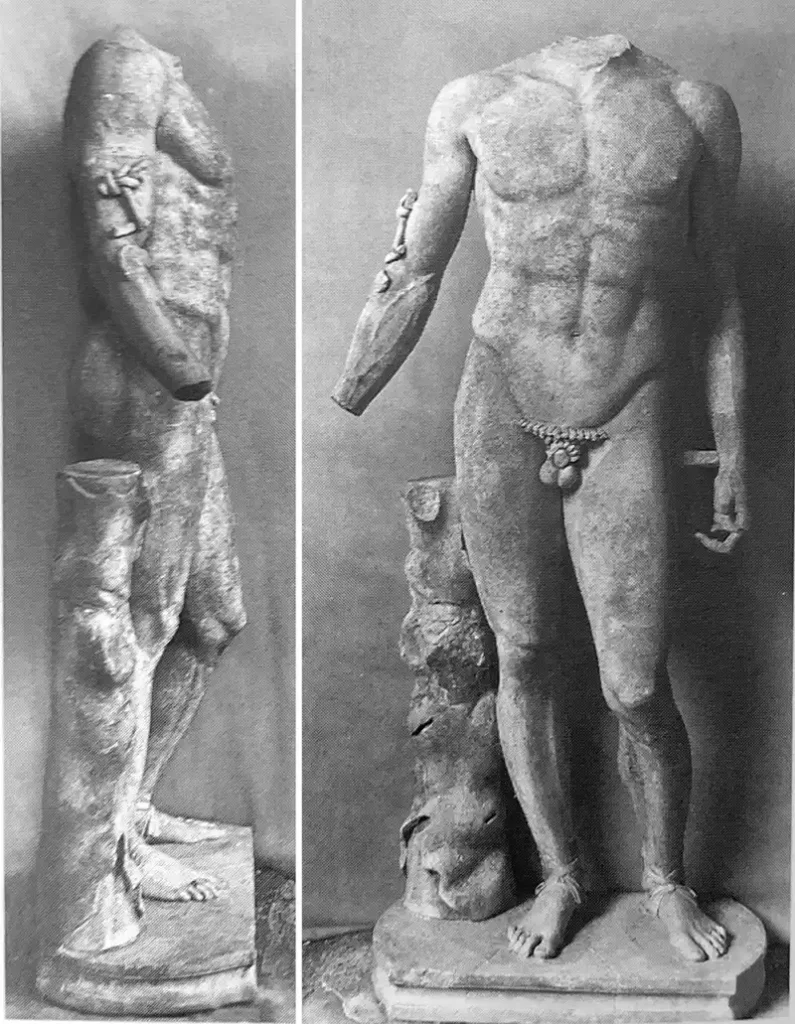
A parere di molti esperti, storici e critici dell’arte greca antica (Di Vita, Odo Pavese, Berger, Minakaran-Hiesgen, Raeder, Hölscher), le due statue di Villa Adriana vanno identificate in Teseo (al posto di «Ares»), eroe attico inventore degli agoni panatenaici e atleta vincitore egli stesso, e appunto Hermes, da sempre protettore di ginnasi, di palestre e di atleti. Ed entrambi nella mano destra (oggi vuota nel Teseo/Ares e mancante nell’Hermes) reggevano il ramoscello di alloro dei vincitori di gara.
Paolo Moreno basa parte della propria “teoria Tideo-Anfiarao” con autori Alcamene-Agelada proprio sulla forte somiglianza con l’Hermes, il cui originale bronzeo è a suo parere da attribuire ad Agelada.
La mano destra di entrambi i Bronzi di Riace, coevi (sia storicamente che artisticamente) delle due statue di Villa Adriana, è atteggiata allo stesso modo. E per motivi “tecnici” (dimensioni, incongruenza di attacchi, etc.) queste mani destre non avrebbero potuto tenere né una lancia e neppure una spada. Come fa notare Antonino Di Vita (1926–2011), il grande archeologo italiano direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene dal 1977 al 2000:
Ma soprattutto non è questa la maniera d’impugnare una spada o una lancia, ed è fuori da ogni realtà che un’arma offensiva, qualunque essa fosse, potesse essere tenuta da, diciamo, guerrieri così possenti ed eroici con tocco tanto leggero fra l’indice e il medio, in una mano dalle dita semiaperte e con un gesto di presa tanto molle! Né reggevano certo un’arma l’efebo di Via dell’Abbondanza o l’Apollo “citarista” e l’Apollo Philesios di Pompei, oppure il piccolo bronzo parigino replica del Discoforo di Policleto, i quali presentano una mano atteggiata alla stessa maniera, in cui, poi, il bronzetto pompeiano del tipo Philesios tiene ancora un ramo di alloro.

Ecco che dunque i due Bronzi sarebbero sì “guerrieri” ma nel senso di vincitori di oplitodromia, la gara che come detto si usò correre dal 520 a.C. in poi nelle grandi feste panelleniche. E mentre con la mano sinistra stringevano la correggia di cuoio (di cui restano tracce nel “Bronzo A”) dell’antilabé del grande scudo argivo che tenevano imbracciato e che li caratterizzava come oplitodromi, nella mano destra reggevano un ramoscello d’ulivo o di alloro, verosimilmente in argento, simbolo della loro vittoria.
Come dimostrò il grande grecista Antony Raubitschek (1912–1999):
Nell’Atene post-480 i vincitori di gare panelleniche e soprattutto panatenaiche, onorati di statua, come allora era venuto in voga, ebbero sempre o quasi rilevanza politica, e, una volta politici, non potevano farsi raffigurare — per l’odio verso il culto della personalità dominante l’Atene pre-Pericle — altro che sotto la specie da tempo “religiosamente legittimata” dell’atleta vincitore, il quale con la sua vittoria riportata in agoni internazionali ha dato lustro alla città e ha reso sé stesso famoso e popolare.
Il rapporto fra religione e agonistica nella Grecia antica fu assai più stretto e pregnante di quanto generalmente si pensi, tanto che Pausania (V.10.1) poteva mettere sullo stesso piano i misteri di Eleusi e gli agoni di Olimpia.
Di tali ramoscelli restano probabili tracce dell’attacco tanto sul braccio destro della “Statua A” quanto, più vistosi, su quello corrispondente della “Statua B”.
Nella A, il profondo incasso nella seconda falange del dito medio sul lato verso l’indice, parrebbe mostrare che una fronda minore usciva verso il basso, fra indice e medio, e assicurava così una perfetta tenuta del ramo, il cui tronco sottile risaliva poi nella mano, incassato nella seconda falange di anulare e mignolo e nelle eminenze tènar e ipotènar alla radice di quest’ultimo. La superficiale scanalatura (profonda 1 mm) che si segue dal polso per 15 cm sull’avambraccio sarebbe la traccia dell’appoggio o del bastone del ramo stesso o di una appendice che serviva a fissarlo meglio, mentre le fronde fuoriuscivano dalla mano verso l’avanti e il basso.
Nella B, l’attributo passava in una sorta di guaina di piombo del diametro interno di 22 mm. Qui si ipotizza che una fronda piccola scendesse fra indice e medio, mentre, attraversata la mano nella guaina, il bastone del ramo piegava leggermente e risaliva sull’avambraccio e quindi sul lato esterno del braccio ove in effetti resta una scanalatura (così superficiale come quella notata nella A) lunga, sull’avambraccio, di 17 cm, e, sul bicipite, di 7,5 cm. Vale a dire che questo bastone lungo e sottile aveva all’incirca lo stesso andamento e doveva apparire, mutatis mutandis, come il kerykeion dell’«Hermes» di Villa Adriana, mentre le fronde erano rivolte, in maniera naturale, anche qui verso il basso e l’avanti. Antonino Di Vita conclude che non vi sia motivo di supporre che nell’antichissimo restauro non si sia ricopiato fedelmente anche l’attributo originario.
Insomma, a parere di una schiera di molti grandi nomi degli studi grecoantichi, artisticamente, fisionomicamente e storicamente “il Giovane” appare molto verosimilmente come la celebrazione di un oplitodromo vincitore, e se è così non v’è ragione di credere che non lo sia anche l’altro Bronzo.
Ossia, i Bronzi di Riace non raffigurerebbero Eteocle e Polinice né Pericle e Temistocle, ma sconosciuti vincitori di gare olimpiche/panatenaiche.
Tuttavia c’è un elemento che mal si raccorda con questi ragionamenti: la presenza della kynê sul capo di “B”. Se fosse un atleta vincitore di gara, non dovrebbe indossare un simile segno di comando.
Se accettiamo il dato delle figure di atleti, questi «sconosciuti vincitori» potrebbero non essere nemmeno così sconosciuti… Lasciamo per un attimo gli oplitodromi nel campo dell’illazione. Sappiamo che lo scultore Pythagoras reggino realizzò diverse statue di atleti olimpici, fra le quali il pugilatore Eutimo di Locri per le multiple vittorie conseguite nei giochi dal 484 al 472 a.C. (cfr. Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” VI.6.2): come già ipotizzato dall’archeologo e storico dell’arte greca Sandro Stucchi nel 1986 e dallo stesso Daniele Castrizio nel 2000, per coincidenza di epoche e di autore, raccordandoci alla nozione che qualsiasi atleta vincitore (a maggior ragione un pugile pluriolimpionico) veniva iconograficamente “eroizzato” come qualsiasi altra divinità o mito, e dunque veniva ritratto come un oplita, allora anche il boxeur Eutimo rientra pienamente in gioco come credibile candidato per il soggetto raffigurato nella “Statua A”. Non solo, ma essendo triplice vincitore, stando a Plinio e Callimaco la statua gli somiglierebbe pure.
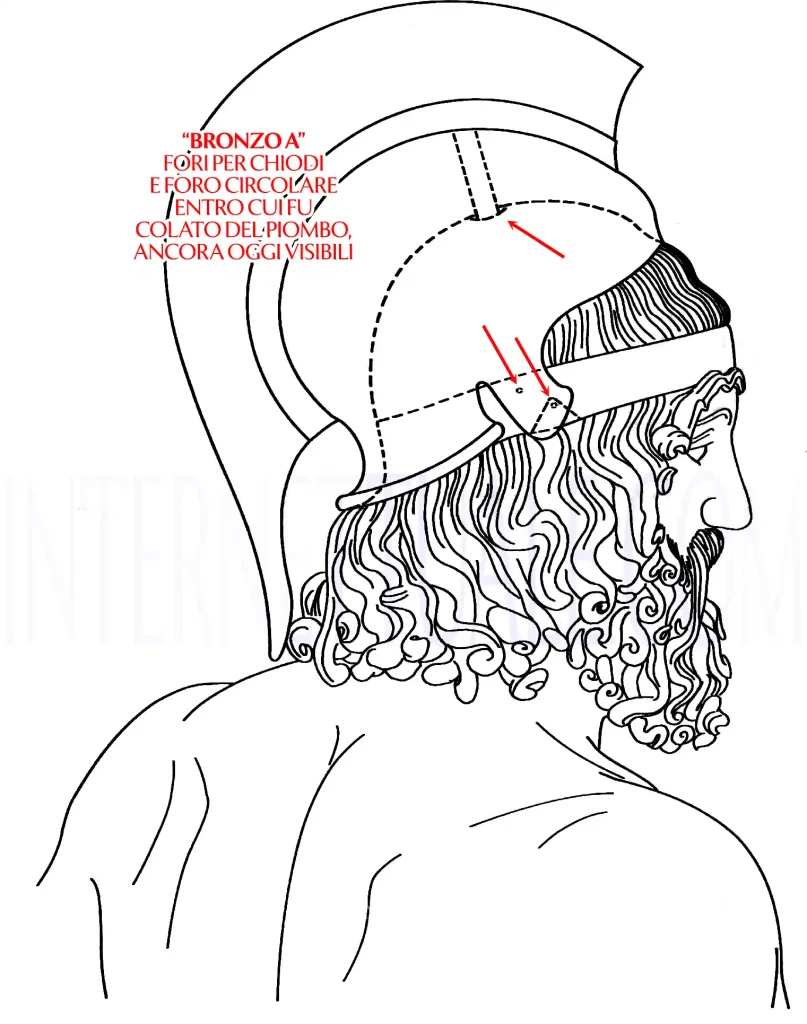
E infatti già Stucchi medesimo non era d’accordo con l’oplitodromo in fase di premiazione, né tantomeno con un oggetto che fosse diverso dalla lancia — sebbene anche lui cada nello stesso errore del giavellotto compiuto poi da Moreno:
La statua era dotata di un terzo attributo, tenuto con la mano destra. L’apprestamento perfettamente circolare tra le dita e il palmo della mano e l’alloggiamento lineare, anch’esso a sezione circolare, sul polso, nonché l’incasso nella seconda falange del dito medio sul lato verso l’indice non possono concedere la presenza di una spada col fodero voltato verso l’alto, né di un ramoscello d’olivo. C’è però un altro fatto che va rilevato: il turgore del bicipite, che, con il braccio abbassato, è del tutto incongruente se non si ammette che il braccio stesso non regga un non indifferente peso, quale certamente non è un ramoscello o qualcosa del genere.
Il braccio doveva dunque sostenere qualche cosa di pesante che è stato indicato in un’asta. La presa della mano è forte e sicura e a essa concorrono, ben stretti attorno all’attrezzo, mignolo, anulare, medio e pollice, che si oppone a quest’ultimo. Solo l’indice non partecipa a questa manovra, staccato com’è dal medio e tenuto semiaperto.
Nella scelta del genere dell’asta a sezione cilindrica va dunque tenuto conto, oltre che dall’atteggiamento della mano e di quello del braccio, anche di un certo peso che essa doveva avere. Tra un semplice scettro e un’arma da getto, un giavellotto, è quindi sicuramente preferibile l’ultimo. La sicurezza ci è data chiaramente da due dati: la posizione del dito indice e la presenza sulla parte interna della sua prima falange di un forellino per il fissaggio di un elemento. Un altro foro, più grande, sul dito medio, tratteneva il perno di fissaggio del giavellotto.
Posizione e atteggiamento dell’indice e posizione del foro si accordano per suggerire la presenza di un’αγχυλη, di un laccio particolare, nella cui ansa si infilava l’indice. L’αγχυλη non era che una funicella di pelle avvoltolata attorno alla metà dell’αχοντιοχ, la pesante arma da lancio degli opliti. Sappiamo dalle fonti classiche, per quanto si riferisce all’arte della guerra, che l’ankyle veniva sistemata immediatamente prima dell’uso dell’akóntion. Possiamo quindi essere sicuri che la figura del guerriero della “statua A” era in atteggiamento di “pronti” alle armi. Un simile atteggiamento lo troviamo raffigurato in una coppa a figure rosse di stile severo a Bruxelles.
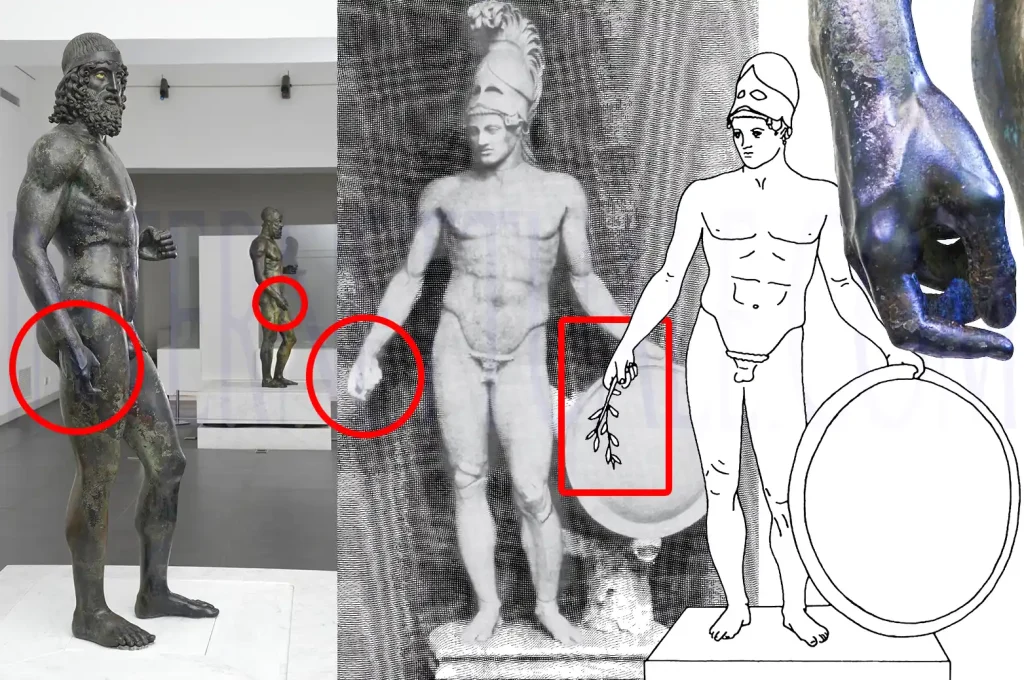
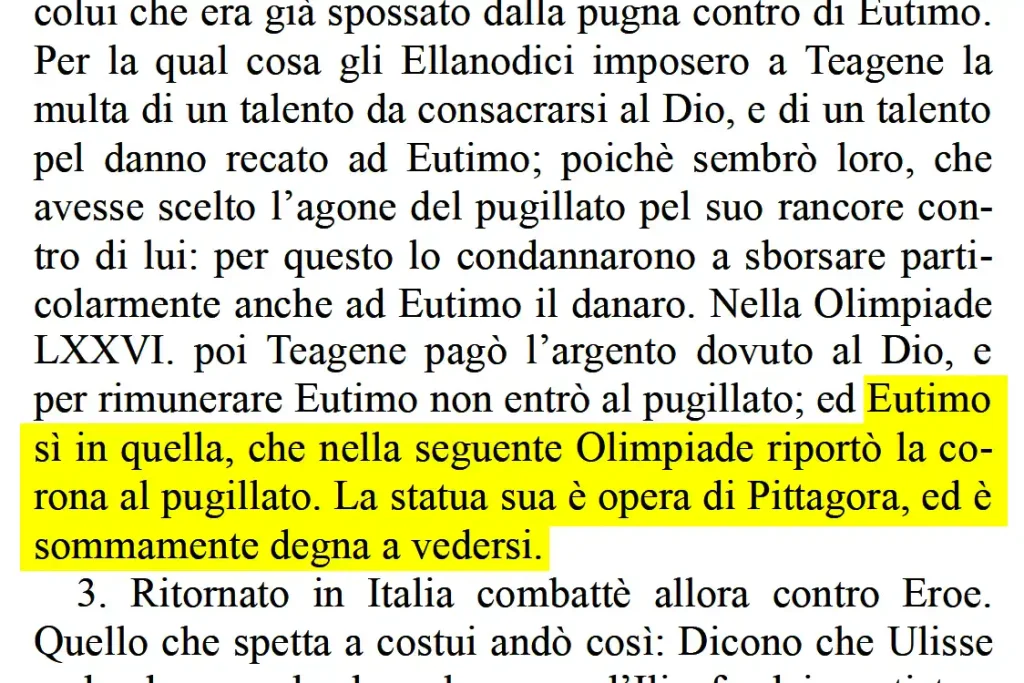
EXCURSUS 2 / INPUT DI COSTANTINO, O PIUTTOSTO SACCHEGGIO?
La tesi su un trasporto ordinato dall’imperatore Costantino nel IV Sec. d.C. viene messa un po’ in crisi dai rilievi e dalle scoperte effettuate dagli studiosi.
Sono osservazioni che sembrano realmente da porre in rapporto con l’inizio della “morte” dei due Bronzi per il mondo antico. Si tratta della violenza adoperata per asportare alcuni attributi, che verosimilmente portò alla caduta anche del grosso ricciolo che copriva l’orecchio sinistro della “Statua A” e alle scheggiature lungo il margine della fossa al centro dei globi oculari di avorio della stessa statua, che si spiegano bene con lo strappo delle iridi e delle pupille in pietre evidentemente ritenute preziose. Segni palesi di un inizio di rapina furiosa subìto perlomeno dalla più ricca e “impressionante” delle due statue, la “A”, ma quasi certamente da entrambe, poco prima d’essere rimosse dalle loro basi per sempre. Questo strappo ha tutta l’aria d’essere avvenuto nel corso — o come conseguenza — di un’azione violenta (non di un amaro ma pacifico ordine imperiale, per esempio), le cui tracce ci sono state conservate evidenti nei piccoli e grandi danni alla “Statua A”.
E fu solo l’ultimo dei saccheggi cui non solo i Bronzi ma tutte le migliori opere d’arte furono oggetto.
È noto che i traffici di opere greche verso l’Italia cessarono con la fine del I Sec. d.C., al termine di quasi tre secoli di razzie. Notevoli in particolare le distruzioni causate nell’agorà di Atene dall’armata di Silla nell’anno 86 a.C.: le statue furono dapprima spogliate dai soldati dei loro materiali preziosi, quindi vennero rimosse dalle loro sedi — perlomeno quelle che erano sopravvissute e/o non avevano subito danni irreparabili — per mandarle in Italia, insieme a numerose altre antichità di Atene. A documentare la spoliazione, le tracce di scalpello che si conservano sui plinti recuperati dagli archeologi moderni, intorno alle cavità dove le statue erano legate mediante bronzo e piombo al plinto, poiché ci indicano, senza dubbio, un’operazione di prelevamento cauto. E siccome la fine dell’agorà antica avvenuta nell’anno 267 d.C. per mano degli Eruli fu solo una barbara distruzione, non rimane altra possibilità che il prelevamento delle statue ateniesi sia stato effettuato in periodo sillano.
Inoltre, il fatto che le due figure siano tanto simili nell’atteggiamento parla a sfavore dell’ipotesi che facessero originariamente parte di un unico complesso composto di molti elementi. Era già, dal punto di vista estetico, così difficile evitare la monotonia ripetitiva in un insieme di sculture poste in fila, come di regola sulle lunghe basi votive ritrovate per esempio nei santuari greci, che — come il gruppo di Daochos II a Delfi mostra con buona evidenza — gli artisti cercavano di variare il più possibile atteggiamento e attributi dei personaggi rappresentati, il che serviva anche a individualizzarli visivamente ancora prima che con le iscrizioni. I Bronzi di Riace potrebbero essere finiti insieme in un momento assai diverso dalla realizzazione, e non sappiamo (né forse mai sapremo) dove e perché.
Se si tiene presente che l’elevato tenore di piombo (3,396%) e tracce di cobalto risultati dalle primissime analisi del “Bronzo B” ricorrono anche nel campione prelevato dall’imbracciatura dello scudo della “Statua A”, non è azzardato supporre che quando il “Bronzo B” ebbe rimpiazzati il braccio destro nella sua interezza e l’avambraccio sinistro con il suo scudo, qualche danno o cedimento mostrava, perlomeno nell’imbracciatura dello scudo, anche la “Statua A”, e che il lavoro di restauro, importante nell’una, di puro e semplice consolidamento nell’altra, avvenne con ogni probabilità nello stesso tempo e nello stesso luogo, se la partita di rame adoperata fu, come sembra, la stessa.

Questione di stile
Il ricco studio di Odo Pavese del 1983
Il diavolo si nasconde nei dettagli, disse qualcuno. E se perfino il celeberrimo Carbonio 14 lascia un certo margine di errore, lo stesso non si può dire delle comparazioni artistiche, che vanno a fondo con maggiore precisione perfino dei più decantati esami chimici. Come avviene per la datazione dei due Bronzi di Riace in base alle comparazioni stilistiche.
Così articolava per esempio Carlo Odo Pavese (1933–2020, un altro udinese), illustre grecista e studioso di fama internazionale, in uno dei primi e più celebri studi apparsi sulle due opere dopo il restauro iniziale a Firenze (1975–1980) con successiva esposizione al Quirinale per volontà di Sandro Pertini.
Il clima politico di esaltazione nazionalistica e di rinnovamento politico (fine delle Guerre Persiane, sconfitta dei “barbari” persiani e cartaginesi, nascita dell’Impero Ateniese; nascono anche la tragedia e la prima scuola di medicina, e l’interesse per fenomeni naturali e celesti) influenza l’ambiente artistico: nel campo dell’architettura vengono privilegiati i lavori di ristrutturazione e di difesa mentre nelle arti figurative viene ulteriormente studiata la ponderazione — ossia il movimento e l’organicità delle forme —, le statue non sono più dimostrazioni di valori aristocratici ma rappresentano la potenza delle poleis greche. Per “stile Severo” si intende la produzione artistica precedente alle opere mature di Fidia, quindi all’incirca 480–450 a.C., e il termine ne traduce le caratteristiche di rigidità e austerità. Vengono eliminati i virtuosismi decorativi e messo a punto un nuovo linguaggio figurativo: vengono effettuati i primi tentativi di introspezione, l’uomo inizia a essere ritratto come un “essere pensante”. La statuaria abbandona progressivamente l’assialità arcaica, il peso delle membra è ormai distribuito su tutto il corpo.
Nel tema della statua maschile nuda stante, l’intento artistico fondamentale è quello di trovare il mezzo migliore per esprimere la forza, la bellezza e la vitalità del corpo umano atleticamente sviluppato. Il proposito è del tutto primitivo e fondamentale. Mentre la figura in movimento esprime con ciò stesso la propria vitalità, la figura stante in riposo necessita di qualcosa affinché questa le venga istillata.
Il kouros arcaico sprizza dal suolo, opponendosi alla gravità in perfetto equilibrio bilaterale, con una uniforme tensione dei suoi muscoli: con questo mezzo egli mostra di essere forte e vigoroso.
Nella prima fase dello stile classico, cioè nello stile cosiddetto Severo, il mezzo per esprimere lo stesso contenuto consiste nell’introdurre nel corpo un disequilibrio tra i due lati. Ne risulta la nota figura di contrapposto: il peso è caricato maggiormente su una gamba, che rimane tesa, mentre l’altra gamba si scarica parzialmente, si flette e si appoggia lateralmente in avanti. Il bacino conseguentemente si inclina verso la gamba flessa. Così il corpo mostra di essere una cosa mobile e articolabile, e quindi viva. In questa fase, tuttavia, che va dal secondo decennio fino alla metà del V Sec. a.C., l’inclinazione del bacino non si trasmette ancora al tronco, che, comprimendo il fianco sopra la gamba tesa, rimane verticale e perpendicolare al suolo (ponderazione a tronco verticale). Nella seconda fase, che si può chiamare intermedia tra lo stile Severo e lo stile maturo (e occupa il sesto decennio del secolo), l’inclinazione del bacino si trasmette al tronco, che perpendicolarmente al bacino si inclina dalla parte della gamba flessa (ponderazione a tronco inclinato).
Nella terza fase, infine, cioè nello stile maturo (che va dal settimo all’ottavo decennio del secolo), il tronco reagisce al contrapposto con una completa articolazione in tre parti: sopra al bacino, inclinato verso la gamba flessa, l’addome si imposta in verticale e il torace si sposta, ristabilendo l’equilibrio proprio della figura stante, con una contro-inclinazione verso la gamba tesa. Mentre nelle due prime fasi il tronco rimaneva rettilineo (perpendicolare al suolo o perpendicolare al bacino), ora si è imparato ad articolare il tronco in tre parti intorno a un asse mediano curvilineo (ponderazione a tronco articolato o incurvato).
I due Bronzi di Riace rientrano nel medesimo tema e nel medesimo schema iconografico. Rappresentano due giovani adulti barbati, nudi, atleticamente sviluppati, stanti in figura di contrapposto: la gamba destra è tesa, la gamba sinistra flessa (secondo il contrapposto normale), il braccio destro reggeva un attributo, il braccio sinistro uno scudo. Le due statue presentano tuttavia evidenti differenze stilistiche e strutturali. La “Statua A” è costruita secondo i principî dello stile Severo, la “Statua B” mostra chiaramente il modellato e la ponderazione propri dello stile classico maturo. Le due statue perciò appartengono rispettivamente alla prima e alla terza fase nell’evoluzione che il tema della statua maschile nuda stante ha subito nel corso del V Sec. a.C..
I due originali bronzei sono nella loro classe i pezzi probabilmente più importanti che a noi siano pervenuti: da un lato infatti sono ben pochi gli originali bronzei conservati; dall’altro, tra quei pochi, essi sono probabilmente quelli più completamente conservati (sono le uniche statue ritrovate intere).
Il pube ha la caratteristica forma a losanga, presente in molti pezzi fino al 460 a.C., per non comparire che sporadicamente più tardi: Tirannicidi (476 a.C.), Torso da Mileto, Torso bronzeo di Firenze, Atleta da Abai (480-470 a.C.), Adorante di New York, Discobolo Ludovisi, Torso di Delos (c. 470 a.C.), Stele di atleta in Delfi (c. 465 a.C.), Atleta da Aderno, Guerriero Somzée (c. 460 a.C.). Il pube a losanga ricompare isolatamente nelle metope del Partenone e nell’Herakles nella decima metope orientale dell’Hephaisteion (445–440 a.C.).
La “Statua A” contiene elementi che si trovano un po’ in tutte le statue di stile Severo. Per riassumerne qualcuno in particolare: gamba sinistra flessa molto avanzata, tronco eretto, iscrizioni, pube a losanga, riccioli spiraliformi, volto espressivo. Tra le statue severe a noi tramandate, la “Statua A” presenta nel complesso la maggiore affinità (riscontrata tramite “ponderazione” nel modellato e nel tipo fisico fra statue del periodo) con la celebre statua, a noi nota da numerose copie, tra cui l’Apollo detto dell’Omphalos è la copia eponima: “A” sembra appartenere alla medesima scuola (o al medesimo ambiente) che creò l’originale dell’Apollo dell’Omphalos.

Per la “ponderazione”, il modellato e il tipo fisico, come sopra descritti, il Bronzo di Riace “A” e l’Apollo dell’Omphalos sono decisamente anteriori alle più evolute creazioni dello stile Severo, come l’Apollo di Kassel e l’Hermes Ludovisi, che sono dotati di maggiore mobilità e penetrazione spaziale (circa 450 a.C.). Per certi aspetti essi sembrano anteriori anche alle sculture dei frontoni di Olimpia. La “Statua A”, dal canto suo, per certi particolari e per certi elementi della ponderazione, sembra anche più rigida e legata dell’Apollo e del Guerriero Somzée. Non si va quindi lontani dal vero nel porre la sua data probabilmente negli ultimi anni del quarto decennio del V Sec. a.C., e comunque non oltre il 460 a.C..
Invece la “Statua B” ha chiaramente superato la fase sperimentale intermedia e mostra la ponderazione e il modellato proprio dello stile classico maturo.
Il Diskophoros è con ragione ritenuto una delle prime opere di Policleto. Esso mostra caratteri della fase intermedia dello stile Severo, ma anche alcuni elementi che appartengono decisamente alla ponderazione classica matura. Il piede della gamba flessa è appoggiato al suolo e il tronco pende un po’ verso la gamba flessa. Ma, in particolare nel Bronzetto del Louvre e nella statua iconica di Chieti (che concordano e sembrano genuine), il tronco è già chiaramente articolato in tre parti, secondo una normale ponderazione policletea: bacino inclinato verso la gamba flessa, cesura mediana orizzontale, linea dei pettorali contro-inclinata, linea alba curva. Alcuni esempi di stile maturo confrontabili con la “Statua B” di Riace:
- Diskophoros (445 a.C.): gamba flessa, ma piede appoggiato al suolo, tronco leggermente inclinato, spalla arretrata ed elevata, linea dei pettorali inclinata, cesura mediana orizzontale, arcata epigastrica ampia, solco inguinale semicircolare meno ampio, incarnato rilevato.
- Torso B (Herakles) nel frontone orientale dell’Hephaisteion (445–440 a.C.): gamba sinistra flessa, coscia avanzata, piede arretrato, incerto se appoggiato o no (poiché mancano le gambe dal ginocchio in giù), contrapposto molto accentuato, quasi sbilanciato, tronco molto incurvato verso gamba portante, cesura mediana orizzontale, solco inguinale semicircolare ampio (policleteo).
- Doryphoros (440–430 a.C.): gamba sinistra flessa arretrata, piede sollevato, tronco articolato in bacino, addome, torace, bacino inclinato, cesura mediana orizzontale, linea dei pettorali contro-inclinata, linea alba curva, arcata epigastrica tonda, solco inguinale semicircolare ampio modellato rilevato e sbalzato.
- Herakles (440–430 a.C.): gamba sinistra flessa arretrata, incerto se il piede è appoggiato o sollevato (come Doryphoros), tronco articolato, arcata epigastrica a montanti dissimmetrici, solco inguinale semicircolare meno ampio (di Doryphoros e di Diadoumenos), modellato rilevato e sbalzato, muscolatura accentuata.
- Diadoumenos (430–420 a.C.): gamba sinistra flessa arretrata, piede sollevato, tronco articolato, arcata epigastrica a montanti leggermente dissimmetrici, solco inguinale semicircolare ampio (come Doryphoros), cesura mediana orizzontale attenuata, obliquo con margine verticale lungo, modellato meno rilevato a larghe zone.
La “ponderazione” ci dice che la gamba destra è tesa, la gamba sinistra è flessa (contrapposto normale), meno avanzata che nella “Statua A” e in altre statue severe. Il tronco di “B” è chiaramente articolato in tre parti, che hanno ognuna il proprio asse di direzione: la linea di forza è divisa in tre segmenti separati. Il bacino è inclinato verso la gamba flessa, l’addome si riporta in verticale e il torace si inclina all’opposto verso la gamba tesa. Conseguentemente la spalla sopra la gamba flessa è più elevata della spalla opposta. E la linea alba descrive una curva.
Questa ponderazione è propria dello stile maturo, a cominciare dal Diskophoros, poi naturalmente nel Doryphoros e nell’Herakles, e infine nel Diadumeno di Policleto. In queste statue la tripartizione del tronco è delineata dal solco inguinale inclinato, dalla cesura mediana orizzontale e dalla linea dei pettorali e delle spalle inclinata all’opposto. Le tre partizioni hanno una disposizione radiale. Il tronco risulta così veramente ponderato secondo la sua struttura interna e la statua “quadrata” citata da Plinio nel riferire del canone greco (Plinio, Nat. Hist. XXXIV.56). Nelle statue anteriori invece, nella fase intermedia fino all’efebo nel fregio del Partenone, poiché il tronco più o meno segue l’inclinazione del bacino, la cesura mediana è inclinata e la linea dei pettorali e delle spalle è orizzontale.
Riguardo al portamento, il tronco della “Statua A” è teso e verticale, quello di “B” è naturalmente rilasciato, leggermente inclinato all’indietro, quasi assiso sul proprio bacino come su un trono. E in merito al modellato, la “Statua B” ha una modellatura più ricca di quella di “A” e in generale dello stile Severo e intermedio: i contorni esterni sono contrastati, i muscoli sono sbalzati, i passaggi non sono fluidi come in “A” ma sono rilevati con attacchi come nei torsi policletei. Ciò per gli studiosi è importante perché autorevolmente conferma che l’incarnato accentuato dei torsi policletei (del Bronzetto del Louvre per il Diskophoros, del Torso Pourtales, del Torso in basalto per il Doryphoros, del Torso delle Terme per l’Herakles, di certi torsi del Diadoumenos) è genuino rispetto alla modellatura levigata a larghe zone, come quella della Statua dalla Palestra di Pompei o della Statua da Delos in Atene.
La clavicola e i fasci superiori del deltoide hanno un bordo più rilevato. La gabbia toracica, l’obliquo dell’addome e le cosce hanno un contorno contrastato con molti sbalzi, che indicano i rilievi in modo naturalistico, come nei torsi dell’Herakles e del Doryphoros (mentre nella “Statua A” formano una linea fluida e continua): in particolare l’obliquo dell’addome trabocca elasticamente sul fianco e altri sbalzati rilievi sono formati dai piccoli glutei e dal grande trocantere.
In “B” gli ampi pettorali formano una massa piena e carnosa. Il margine inferiore modella due curve carnose, ma non descrive un arco doppio come nella “Statua A”. Le areole sono di rame (come nella “Statua A” e nel Bronzetto del Louvre). L’arcata epigastrica è molto vicina ai pettorali. Essa descrive una curva ampia, abbassata e tondeggiante, il bordo è rilevato in fuori, più sul lato sinistro, due montanti dell’arco sono dissimmetrici a causa dello spostamento dell’intero torace.
Tutti elementi questi che si ritrovano pari pari nei torsi del Doryphoros e dell’Herakles. La gabbia toracica è veramente aperta e la sua struttura mostrata, come di più non si potrebbe.
Nella “Statua B” il pube si inserisce orizzontalmente nel solco inguinale e lo supera (come nel Bronzetto del Diskophoros e nel Torso in basalto), invece nella “Statua A” termina nel solco inguinale. In “A”, il pube ha la forma di un rombo allungato, che, su ambedue i lati, va oltre le anguinaie: questo schema, che è noto anche nel Torso di Mileto e da altre opere del periodo classico antico, è stato elaborato intorno al 490 a.C. ed è rimasto in uso fino al 460 a.C..
Anche in “B” le punte laterali del pube vanno oltre la linea dell’inguine; nella parte inferiore invece esso non termina all’altezza del pene ma lo circonda anche lateralmente, mentre viene limitato in alto da una linea diritta (e non a triangolo come in “A”), che si addice meglio alla forma curva del corpo. Questa forma del pube sembra essersi sviluppata soltanto verso il 460 a.C., stando agli originali, come per esempio il Cronide di Capo Artemisio, o alle copie, come quelle del cosiddetto Apollo di Kassel. Rispetto ai riccioli di stile antiquato del “Bronzo A”, che derivano ancora da quelli tipici di inizio V Sec. a.C., i peli del pube del “Bronzo B” sono mossi in maniera più libera. Contorno e grandezza dei riccioli sono più differenti, come sappiamo grazie a un torso di Francoforte e ad altre opere del periodo 460–450 a.C..

Una differenza simile si può notare anche per quanto riguarda la forma del pene e dello scroto. In “A”, la grandezza dello scroto è pressoché uguale per i due testicoli. In mezzo si osserva la linea a rilievo di separazione, come è frequente nelle opere del periodo tardo antico e del Severo iniziale, mentre anche per questo particolare “B” mostra una forma più avanzata, senza linea mediana, con il testicolo sinistro nettamente più basso.
I riccioli del pube sono simili ai capelli (sono fatti a fiammella, non a spirale come in “A”). Partono dall’inguine e vanno verso l’interno (come nei torsi policletei, per es. nel Torso in basalto), al contrario in “A” partono dal pube e vanno verso l’esterno, in direzione opposta a quella di “B”. In “B” c’è una piega di pelle nello scroto sotto i testicoli (come nel Bronzetto e nei migliori torsi policletei fino all’Efebo Westmacott), in “A” manca e c’e invece una grinza sopra i testicoli. Il pene ha la forma minuta affusolata, normale per la moda del tempo, glande appena segnato, prepuzio molto prolungato: anche in adulti ha uno sviluppo adolescenziale; l’asta ha sezione circolare in “A”, leggermente oblunga in “B”; il prepuzio è chiuso con due grinze in “A”, con un solo taglio verticale in “B”. Nella veduta laterale è sorprendente la somiglianza nella postura, nel contorno e perfino nei particolari del modellato con alcuni torsi policletei (specialmente con il Torso Pourtales del Doryphoros e il Torso delle Terme di Herakles). Nella veduta dorsale di “B”, il solco spinale è meno profondo che nella “Statua A”. I muscoli della scapola formano rilievi piuttosto minuti e accidentati (non ampi e rotondi come in “A”). In “B” gli estensori della spina sono ben rilevati (più nettamente che in “A”), visti in profilo mostrano un rilievo sbalzato (non tondeggiante come in “A”) nel punto dove si inseriscono nei lombi, simile a quanto si vede nei citati torsi policletei. Glutei, muscoli spinali, obliquo dell’addome si inseriscono senza intervallo uno accanto all’altro. I glutei hanno una forma piuttosto squadrata, con ampia fossa trocanterica e corrispondente rilievo, come nei torsi citati. Al contrario in “A” la fossa trocanterica è un po’ meno profonda e i glutei sono più rotondi e prominenti, il taglio intergluteare è ricurvo e la curva è continuata in alto dal margine superiore dei glutei.
Nelle gambe, in “B” il modellato delle cosce, a parte i rilievi dei fianchi, è liscio e scorrevole. Il volume muscolare è minore di quello di “A”: posteriormente la massa dei flessori della coscia non è così voluminosa e tondeggiante come in “A” (circonferenza della coscia in cm: “A”=69, “B”=67). Particolarmente tipica è la parte fortemente rigonfia sopra al ginocchio destro di “B”, che verso il lato interno si piega in basso, elemento che compare in maniera quasi identica nelle statue policletee. Nello stinco sono segnati il soleo e il gemello, il peroneo lungo è molto attenuato. La massa del polpaccio è più arrotondata che in “A”.

Con ciò non si vuole suggerire che la “Statua B” sia una creazione della scuola policletea, ma soltanto notare che riferimenti più prossimi vanno ricercati in quell’epoca. Anche in Attica intorno al 440 a.C. si trovano elementi che sono interpretabili come influenza policletea oppure come parallela evoluzione.
E forse, per certi aspetti sopra notati, la cosa più probabile è che la “Statua B” sia opera di un buon maestro attico, che accolse suggerimenti da vari momenti policletei: per il contrapposto essa è simile al Diskophoros, per la ponderazione e per il modellato del tronco all’Herakles e al Doryphoros, per certi particolari nelle iscrizioni dell’addome al Diadoumenos e al Ragazzo. La “Statua B” dunque sembra contemporanea o posteriore almeno all’Herakles e al Doryphoros, e forse anche al Diadoumenos. D’altra parte il ritmo chiuso e la ponderazione ancora rigorosa la fanno ritenere anteriore alle opere post policletee dell’ultimo ventennio. La “Statua B” quindi si pone verosimilmente nel terzultimo decennio del secolo: 430 a.C. circa. Trent’anni dopo la “Statua A”.
Un elemento di raffronto che può essere di un certo interesse riguarda lo spessore della parete bronzea di tre statue: Auriga di Delfi, “Bronzo A”, “Bronzo B”. Le uniche, come detto, dotate di caruncola lacrimale in pietra rosa. È una testimonianza “specialistica” supplementare che va a rinforzare quella stilistica: siamo in presenza quantomeno di tre saperi tecnologici differenti.
Lo spessore del metallo, nell’Auriga (ca. 475 a.C.), va da 8 a 13 millimetri (con eccezioni fino a 25 mm nelle grosse pieghe della xystis); nella “Statua A” di Riace (ca. 460 a.C.) va da 5,7 a 12 mm (con eccezione del pene, pieno, di 20 mm); nella “Statua B” di Riace (ca. 430 a.C.) va da 4,7 a 13,4 mm (salvo nella gamba destra, dove per qualche incertezza di lavoro scende fino a 3 mm e nel pene, pieno, dove sale a 20 mm). Ammettendo, come si deve fare, un affinamento nella tecnica di fusione con il passare non di secoli ma appena di decenni, a riprova del fatto che fossero all’opera centinaia di bronzisti in quella che doveva essere la più ambita attività lavorativa dell’epoca, con progressi tecnici continui, lo spessore minimo calcolato della parete bronzea delle statue dei periodi Severo e Classico passa dagli 8 mm del quarto decennio del V Sec. a.C., ai 5,7 mm alla fine del terzo decennio, fino ad arrivare a 4,7 mm intorno al settimo o ottavo decennio del secolo. (I calcoli sono degli studiosi Formigli e Stucchi — ndr). Un sapere e una maestria nel rendere leggere le statue che nessuno, nei secoli successivi, nell’Ellade come nella Romanità, seppe più replicare, come ricorda tristemente Plinio.
Un tempo il bronzo si legava coll’oro e l’argento, e tuttavia l’arte era considerata più preziosa della materia; ora non si sa qual delle due sia peggiore; e, cosa strana, mentre i prezzi degli oggetti sono saliti all’infinito, la fama dell’arte è estinta. Essa infatti, come tutte le cose di questo mondo, ha incominciato a esser praticata per guadagno, mentre un tempo per la gloria — tanto da essere attribuita a opera degli dèi, e i principali uomini di ogni nazione cercavano la fama anche per questa via —; e si è talmente perduto oggi il processo di fusione del bronzo prezioso, che già da un pezzo neppure il caso sia capace di produrre in questo campo un’opera d’arte.
Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia” XXXIV.3
Paolo Moreno non era d’accordo
La prospettiva stilistica testé descritta incontrò l’opposizione del già citato archeologo e storico Moreno. Il quale anzi vede una “collaborazione” (Alcamene-Argelada) e così scrive sul suo libro:
Perduti gli elmi in antico, e staccati col restauro i tenoni che sporgevano dai piedi, i due nudi del Museo di Reggio hanno la medesima statura (Bronzo A, m 1,98; B, 1,97) e una stretta coincidenza delle misure nelle partizioni verticali — come la lunghezza dei femori (destro A, cm 59,9; B, 58,5; sinistro A, 60,2; B, 60,1) o l’altezza del torace (A, 57; B, 56,3) — e nella larghezza dei tratti fondamentali: caviglia (destra A, 8,6; B, 8,8; sinistra A 8,7; B, 8,6), ginocchio (destro A, 12,1; B, 12; sinistro A, 11,6; B, 12), anche (A, 36,5; B, 36), vita (A, 33,5; B, 33,4). Tenendo conto che il modellato di ogni sezione muta liberamente dall’uno all’altro esemplare in funzione espressiva, bisogna concludere che la rigorosa omogeneità mantenuta soltanto sugli assi non è frutto del caso, bensì implica un accordo preliminare sul disegno tra i due autori: i quali, lavorando poi separatamente, ciascuno entro i propri parametri estetici e secondo l’indole del personaggio assegnato, hanno rispettato la medesima taglia, per garantire l’armonica composizione del prodotto.
Tra gli stessi sostenitori della datazione tarda del “Bronzo B” è nata la constatazione che la curvatura del torso è soltanto “protopolicletea” (Harrison 1985, p. 47): in altri termini, anteriore al Doriforo creato intorno al 445. Il movimento è infatti quello del Discoforo, che è il primo, sicuro pronunciamento di Policleto, anteriore al 450, cioè allo stesso “Bronzo A” di Riace. Pertanto l’eventuale conoscenza del Discoforo da parte dell’autore del “Bronzo B” non abbassa la cronologia, bensì è segno di sperimentazione a un alto livello epocale: il “Bronzo B” ha in comune col Discoforo anche l’incipiente flessione nella gamba parzialmente affrancata dal peso e scartata di lato, che ancora impone al piede di stendere al suolo l’intera pianta fino al tallone (nudus talo incessens, Plinio, XXXIV.55), mentre nelle successive opere di Policleto l’ulteriore alleggerimento rispetto all’arto portante (uno crure ut insisterent signa, Plinio, XXXIV.56) consentirà la piegatura della gamba libera, puntata in terra all’indietro con le sole dita.
Insomma, queste osservazioni giustificano Castrizio quando propone per Pythagoras la “collaborazione del nipote Sostrato”. Tuttavia Odo Pavese diverge totalmente quando attraverso complicati calcoli geometrici si raccorda con la visione di Antonino Di Vita a proposito degli oggetti oggi perduti retti dalle mani destre. I quali orientano in maniera cruciale l’identità — anch’essa perduta — dei Bronzi di Riace.
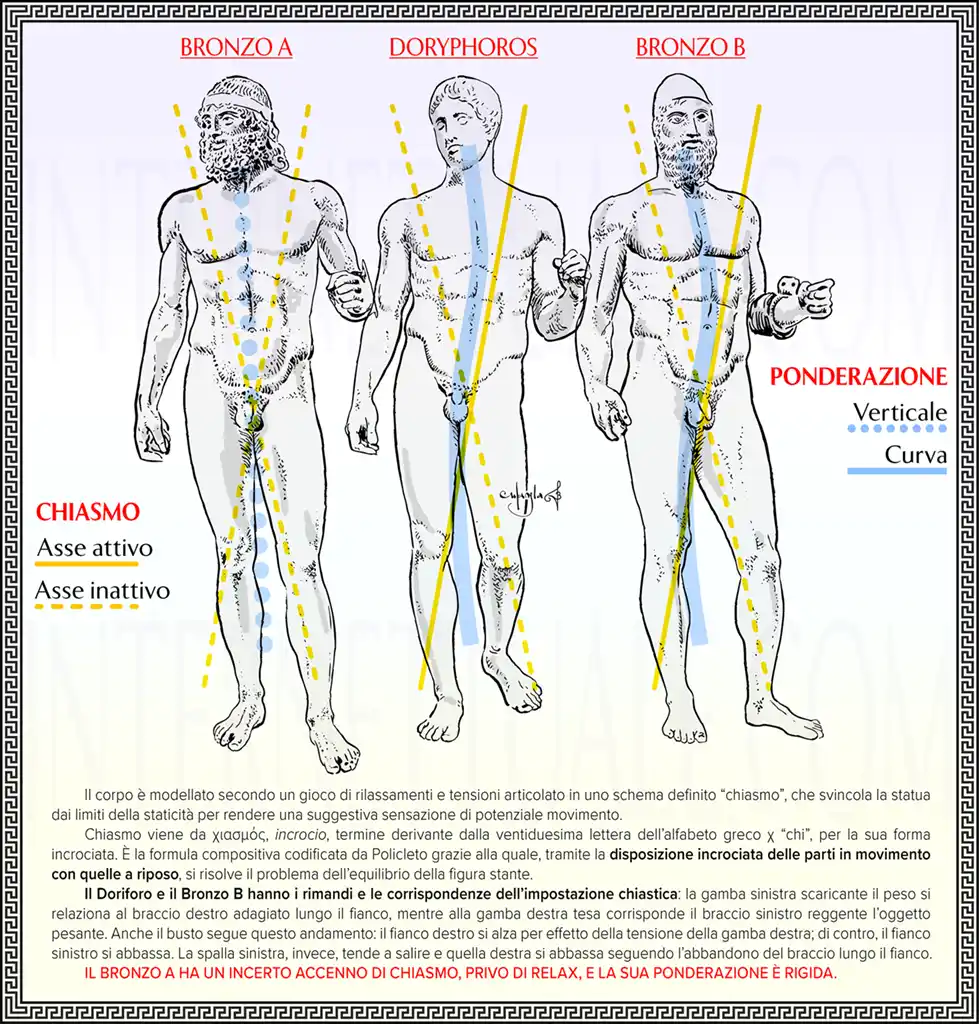
Riguardo agli “oggetti perduti”
La “Statua B” portava l’elmo alzato sulla fronte, in posizione di riposo. L’elmo è andato perduto, rimane solamente la calotta cranica su cui esso poggiava: la calotta ha anteriormente un appoggio per il frontale dell’elmo, ma non ha tracce di occhiaie e paranaso. Si è conservata una lamina rettangolare di rame che originariamente era saldata al corripondente intacco, presente nella parte anteriore della calotta, sopra il frontale. L’elmo perciò sembra fosse di tipo non corinzio, ma attico. In entrambe le statue il braccio sinistro flesso reggeva uno scudo oplitico, l’avambraccio infilato nel porpax, il pugno chiuso sull’antilabé. Si è conservata parte dell’antilabé di “A” (diametro stimato circa 2 cm), ora distaccata, filettata in modo da sembrare fatta in cuoio. Il braccio destro pende lungo il fianco. La muscolatura del braccio e la flessione delle dita sembrano suggerire che la mano reggesse qualcosa. Che cosa?

Nella mano destra della “Statua A” l’indice e il medio sono divaricati a una distanza di 3,4 cm. Nella seconda falange del medio c’è una intaccatura profonda 1 cm, sicché il margine del medio, senza l’intaccatura, dista dall’indice 2,4 cm. All’interno della mano c’è una cavità arrotondata cilindriforme del diametro di 3,4 cm in ogni punto. Anche le seconde falangi del quarto e quinto dito sono spianate e arrotondate all’interno per creare la cavità cilindriforme. Sono incavate allo stesso scopo anche le eminenze tenare e ipotenare. Nella regione del polso e nell’interno dell’avambraccio (avanti al tendine del palmare lungo) c’è una superficiale scanalatura (profonda 1 mm) che si estende dal polso fino a metà avambraccio per 15 cm, e non oltre. Non ci sono tracce di scanalatura oltre a questo punto né nell’avambraccio né nell’omero. All’interno dell’avambraccio sono indicate tre vene; una scende avanti e una dietro alla scanalatura fino a unirsi all’attacco del polso col tendine del palmare, posteriore alla vena.
L’intaccatura nel terzo dito, la cavità nel palmo della mano e la scanalatura nell’avambraccio sono allineate secondo un unico asse. Ciò dimostra che la mano reggeva un attributo rettilineo passante tra l’indice e il terzo dito per la cavità nella mano e per la scanalatura nell’avambraccio. La direttrice passante per la cavità nella mano e per la scanalatura, se prolungata fino all’omero, sarebbe tangente al margine inferiore del deltoide, ma non c’è traccia né qui né altrove di un suo eventuale passaggio. Una eventuale asta (di lancia) dunque percorrerebbe l’avambraccio fino a metà (per 15 cm) e poi, senza toccare altri punti nel braccio, passerebbe tangente al margine inferiore del deltoide. In nessun modo l’asta si potrebbe appoggiare sul deltoide stesso o sulla spalla, poiché l’allineamento non lo permette. Dunque la mano destra della “Statua A” è conciliabile con un attributo, che può essere un’asta (passante tra indice e medio e poggiante sul braccio), una spada (elsa tra indice e medio, lama o guaina poggiante sull’avambraccio e rivolta all’insù), oppure un altro oggetto, ramo o bastoncino (dall’avambraccio scendente tra indice e medio, fronda rivolta all’ingiù).
Il braccio destro della “Statua B”, come l’analisi chimica e le radiografie hanno dimostrato durante il restauro, è stato saldato alla statua in epoca posteriore per sostituire quello originario. Non è detto quindi che questo braccio riproduca le condizioni originarie. Comunque sia, la mano destra ha un riempimento di piombo in cui si trova un foro circolare del diametro di 2,2 cm, lungo 5 cm. Senza riempimento la cavità della mano ha un diametro di 3 cm, la distanza tra pollice e medio è di 3 cm, tra medio e indice di 2,9 cm. Lo strato di riempimento è spesso 5 mm. Entrambe le mani della “Statua B” sono riempite di piombo, ma non quelle della “Statua A”. Il piombo aveva evidentemente funzione di connettivo tra le mani e l’attributo. Anche nelle mani della “Statua A” c’era probabilmente un connettivo, andato perduto. La direttrice attraversante il foro nel riempimento della mano continua lungo l’interno dell’avambraccio e tange il tricipite all’interno del braccio, passando all’interno e dietro all’omero (direttrice “allineamento B–B”). Nei punti tangenziali tuttavia non vi sono tracce del suo passaggio, come scanalature o simili.
V’è una superficiale scanalatura all’interno dell’avambraccio, a cominciare dal polso e a continuare fino a metà avambraccio, lunga 17 cm, profonda 1 mm (simile a quella nell’avambraccio della “Statua A”). La scanalatura comincia avanti al tendine del palmare lungo (come nella “Statua A”). Anche qui sono indicate le vene avanti e dietro la scanalatura (tutto l’avambraccio è ricco di vene). C’è un’altra superficiale scanalatura all’esterno dell’omero in corrispondenza del bicipite, lunga 7,5 cm e profonda 1 mm. L’asse passante per queste due scanalature all’interno dell’avambraccio e all’esterno dell’omero (“allineamento A–A”) non è allineato con l’asse attraversante il foro nel riempimento della mano (vd. sopra: “allineamento B–B”) e tangente la faccia interna dell’omero, ma forma con questo un angolo di alcuni gradi. Se entrambi gli allineamenti sono originari (cioè entrambi contemporanei all’epoca del rifacimento del braccio) e l’attributo passava per “B–B” (il foro nella mano) e per “A–A” (le due scanalature), bisogna pensare che esso non fosse rettilineo, ma leggermente incurvato; come per es. un bastoncino flessibile.
Altrimenti bisogna ritenere che in un primo tempo l’attributo passasse per “A–A” (per le due scanalature lungo l’interno dell’avambraccio e per l’esterno del braccio), e poi ci sia stato un ulteriore rifacimento per cui l’attributo venne allineato “B–B” (attraverso il foro nella mano e all’interno dell’avambraccio e del braccio).
Nella prima fase (“allineamento A–A”) l’attributo poteva essere un’asta, una spada o un bastoncino: in ogni caso esso era impugnato tra pollice e indice, si appoggiava sull’avambraccio e sull’esterno del braccio, dove si trovano le scanalature, ed era rivolto all’insù, almeno fino alla scanalatura nel braccio. Nella seconda fase (“allineamento B–B”, attraverso il foro nel riempimento della mano) l’attributo poteva essere del pari un’asta, una spada o un bastoncino. Se asta, doveva passare all’interno e dietro il braccio (ignorando le due scanalature). Se spada, l’elsa era normalmente impugnata tra pollice e indice, la lama probabilmente sguainata, rivolta all’ingiù. Se ramo o bastoncino, l’impugnatura era la medesima, la fronda probabilmente rivolta all’ingiù.
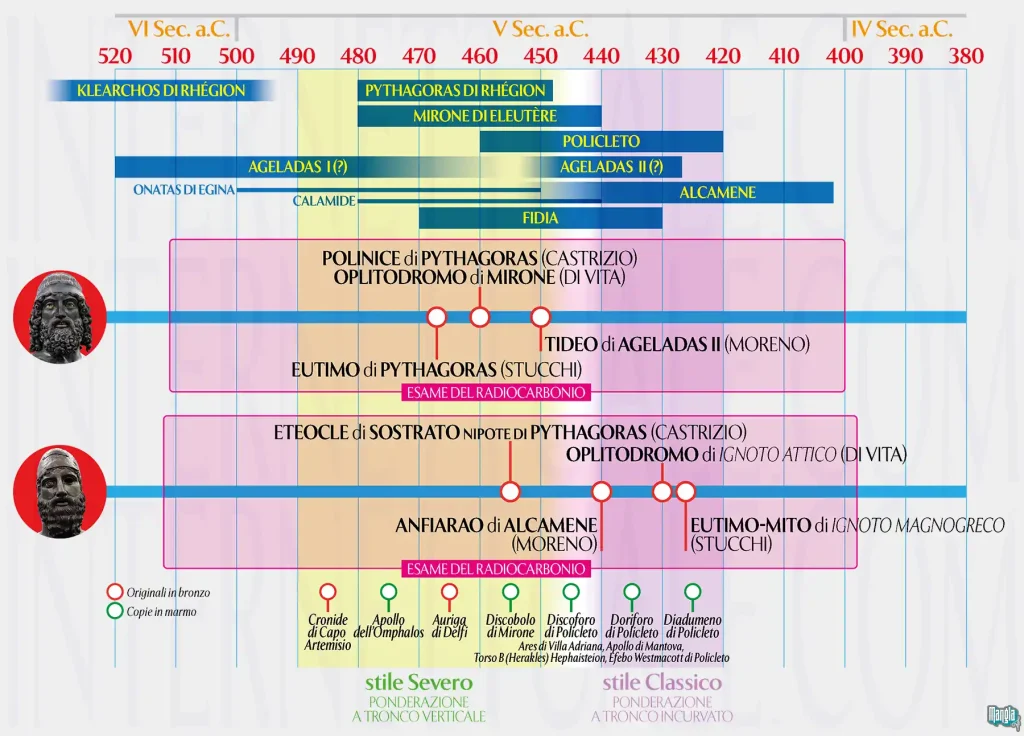
Riassumendo, dunque, per quanto riguarda le tracce riscontrate e il contesto iconografico, a entrambe le statue è possibile supplire come attributo nella mano destra un’asta di lancia, una spada oppure un bastoncino (che nella fattispecie si può immaginare ramiforme). In particolare, nella “Statua A”, se asta di lancia, essa doveva essere tenuta tra l’indice e il medio in maniera sorprendentemente casuale e delicata per un’asta, dato che tra queste due dita si trova l’intaccatura che serviva al suo passaggio. Se spada, l’elsa doveva essere tenuta parimenti tra le due dita in maniera altrettanto sorprendente e inoltre doveva appoggiare sull’avambraccio con la punta rivolta all’insù (anche questo piuttosto strano), altrimenti sull’arto non sarebbe stata predisposta una scanalatura. Se infine l’attributo era un ramo, il gesto almeno di stringerlo delicatamente tra due dita (indice medio) diventa abbastanza normale e comprensibile.
Una perplessità a supplire una lancia o una spada nelle mani delle due statue può essere data dal fatto che nella mano di “B” il foro nel riempimento ha un diametro di 2,2 cm: un foro così stretto sembra insufficiente per accomodare un’asta di lancia o un’elsa di spada. A giudicare dalle rappresentazioni, sia l’asta delle lance greche, sia l’elsa delle spade erano piuttosto grosse: in proporzione alle statue dovrebbero essere grosse almeno 3 cm — l’elsa anche più —. È vero che nella mano di “A” la cavità interna è di 3,4 cm, ma, se anche qui bisogna supporre che ci fosse uno strato di connettivo di 5 mm (come in “B”), lo spazio disponibile per l’attributo si riduce a circa 2,4 cm. Parimenti la distanza tra indice e medio, attraverso cui passava l’attributo, è di 2,4 cm, se non si considera l’intaccatura profonda 1 cm ricavata nel dito medio. Anche in “A” quindi sembra che l’attributo fosse spesso non più di 2,4 cm. La controprova sembra fornita dalla antilabé di “A”, che si è conservata: essa infatti ha un diametro di circa 2 cm, ma si accomodava nella mano sinistra in uno spazio ampio circa 3 cm.
Proviamo nondimeno a considerare i due Bronzi integrando come attributo nella mano destra una lancia o una spada. In questo caso essi devono essere interpretati come guerrieri (eroi o uomini). La lancia (la cosiddetta “dòry”) era l’arma per antonomasia dei Greci, e non si dà rappresentazione normale di guerriero che non abbia almeno la lancia.
Nella rappresentazione statica, lo schema tipico e normale vede solitamente il guerriero tenere la lancia nel pugno chiuso, piantata al suolo, verticale davanti a sé, lo scudo nel braccio sinistro. Oppure, secondo un altro frequente atteggiamento, il guerriero ha il braccio destro allungato lateralmente e si appoggia alla lancia, che sta verticale al suo fianco.
Nei due Bronzi non si ha alcuno dei due schemi normali sopra descritti. La mano è semiprona, e questo non sembra il gesto più ovvio per reggere una lancia. Un esatto parallelo, per quanto concerne la posizione della mano e la funzione delle dita, è dato, a quanto pare, solamente dallo Zeus di Dresda secondo il moderno restauro: Zeus ha lo scettro nella mano semiprona, l’asta dello scettro (piuttosto sottile) tra indice e medio, tangente all’interno dell’avambraccio e all’esterno del braccio, sotto il deltoide, non sulla spalla.
Anche la seconda alternativa, la spada, presenta numerosi problemi. Sia in “A” che in “B” la spada sarebbe stata appoggiata all’interno dell’avambraccio con la punta rivolta all’insù. Questa maniera di tenere la spada sembra piuttosto insolita per le corte spade antiche. Non è tuttavia inesemplata: si trova non in opere greche, ma in alcuni monumenti italici. Se poi la spada era impugnata dalla “Statua B” con la lama rivolta all’ingiù (secondo un “allineamento B–B”), allora il gesto è normale e non ha bisogno di commento: ma in ogni caso non si adatta alla staticità del soggetto.
La spada era per i Greci un’arma ausiliaria, veniva usata occasionalmente, e normalmente non come arma da battaglia, ma per finire il nemico già caduto. La spada non era per i Greci l’arma emblematica del guerriero, come per i cavalieri medievali. I guerrieri greci non sono raffigurati con la spada in pugno, se non quando sono impegnati in azioni che la richiedano, come può essere una androktasia: ciò non è evidentemente il caso dei Bronzi di Riace. La lancia era l’arma principale del guerriero, e senza lancia sembra difficile supporre una rappresentazione statica, ideale e generica di guerriero come quella data dai due Bronzi — non significante cioè un qualche particolare momento, dove la spada sia richiesta dall’azione in corso.
La terza possibilità che si concilia con le tracce riscontrate è che i due Bronzi avessero come attributo nella mano un bastoncino ramiforme. Dalla “Statua A” esso poteva esser tenuto con la fronda rivolta all’ingiù (e in questo caso il legno doveva arrivare almeno fino a metà avambraccio, cioè fino al termine della scanalatura lunga 15 cm), oppure con la fronda all’insù, poggiante sull’avambraccio. Nella “Statua B” (in “allineamento A–A”) il ramo poteva stare con la fronda all’insù (arrivando almeno fino alla scanalatura presente sul braccio) oppure (“allineamento B–B”) verosimilmente con la fronda rivolta all’ingiù. L’ipotesi di un ramo è meglio conciliabile con lo spazio disponibile nella mano delle due statue e con il passaggio tra l’indice e il medio della “Statua A”, ma d’altra parte non è molto gradevole visualizzare un ramo che nella “Statua A” risale a metà avambraccio e nella “Statua B” addirittura fino al braccio.
Perché dunque considerare anche il supplemento di un ramo? In quale occasione si possono presentare due figure maschili nude, armate di elmo e scudo, ma sprovviste delle rimanenti armi della panoplia, cioè prive di schinieri, di thorax, di balteo, di spada, e soprattutto prive di lancia? Un siffatto equipaggiamento è conciliabile con la corsa armata, l’oplitodromia: in questa corsa infatti gli atleti gareggiavano nudi (come in ogni altra disciplina atletica) e della panoplia portavano solamente l’elmo e lo scudo, senza altre armi, in particolare senza thorax e senza lancia. I due Bronzi potrebbero dunque rappresentare due hoplitodromoi, atleti corridori nella corsa armata. La nudità sarebbe allora atletica. Essi sono raffigurati stanti, probabilmente nel momento della premiazione. I Bronzi di Riace rientrano così nella nota classe delle “statue atletiche”, che era usanza dedicare nei santuari sede degli agoni e nelle città natali degli atleti a commemorazione della vittoria ottenuta.

Nella maggior parte degli agoni il premio era dato da una corona di fronda, e un ramo della stessa fronda (che in molti luoghi era l’apollinea palma) era costume porre nella destra del vincitore. È ancora una volta grazie a Pausania che lo veniamo a sapere:
[…] sopra l’altra colonna poi è espresso Jasio, che tiene il cavallo, e porta nella destra un ramo di palma: dicono che Jasio vincesse col cavallo in Olimpia, quando Ercole Tebano celebrò i giuochi Olimpici.
Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” VIII.48.1-2
Del darsi in Olimpia la corona di olivo selvatico al vincitore, e di lauro in Delfo, dell’uno ho di già reso conto ne’ discorsi sugli Elèi, e l’altro sarà da me appresso mostrato: nell’Istmo poi il pino, in Nemea l’appio furono creduti doversi dare per i travagli di Palemone, e di Archemoro. I combattimenti hanno per lo più la corona di palma, e dappertutto la palma è posta al vincitore nella destra: ciò fu per la seguente ragione stabilito. Dicono che Teseo tornando da Creta diè in Delo de’ giuochi in onore di Apollo, e coronò i vincitori di palma: quindi dicono aver cominciato questo uso. Della palma di Delo fece menzione anche Omero nella supplica di Ulisse alla figlia di Alcinoo.
La “Statua A” porta sciolta sulle spalle la sua florida capigliatura, come si usava portare sotto l’elmo: i capelli uscivano da sotto il paranuca e scendevano sul collo, sia perché così era più bello, sia per servire da imbottitura dell’elmo. Altrimenti, per gli esercizi ginnici, i capelli venivano raccolti sulla nuca o girati in trecce secondo varie fogge.
I due potenziali hoplitodromoi di Riace sono barbati: ciò significa che essi sono adulti e appartengono alla categoria degli andres (uomini). Alla corsa armata in ogni agone e in ogni tempo partecipava soltanto la categoria degli atleti adulti, con rigida esclusione dei paides (fanciulli) e degli ageneioi (gli… “sbarbatelli”). Solamente ad Atene, nelle Panathenaia, Theseia e Epitaphia le squadre erano costituite dagli efebi dei ginnasi.
Le gambe dei due atleti sono nude, prive di schinieri: se originariamente nella corsa armata si usava portare anche gli schinieri, in seguito questi furono aboliti. La statua di Damaretos di Heraia, vincitore nella corsa armata a Olimpia, eretta insieme a quella del figlio (480 a.C.), portava gli schinieri, contrariamente all’usanza in seguito invalsa. E infatti nella pittura vascolare di stile Severo gli schinieri non sempre compaiono e prima della metà del V Sec. a.C. cessano completamente. Ancora Pausania:
Damareto Ereese, figlio di Damareto, ed i nipoti riportarono ciascuno due vittorie in Olimpia: Damareto nella LXV Olimpiade, quando fu per la prima volta stabilito il corso dell’uomo armato, e similmente nella seguente: è stata la statua rappresentata collo scudo simile ai nostri, coll’elmo in capo, ed i gambali ai piedi. Queste cose furono col tempo sì dagli Elèi che dagli altri Greci tolte dal corso.
Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” VI.10.2
Alcune statue dedicate per una vittoria nella corsa armata sono attestate dalle fonti. Oltre a Damaretos di Heraia, che vinse la corsa nel 520 e 516 (cfr. sopra Pausania), si sono tramandati Telesikrates di Cirene (vinse a Delfi nel 474), Epicharinos, con una statua nell’Acropoli di Atene, opera di Kritios e Nesiotes (Pausania, I.23.9), Mnaseas di Cirene, che vinse a Olimpia nel 456, statua realizzata da Pythagoras reggino (Pausania, VI.13.7), Lykinos di Sparta, con statua di Mirone (Pausania, VI.2.2 — costui ebbe una statua per la vittoria nella corsa armata nel 448 e un’altra statua per il trionfo nella quadriga, con data incerta), Kallikrates di Magnesia, che vinse a Olimpia nel 344 e nel 340, con statua di Lisippo (Pausania, VI.17.3).
A parte l’Epicharinos, queste statue si possono visualizzare come figure stanti, non dissimili dai due Bronzi di Riace, secondo il normale schema degli “andriantes” atletici. Al periodo in cui esse furono erette (tra 480 e 450 a.C.) appartiene del resto la “Statua A”.
Dai monumenti appare che lo stesso periodo (cioè la prima metà del V Sec. a.C.) fu l’epoca di maggior voga della corsa armata. L’interesse per questa disciplina è dimostrato dai molti monumenti ma in particolare anche dalle varie e vivaci rappresentazioni vascolari.
In ogni modo e per concludere, a parte ogni considerazione cronologica, i gruppi cui i due Bronzi potessero appartenere erano svariati: già soltanto a Delfi Pausania ricorda una decina di gruppi dedicati nel V Sec. a.C..
Inoltre esistevano certamente molti altri monumenti in altri santuari nel V. Sec. a.C., che non sono ricordati né da Pausania né da altri, per l’ovvia ragione che essi erano già andati perduti o rimossi, oppure semplicemente perché “il periegeta” non li vide o, se li vide, non li ricordò. La nostra documentazione si fonda su una duplice riduzione: soltanto una parte dei monumenti è attestata dalle fonti e soltanto una piccola parte delle fonti è tramandata fino a noi. La possibilità dunque che due bronzi trovati casualmente provengano da un monumento noto nella letteratura, per esempio che essi provengano proprio dal donario degli Ateniesi a Maratona come suggerito da qualcuno, sembra a priori piuttosto remota, ed è inoltre contraddetta da considerazioni cronologiche intrinseche.
Un’idea del gran numero di statue che c’erano in Grecia, anche dopo le spoliazioni, si può avere da Plinio (Hist. Nat. XXXIV.5 e XXXIX.36: «Muciano, quello che è stato console tre volte, ha detto che anche allora c’erano a Rodi 73 mila statue, e si crede che non ne rimangano meno a Atene, Olimpia, Delfi») e da Livio (Ab Urbe Cond. XXXVIII.3-10): come già abbiamo visto parlando di Pirro, il console romano Marco Fulvio Nobiliore (226–189 a.C.) nel suo trionfo riportò dalla sola Ambracia 785 statue di bronzo e 230 di marmo. (Oltre mille statue portate via da una città che non era nemmeno fra le più importanti…) A Olimpia sono state trovate molte basi di statue di cui Pausania non fa menzione. Lo stesso Pausania (II.1.7) dice che il viale dei pini all’Istmo era fiancheggiato da statue atletiche, ma poi egli non ne nomina alcuna. “Il periegeta” non nomina statue atletiche a Delfi, a Nemea e in altri santuari, che pure erano numerose. E così via.

Queste ultime considerazioni ancora una volta indeboliscono la teoria sui Fratricidi in fase di trasloco alla volta di Costantinopoli e di converso, per un singolo particolare, avvalorano le tesi di coloro che propongono una rotta più semplice, dalla Grecia direttamente alla Calabria.
I Bronzi erano stati appena razziati in Grecia e stavano viaggiando verso (e non da) Roma?
Abbiamo due indizi in tal senso:
1) Come già detto all’inizio del blogpost, durante la guerra contro Mitridate, re del Ponto, e poi ancora nel corso della guerra civile tra Mario e Silla (peraltro Argo avea già subìto la distruzione assieme a Corinto nel 146 a.C. al culmine della Guerra Acaica, e sono rimaste famose le spoliazioni a opera di Lucio Mummio), l’Argolide venne ripetutamente saccheggiata dai Romani, che portarono a Roma le opere d’arte più significative. Argo fa parte della zona in cui i Bronzi di Riace furono realizzati: lo sappiamo dall’analisi delle terre di fusione.
2) Conosciamo con sicurezza almeno un altro celebre naufragio di una nave con a bordo un Bronzo di altissima fattura: il Cronide di Capo Artemisio.
Sfortunatamente, parafrasando Agatha Christie, due indizi non fanno una prova (ce ne vogliono tre).
Fra l’altro, senza con questo voler artatamente aprire un altro fronte (cosa che a ogni modo, non resistendo alla tentazione, farò nelle conclusioni!), non è da escludere che al momento dell’antico restauro, se è vero che esso avvenne a Roma (nel I Sec. d.C.?) molti decenni prima del naufragio a Riace e se è vero come è vero che i due Bronzi furono interamente ricolorati di nero, un qualche capriccio imperiale possa aver modificato l’impostazione e l’intento originale delle statue: da atleti olimpici armati di fronde (magari ormai andate perdute) a guerrieri armati di lancia…
Non deve sorprendere l’idea del… “bronzomontaggio” da parte dei Romani. Le opere in bronzo sopravvissute sono pochissime, eppure fra queste ce n’è una che è la prova lampante del fatto che il “pastiche” fosse una pratica se non diffusa comunque non insolita. È il cosiddetto “Spinario”: una scultura oggi conservata ai Musei Capitolini a Roma, raffigurante un giovane seduto mentre, con le gambe accavallate, si sporge di fianco per togliersi una spina dalla pianta del piede sinistro. Ne esistono varie versioni sparse nei musei di tutto il mondo: una marmorea fa parte della collezione degli Uffizi di Firenze e venne copiata da Brunelleschi nella celebre formella del concorso per la porta nord del Battistero del 1401; un’altra copia marmorea si trova al Louvre, una bronzea al Museo Puškin di Mosca.
Lo Spinario fu assemblato nel I Sec. a.C.: al corpo di epoca ellenistica (III Sec. a.C.) fu aggiunta la testa più antica (V Sec. a.C.), e si vede dai capelli, che invece di cadere verso il basso stanno aderenti alla testa, come se la figura fosse in piedi. Gli altri Spinari in giro per il mondo sono derivati dalla statua conservata a Roma. Secondo Paolo Moreno la testa è opera di Agelada e in origine era un Eros; ma la tecnica sopraffina dei capelli può richiamare anche Pythagoras.

La passione sfrenata dei Romani per le statue bronzee greche è rimasta registrata in Plinio:
C’è molta gente così affezionata alle statue cosiddette Corinzie, che se le portan dietro in viaggio, come l’oratore Ortensio la sfinge datagli da Verre reo convinto; a causa di essa Cicerone durante il dibattimento rispose a Ortensio, il quale diceva di non capire gli enigmi, che «doveva invece capirli benissimo, dal momento che aveva in casa la sfinge». Anche Nerone portò in giro l’Amazone […] e poco prima Gaio Cestio, uomo consolare, una statua che teneva seco anche in battaglia.
Si racconta che Lysippos abbia prodotto 1500 opere, e tutte di tal perfezione artistica che ciascuna basterebbe a dar fama all’autore. Il loro numero fu constatato quando, lui morto, l’erede apri lo scrigno, dove Lysippos era solito riporre una moneta d’oro dal prezzo di vendita di ciascuna statua.
Fece più statue Lysippos di ogni altro, artista, come abbiamo detto, di genio fecondissimo. Fra esse notevole l’Atleta che si deterge (apoxyomenos) che Marco Agrippa dedicò davanti alle sue Terme. Questa statua piaceva molto a Tiberio, il quale dando libero corso al suo desiderio — egli che sapeva controllar così bene sé stesso al principio del suo regno — la fece trasportare nella sua stanza da letto, sostituendo un’altra statua al posto di quella. Ma tanta fu l’avversione del popolo romano da chiedere con grande clamore in pieno teatro che fosse rimesso al suo posto l’apoxyomenos; e il principe dovette cedere, egli pur così morbosamente geloso di quella statua.
Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia” XXXIV.48, 37, 62
E gli imperatori non si facevano scrupolo alcuno nell’intaccare il patrimonio artistico che Roma aveva saccheggiato nell’Ellade, come si può capire da questo aneddoto:
È famoso Lysippos per la suonatrice di flauto ebbra, per i cani e la caccia, ma soprattutto per la quadriga col Sole fatta per i Rodii. Fece anche molti ritratti di Alessandro Magno cominciando da quando era fanciullo; quest’ultima statua di Alessandro fanciullo Nerone, cui piaceva moltissimo, la fece dorare; ma poi, il costoso ornamento avendo cancellato la bellezza artistica, fu di nuovo tolto l’oro, e così veniva riputata ancora più preziosa di prima, appunto perché rimanevano visibili le cicatrici e le incisioni che erano servite a fare aderire l’oro.
Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia” XXXIV.63
E c’è da ultimo anche un enigma che nessuno ha mai affrontato né chiarito.
Possediamo copie d’ogni genere, realizzate in marmo dagli antichi Romani, delle opere dei grandi maestri greci del V Sec. a.C.: tanto per dirne una, solo del Discoforo e del Doriforo di Policleto ci sono pervenute decine di repliche. Eppure per i Bronzi di Riace, per i quali possiamo dare per scontato che per la loro bellezza e maestria non potessero passare inosservati a generazioni di imperatori, senatori, consoli, centurioni, semplici benestanti e razziatori vari, non è sopravvissuta alcuna copia in marmo. Eccezion fatta — ma l’attribuzione è contestata — per un fantomatico torso senza braccia né testa e privo di metà delle gambe, che secondo alcuni (fra questi anche il compianto Paolo Moreno e il Museo di Reggio Calabria) sarebbe la replica del “Bronzo B”. Un busto evidentemente così insignificante che lo stesso museo che lo possiede, il Musée Royaux des Beaux-Arts di Bruxelles, non ne pubblica né l’immagine né una sinossi (inutile usare Google: non si trova nulla, l’unica foto è sul libro di Moreno), e che secondo il sito web del Museo di Reggio sarebbe appartenuto alla collezione imperiale romana del Palatino.
È lecito chiedersi: come mai? Come mai non esistono copie in marmo di simili capolavori?
L’unica risposta che viene in mente è che il motivo della loro “invisibilità” presso gli antichi potrebbe essere cronologico: i due eroi di Riace finirono in mare molto presto. Molto prima di quanto possiamo immaginare e di quanto abbiamo teorizzato fino a oggi. Per esempio raccordandosi alla (improbabile) congettura di Stucchi in base alla quale fu Pirro a depredare le opere, forse già in Grecia nel III Sec. a.C. («Pare che dapprincipio il tempio di Delfo fosse da molte genti insidiato. Questo ladrone Euboese, e negli anni seguenti la nazione de’ Flegj, ed inoltre Pirro di Achille lo assalirono» scrive Pausania in “Guida della Grecia” X.7.1: Pirro era della casata di Eacide che proclamava di discendere da Achille — ndr), non lasciando perciò il tempo che la loro esposizione prolungata desse il tempo di stimolarne la riproduzione da parte dei marmisti di Roma e dei loro munifici committenti.
Il che, però, stride con l’antico restauro: i restauratori entrati in azione 5/6 secoli dopo la creazione delle statue non lavorarono certo sott’acqua.

RIANNODARE I FILI
Tentando un compendio con i pro e contro delle ipotesi viste fin qui, le prime due delle quali lo stesso mondo accademico considera le uniche rimaste in piedi:
Eteocle e Polinice (Castrizio)
PRO
- Il dettaglio di Plinio su Pythagoras: «Pitagora fu il primo a riprodurre i tendini e le vene, e a trattare i capelli con maggiore diligenza» (Plinio il Vecchio, Nat. Hist. XXXIV.59). Che è quanto vediamo oggi sul “Bronzo A”, specialmente in merito alle ciocche, fuse una per una.
- Taziano l’Assiro cita esplicitamente Pythagoras come autore di statue di Eteocle e Polinice, opere che a quanto dichiara egli ha visto di persona «nelle città dei Romani» (attorno al 165/170 d.C.) in mezzo a molte altre di origine greca.
- La presenza della caruncola lacrimale in pietra rosa su entrambe le statue indica un unico autore o più probabilmente un’unica scuola autoriale (le presenta anche l’Auriga di Delfi di Sòtada di Tespie, di un quindicennio anteriore al “Bronzo A”).
- Nel II e I Sec. a.C. l’Argolide viene ripetutamente saccheggiata dai Romani, che portano a Roma le opere d’arte più significative.
- La kynê è il segno che contraddistingue lo stratego, il generale dell’esercito di una polis greca: la cuffia sul capo del “Bronzo B” ci dice che siamo in presenza di un capo (Eteocle?) e non di un atleta o di un indovino.
- Il radiocarbonio fornisce un intervallo di date plausibilistico sulla quasi contemporaneità delle due statue (il che costringerebbe peraltro a rivedere tutto quello che sappiamo sugli stili Severo e Classico).
- La traccia sul bicipite destro del “Bronzo B” è compatibile con la presenza di una lancia appoggiata a esso.
Inciso: I punti 1, 2 e 3 sono a prima vista sufficienti per ritenere la teoria del prof. Daniele Castrizio, malgrado le incongruenze (cfr. i contro), la più adeguata fra tutte. Plinio pare proprio descrivere vividamente la tecnica del “Bronzo A”, Taziano assegna a Pythagoras entrambe le statue di Eteocle e Polinice, la caruncola lacrimale depone a favore di una singola matrice autoriale: a meno di non soffrire di pregiudizio di conferma nel leggerle, le due fonti letterarie in pratica sembrano dimostrarsi a vicenda sull’identità dei Bronzi che vediamo oggi esposti a Reggio Calabria.
Il sillogismo Plinio-Taziano-Bronzi contiene però una trappola mentale. Quale? Questa. Diamo per assodato che Plinio stia descrivendo la “Statua A” di Riace quasi fosse il “primo (e/o unico) lavoro” di Pitagora Reggino, e come sottotitolo che nessun altro scultore utilizzò quelle medesime tecniche. Invece Gaius Plinius Secundus detto Plinio il Vecchio — che peraltro non gode di una gran fama di accountability presso gli studiosi (la Naturalis Historia è stata a lungo guardata dalla scienza accademica moderna come un repertorio di notizie ricco ma inaffidabile, e il suo autore come un acritico e confusionario collezionista di nozioni) — dice soltanto che Pythagoras fu l’iniziatore di dette tecniche (dare risalto alle venature, suddividere le ciocche una a una: possiamo aggiungere, sempre per sillogismo, la caruncola lacrimale). Non che fu l’unico! Al contrario: «Fu il primo» sottintende che «ce ne furono altri». E non dice nemmeno che Pythagoras cominciò o continuò o finì proprio con la statua che noi vediamo esposta a Reggio. Il Reggino ne fece molte *, tanto che per esempio qualcuno, sulla stessa base delle parole di Plinio, gli assegna anche il Cronide di Capo Artemisio, il quale presenta caratteristiche stilistiche e realizzative molto simili — e che però precede il “Bronzo A” di almeno un ventennio (vene e tendini sono peraltro visibili sul celeberrimo Auriga di Delfi e in alcune statue a Olimpia, tutti anteriori al “Bronzo A”, stesso dicasi per le caruncole lacrimali dell’Auriga: e anche in questi casi gli studiosi, nel dubbio e con un po’ di pigrizia, indicano Pythagoras fra i possibili autori — con buona pace della firma dello scultore Sòtada sul basamento dell’Auriga).
Andiamoci cauti nel tirare le conclusioni.“Pythagoras lavorava così” e “Pythagoras fece Eteocle e Polinice” sono di per sé due dichiarazioni ben distinte; “i Bronzi di Riace sono Eteocle e Polinice” è una supposizione; “i Bronzi di Riace sono di Pythagoras” è un’altra supposizione. Anche se non sembra, i quattro concetti non hanno alcuna relazione l’uno con l’altro. (Per dirla in un altro modo, sarebbe tutt’altro paio di maniche se per esempio Plinio avesse scritto «…Pythagoras raffigurava l’ira mettendo denti d’argento nelle bocche dei personaggi che scolpiva», oppure «…dotava le sue statue perfino di caruncola lacrimale»: in tal caso avremmo dettagli esclusivi che collegherebbero in maniera diretta, visto che il “Bronzo A” è l’unica statua antica con i denti bene in vista, o che entrambi i Bronzi hanno le caruncole lacrimali fatte ad hoc con pietra rosa — e visto che anche l’Auriga di Delfi ne è dotato, in un sol colpo assegneremmo Bronzi e Auriga a Pythagoras —. Invece disponiamo solo di considerazioni generali e slegate. L’errore di vedervi un legame con i Bronzi è che partiamo proprio con un pregiudizio di conferma: leggiamo Plinio e Taziano avendo già in mente l’assunto “I Bronzi di Riace sono Eteocle e Polinice realizzati da Pythagoras Reggino”.)
D’altro canto, le suddette incongruenze in Castrizio, che esprimerò di seguito, possono apparire assai numerose e circostanziate, tali da invalidare seriamente la “teoria Eteocle-Polinice”. In realtà, come mi auguro si capisca bene alla fine, neanche queste sono ancora decisive. La verità è che Castrizio (e ormai con lui buona parte del mondo accademico, lo stesso Museo di Reggio e perfino Wikipedia) potrebbe essere “quello che ci è andato vicino”: ma non abbiamo ancora la piena certezza che le sue due… frecce bronzee siano conficcate proprio al centro del bersaglio — o, se è per questo, che lo abbiano mancato.
NOTA (*): Tutte le opere che in oltre un secolo di studi sono state attribuite a Pitagora Reggino, in un elenco raccolto da Antonino Di Vita (cfr. volume “Lo Stile Severo in Grecia e in Occidente: aspetti e problemi” a cura di Antonella Mandruzzato, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 1995).
1) Torso Valentini = il Filottete di Siracusa (1°). 2) Piccolo bronzo di Catania (Filottete). 3) Perseo di Napoli e sue repliche. 4) Teste supposte del Perseo (Roma-Londra). 5) Efebo di Adrano (Leontiskos?). 6) Statuetta di bronzo da New York (da Smirne; «l’Adorante»). 7) Atleta, sostegno di specchio da Locri. 8) Cd. Epimeteo di Dumbarton Oaks. 9) Discobolo di Stuttgart. 10) Satiro al Cabinet des Médailles. 11-19) Nove bronzetti a Roma, Boston, Siracusa, Lugano (due), Londra, Bari, Sparta, Louvre, messi in rapporto con la produzione di Pitagora 0 sotto il suo influsso. 20) Bronzetto di peplophoros a Catania (da Locri?). 21) Auriga di Delfi. 22) Discobolo Ludovisi. 23-29) Sette teste di atleti a New York (due), Vaticano (tre), Roma, British Museum, mercato antiquario. 30) Atleta Cirene-Perinto. 31) C.d. Polluce del Louvre. 32) Apollo saettante dal tempio di Sosio. 33) Acrolito di Cirò. 34) Europa (terracotta) da Taranto. 35) Europa su manico di specchio da Locri. 36) Apollo dell’Omphalos Apollo Choiseul-Gouffier e repliche relative. 37) Auriga dell’Esquilino. 38) Cronide di Capo Artemision. 39) Zeus della metopa del tempio E di Selinunte. 40) Dioniso su monete di Naxos. 41) Zeus su un conio di Messana-Zancle. 42-45) Quattro teste a Hannover, a Vienna, a Dresda, a Villa Adriana (nonché numerose terrecotte da Medma) confrontabili con le metope del tempio E di Selinunte. 46) Testa di Zeus dalla Gaggera. 47) Testa fittile da Medma. 48) Testa a Taranto. 49) Terracotta da Locri. 50) Testa fittile dalla Magna Grecia. 51) Testa di Athena al Barracco. 52) Testa da Palestrina a New York. 53) Testa italiota. 54) Spinario capitolino. 55) Atleta di Stephanos. 56) Idolino di Firenze. 57) Eros Soranzo all’Ermitage. 58) Apollo di Kassel. 59) Ares Somzée a Monaco. 60) Citaredo all’Ermitage. 61) Trono Ludovisi. 62) Oplitodromo di Tübingen. 63) Testa Chatsworth. 64) Venere dell’Esquilino. 65) Efebo di Mozia. 66-67) Bronzi di Riace.
A queste opere si aggiungano conii in cui sarebbero vivi riflessi dell’opera di Pitagora, databili fra il 460 e il 420 a.C., di Crotone, Gela, Katane, Siracusa, Naxos, Reggio, Metaponto, Selinunte, Imera, Zancle, Cirene.
Si tratta di circa un’ottantina di attribuzioni. «E auguriamoci che non si trovino altre sculture di stile Severo in Magna Grecia e in Sicilia, ’ché allora l’opera di Pitagora sarà ancora più ricca e poliedrica!», conclude sconsolato Di Vita.

CONTRO
- Troppe le statue presenti in Grecia, e troppe le razzìe operate specialmente dai Romani, per poter relazionare l’appartenenza dei Bronzi di Riace proprio a un preciso tema statuario della saga di Tebe (Pausania ricorda una decina di gruppi scultorei del V Sec. a.C. già nella sola Delfi).
- A tutt’oggi non abbiamo prove dell’esistenza di un gruppo bronzeo comprendente tutta la scena del “fermo immagine” con i due fratelli che si fronteggiano, la madre a seno scoperto che li supplica, Edipo/Creonte/Tiresia e Antigone. Un gruppo che sarebbe stato imponente: eppure sfuggito a tutti i grandi osservatori dell’epoca (Erodoto, Tucidide, Zenone, Ellanico, Polibio, Demostene, Senofonte e decine d’altri, senza tirare in ballo i soliti Platone e Aristotele…). Il nostro punto di riferimento per il “fermo immagine” è il gruppo marmoreo del sarcofago in stile attico conservato a Villa Doria Pamphilj a Roma, risalente al II Sec. d.C., e dal momento che nella romanità erano diffusissime le copie di originali bronzei greci (i marmisti romani raggiunsero un livello di “mimesis” incredibilmente elevato), è lecito supporre che questo fantomatico gruppo a 5 sia effettivamente esistito in Grecia — e poi sia stato trafugato dai Romani. Tuttavia la liceità di una supposizione non è ancora una testimonianza.
- Publio Papinio Stazio avrebbe visto a Roma, forse nel palazzo imperiale, il magnifico gruppo a 5 con Giocasta che espone il seno disperata, e ne avrebbe tratto ispirazione per la sua Tebaide. Questo il passo cruciale nel libro XI dell’opera (nella traduzione settecentesca del cardinale Bentivoglio), che secondo Castrizio allude a quanto Stazio ammirò:
«…Ma il primo avviso del furor fraterno/ appena giunge alla furente madre,/ che gli dà fede, e n’ha spavento, e corre/ lacera il crine e il volto, e sanguinosa/ e ignuda il petto di Baccante in guisa,/ dimenticando la vergogna e il sesso…».
Eppure il ragionamento ha una logica che può essere facilmente rovesciata. La Tebaide di Stazio uscì nel 92 d.C. e divenne presto celebre; il gruppo marmoreo di Villa Doria Pamphilj risale a uno o due secoli più tardi, sempre a Roma: non potrebbe esser stato lo scultore (o ancora meglio il suo committente) a ispirarsi alla tragedia di Stazio?

Le urne sono una tipologia di manufatti tipica dell’artigianato etrusco dell’età ellenistica. A partire dalla metà del III Sec. a.C., nell’area volterrana (Pisa) si sviluppa la fabbricazione di urne sia in tufo, sia in pregiato alabastro. La cassa delle urne è in genere decorata con scene mitologiche in particolare tratte dalle saghe della guerra di Troia (immagine in basso a sinistra) e dei Sette contro Tebe (tutte le altre figure), particolarmente apprezzate nel mondo etrusco, mentre il coperchio, realizzato separatamente, prevedeva la figura del defunto semisdraiato a banchetto (schema già diffuso per i sarcofagi).
In nessuna di queste raffigurazioni a rilievo è mai presente Giocasta che si straccia le vesti e rimane a seno nudo cercando di dividere i figli: questo tema, a giudicare dal bassorilievo di Villa Doria Pamphilj, sembra essere successivo al I Sec. d.C., forse influenzato dai versi presenti sulla Tebaide di Stazio. E oltretutto è limitato a un solo esemplare integro giunto fino a noi.



Nei dolia sono stati rinvenuti i resti di almeno 400 stampi in terracotta che servivano a realizzare oggetti semicircolari della dimensione di una mano. Gli oggetti avevano tutti lo stesso peso. Su entrambi i lati o intorno agli oggetti veniva impresso un rilievo: erano raffigurati animali, scene di teatro, anfiteatro e circo, scene erotiche e mitologiche, nature morte. Stampi simili sono stati ritrovati nella metà occidentale del Nord Africa, sulla costa orientale della Spagna, nel sud e nell’est della Francia, in Italia, forse in Austria, e in Grecia. Sono tutti notevolmente simili, sono stati probabilmente realizzati in Nord Africa e sono da datare alla fine del II e alla prima metà del III Sec. d.C..

Non sappiamo quale fosse — ammesso che ci fosse — la scena del “duello finale” nelle primissime versioni del mito, l’Edipodia di Cinetone (cfr. più avanti la Nota 3) e la Tebaide di Stesicoro; con l’avvento dei grandi tragediografi classici, coevi ai Bronzi, si delinea una sceneggiatura: ma in Eschilo i due fratelli si uccidono tra loro senza che la madre intervenga (di più: il duello nemmeno viene descritto perché è un messaggero a dare la notizia che i fratelli si sono uccisi a vicenda), e mezzo secolo dopo che il primo dei due Bronzi (“A”) è stato realizzato, Sofocle scrive una tragedia in cui Giocasta si era già suicidata quando aveva compreso di aver sposato il figlio Edipo, anni prima del duello fratricida fra Eteocle e Polinice. Vent’anni dopo Sofocle, quando ormai è stato superato abbondantemente il limite cronologico anche del secondo Bronzo (“B”), in Euripide compare il tema del seno mostrato “ad misericordiam” dalla madre. Ed è soltanto quando arriva in terra latina, ben 5 secoli dopo, che la tragedia si arricchisce del tema definitivo: Stazio abbonda di particolari sulla madre che si straccia le vesti — e in più episodi lungo l’intera vicenda, non solo prima del duello.
Dunque, osservando strettamente le fonti, il tema «guardate, figli, questo è il seno che vi ha allattato!» di Giocasta è successivo ai Bronzi di Riace. Non precedente.
(Bisognerebbe presupporre che sia stato non Stazio nel I Sec. d.C. bensì già Euripide al termine del V Sec. a.C., a ispirarsi al bronzeo “gruppo a 5” con Giocasta in topless, che Pythagoras avrebbe realizzato ispirandosi a sua volta alla versione magnogreca del mito… Ma forse una simile congettura pretenderebbe una dose esagerata di sospensione dell’incredulità.)
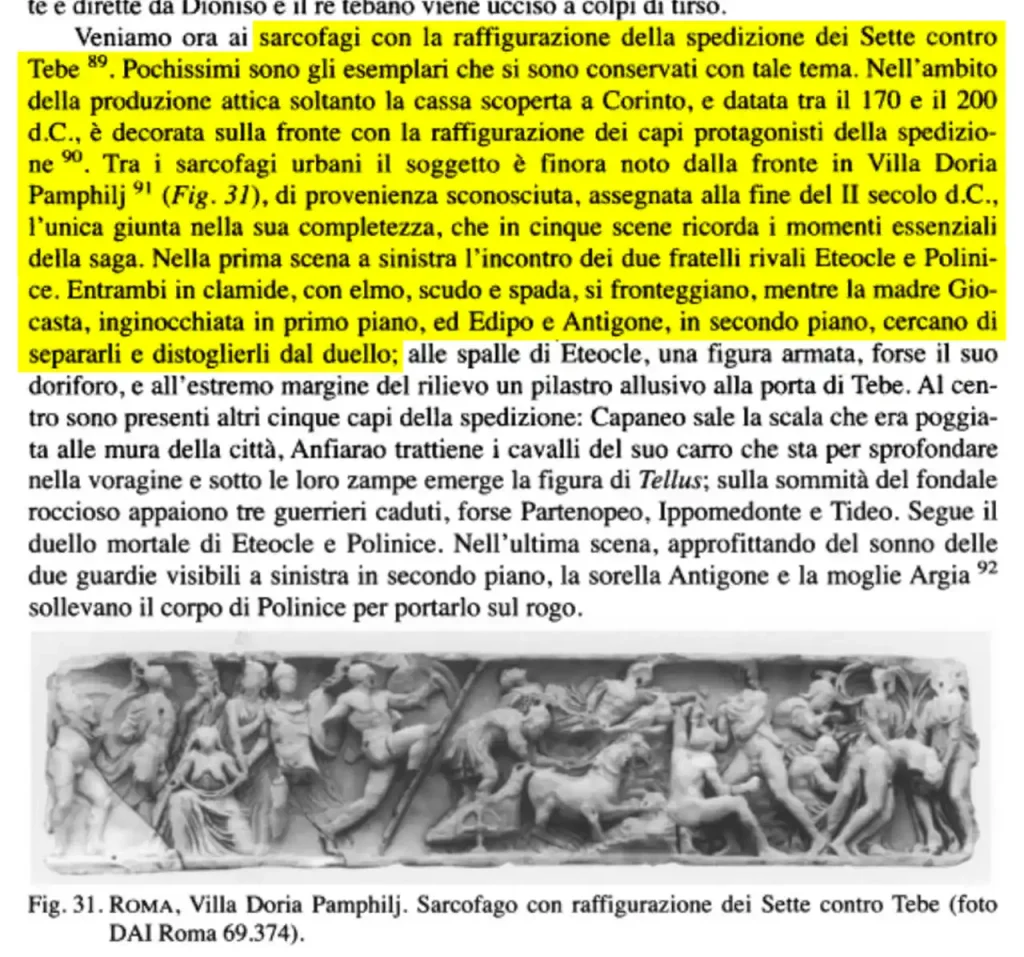
- Osservando i bassorilievi di due millenni fa alla ricerca di Giocasta che si straccia le vesti e mostra il seno, viene spontaneo notare che praticamente tutta l’iconografia di Eteocle e Polinice in duello è costituita da corpi in azione: la loro è sempre una raffigurazione dinamica. Perfino sul bassorilievo di Villa Doria Pamphilj la concitazione delle figure è massima. Le due statue di Riace, invece, sono in posizione “rilassata”: la posa tipica, stante, dei kouroi dei periodi Severo/Classico. Si tratta di una posa che caratterizzava le esedre e i santuari, dove gli eroi e gli dèi erano esposti uno a uno. Non dà l’idea di far parte di un gruppo “sceneggiato”, come quelli che si vedono appunto sui bassorilievi di Villa Doria Pamphilj o dei sarcofagi etrusco-ellenistici di ispirazione attica, in cui c’è sempre movimento.
- E a voler essere fiscali e inappuntabili, va notato infine che il “gruppo a cinque” di Villa Doria Pamphilj non ha 5 figure bensì 18 (più un cavallo). È una vera e propria “sceneggiatura in bassorilievo”: la sinossi in marmo della Tebaide di Stazio.
- I Bronzi di Riace sono stati prodotti da officine diverse, da artefici diversi, distinguibili sotto il profilo degli approvvigionamenti e della tecnica; e al di là delle analisi dei materiali anche la comparazione stilistica fra Severo (Bronzo A) e Classico (Bronzo B) ci dicono che intercorrerebbe un trentennio fra le due opere — comparazione tuttora non definitivamente contraddetta dal radiocarbonio né da altri esami.
A questo proposito, le teorie di Odo Pavese, Di Vita e tutti gli altri, che dimostrano dati alla mano le differenze di stile fra i due Bronzi di Riace, sono state buttate a mare in toto (come si dice, gettare via il bambino e l’acqua sporca) dopo le analisi approfondite degli Anni ’90; tuttavia in tali teorie, una volta epurate della parte “oplitodromi” e “ramoscelli in mano”, l’impianto artistico rimane esame limpido e inoppugnabile, per merito peraltro della bravura dei marmisti dell’Antica Roma, i quali svilupparono (sicuramente grazie al know-how degli schiavi “importati” dalla Grecia insieme alle opere, ma è vero anche che erano organizzati in botteghe che possedevano calchi delle opere più richieste, in modo da poterle produrre quasi in serie) tecniche di copia cristalline che hanno consentito di non perdere nulla della maestria di genî come Policleto, Fidia, Mirone, Lisippo (e Pitagora Reggino!). Il problema degli stili differenti è così importante che lo stesso Castrizio si è sentito in dovere di intervenire in merito, sebbene l’argomento usato («conosciamo bene la scultura di Atene ma non quella fuori Atene», cfr. qui sopra immagine del brano tratto dal suo libro) sia impalpabile. - La “rotta di Costantino” ha un’attestazione tardissima (X Sec. d.C.).
- L’intuizione del nipote di Pythagoras (Sostrato) quale continuatore dell’opera dello zio — sottintendendolo autore del “Bronzo B” — non è supportata da evidenze, e l’indizio della tortuosa e confusa citazione di Plinio (Nat. Hist. XXXIV.60), unico autore antico a nominare questo Sostrato, è troppo labile. (Il che peraltro va a fare il paio con Clearco di Reggio conosciuto da un unico autore antico, Pausania: eppure ciò non ha impedito di ipotizzare perfino un’irrealistica “scuola di scultura reggina”, citata anche su Wikipedia, i cui esponenti sarebbero stati “Learco” — mai esistito —, Clearco, Pitagora e Sostrato… ma questo è un altro problema, inutile divagare.)
- Pausania nel II Sec. d.C. vide sia nell’agorà di Argo che a Delfi dei gruppi statuari dedicati ai protagonisti del Ciclo Tebano che comprendevano Polinice: quelle statue non erano ancora arrivate a Roma — se mai ci arrivarono —. Evidentemente come già accadeva per quasi tutti i miti greci, da Zeus ad Apollo a Minerva, ritratti non uniformemente ma nelle più disparate situazioni, anche di Polinice poterono esistere sia versioni “semplici” (in questo caso quelle viste da Pausania ad Argo e Delfi) che versioni “sceneggiate” (in coppia con Eteocle per i fratricidi forse visti da Taziano). D’altro canto è possibile e forse probabile che quanto visto da Pausania ad Argo e a Delfi fossero opere successive: gli Argivi, ripetutamente derubati non solo dai Romani ma da vari popoli egei (Eubei, Flegi e perfino Pirro, cfr. Pausania, X.7.1), rifecero comunque le statue dei Sette e degli Epigoni in epoca ellenistica (della serie, «più voi ce le rubate e più noi le rifacciamo»). A ogni buon conto, perché il ragionamento stia in piedi il… “Polinice di Riace” dev’essere per forza di cose quello nominato da Taziano: perché è in coppia con Eteocle. Tuttavia l’Assiro passò alla storia come uno dei primissimi feroci polemisti del neonato cristianesimo: come mai, se davvero vide coi propri occhi un gruppo scultoreo come quello di Villa Doria Pamphilj, non se la prende anche con la figura di Giocasta/Euriganeia, colei che è inginocchiata a offrire disperata il seno nudo per tentare di sventare la duplice morte dei “frutti del suo incesto”?
Infatti non è difficile che il fratricidio sia tenuto in onore presso di voi, che, vedendo le statue di Polinice e di Eteocle, non distruggete il ricordo di quell’infamia, seppellendole con il loro autore Pitagora.
Taziano, “Adversus Graecos” 34
Seguendo la logica della teoria, in questo passo ci si sarebbe dovuti aspettare un’invettiva non solo contro Eteocle e Polinice ma anche (e forse soprattutto) contro la loro insana madre, che si è resa protagonista dell’incesto con Edipo da cui sono nati Eteocle e Polinice. Quale migliore occasione di un incesto, per rinforzare le accuse d’immoralità che Taziano rivolge ai popoli pagani della Grecia? Così:
Infatti non è difficile che l’incesto e il fratricidio siano tenuti in onore presso di voi, che, vedendo le statue di Polinice e di Eteocle e di Giocasta, non distruggete il ricordo di quell’infamia, seppellendole con il loro autore Pitagora.
Taziano nei capitoli 33 e 34 espone un elenco di “persone prive di valore” e molto dubbie dal punto di vista morale, che però artisti greci figurativi hanno trovato degne di essere immortalate in una statua (il che dovrebbe naturalmente mostrare che l’arte figurativa dei Greci non merita ammirazione), e, fra queste, una serie di donne (finanche una «donnetta» famosa per aver partorito trenta figli) e perfino di dee, tutte a suo avviso di indubbia immoralità. Le sue parole non risparmiano epiteti: meretrici, baldracche, prostituzione, fornicazione. Sorprende, dunque, l’assenza di Giocasta, protagonista di un episodio largamente scabroso.
Insomma, non solo Pausania ma anche Taziano restituisce l’impressione d’aver visto non un gruppo statuario formato famiglia ma soltanto due singole statue. Due statue non accompagnate dalle altre dei Sette e degli Epigoni, perché altrimenti non vi sarebbe stato raffigurato Eteocle.
E non è tutto, perché anche dove le abbia viste è in realtà problematico:
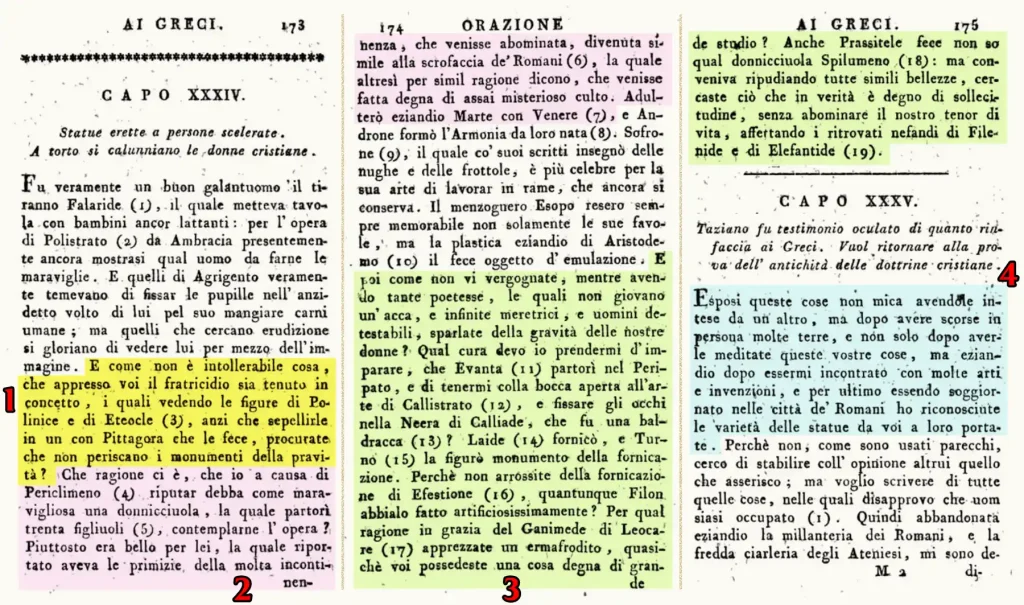

«Esposi queste cose non mica avendole intese da un altro, ma dopo avere scorse in persona molte terre, e non solo dopo averle meditate queste vostre cose, ma eziandio dopo essermi incontrato con molte arti e invenzioni e per ultimo essendo soggiornato nelle città de’ Romani ho riconosciute le varietà delle statue da voi a loro portate». (Discorso ai Greci XXXV)
Non sta parlando esattamente di Roma: «le città de’ Romani» erano centinaia, nel II Sec. d.C., date le dimensioni dell’Impero Romano, arrivato ai suoi massimi proprio in quell’epoca. Ed è acclarato che in molte di esse (se non in tutte) ci fosse arte greca. Lui stesso, infaticabile viaggiatore1, parla dell’Europa sul toro di Pitagora che da Cicerone e Varriano sappiamo presente a Taranto. Non possiamo dunque essere sicuri che Taziano vide le statue pitagoriche di Eteocle e Polinice a Roma (implicitamente confermando Stazio, come vorrebbe il prof. Castrizio): potrebbe averle viste ovunque.
NOTA (1) – Della vita di Taziano sono noti pochissimi particolari. Originario dell’Adiabene (alta Mesopotamia), fu educato da un filosofo/rétore greco. In gioventù viaggiò a lungo entrando in contatto con il pensiero di molti filosofi. Durante questi viaggi, disgustato dall’avidità dei filosofi pagani con i quali era entrato in contatto, concepì un profondo disprezzo per i loro insegnamenti. Intorno al 150, attratto dalla religione cristiana e dalla semplicità delle Sacre Scritture, si convertì unendosi alla comunità di Roma, dove divenne un seguace di Giustino.
Finché fu in vita Giustino (163/167 d.C.), Taziano si affermò come uno dei più convinti sostenitori del Cristianesimo. Successivamente, attorno al 172 passò al gruppo gnostico degli Encratiti e ritornò in via definitiva in Oriente. Le circostanze e la data della sua morte sono sconosciute.
Taziano compose molte opere, ma ne sono sopravvissute solamente due. La prima, risalente al periodo ortodosso e conservatasi per intero, è appunto l’apologia del Cristianesimo intitolata Πρὸς Ἕλληνας (ma meglio nota come Oratio ad Graecos o Oratio adversus Graecos), e fu scritta dopo il 165: quando aveva già lasciato Roma.
In Oriente, dove lo troviamo nel 172, fondò una scuola (il didaskaleion), e specialmente ad Antiochia di Siria, in Cilicia e in Pisidia, esercitò la sua attività d’insegnante, che già dopo il martirio di Giustino s’era volta decisamente all’eresia degli gnostici e precisamente a quella di Valentino.
Per maggiori informazioni sugli gnostici e sui “cristianesimi perduti”, cfr. il mio libro Cerco il Figlio.
- Resta poi da chiarire come mai un artista magnogreco residente in Italia2 sia stato incaricato di realizzare un impegnativo e dispendioso gruppo scultoreo (una “scena-fotogramma” non con una o due statue ma con ben cinque personaggi) per il mito fondativo di una città molto lontana dalla Magna Grecia3, sia nel tempo che nello spazio (Argo), per la cui ispirazione lo stesso scultore attinge a una tradizione magnogreca tutto sommato marginale4 e “non mainstream” per la sua epoca (Eschilo era appena andato in scena con successo ad Atene con un’altra versione), e perdipiù utilizzando terre di fusione dell’Argolide… Posta così, aderendo pedissequamente ai testi antichi, la faccenda risulta un po’ troppo arzigogolata.
La realizzazione di sculture del genere era sempre dovuta alla committenza di una città o comunità che intendeva celebrare i propri eroi, fossero essi dèi, miti fondativi oppure atleti impostisi alle Olimpiadi (tre categorie ugualmente sacre per gli antichi Greci), impegnando un artista e la sua bottega per oltre un anno di lavorazione su ogni statua, e in più mettendogli a disposizione un materiale, il bronzo, piuttosto costoso.
Peraltro, come insegnano gli esperti, l’episodio del mito dei Sette più frequentemente rappresentato nell’arte vascolare grecoantica è la partenza di Anfiarao, non il duello fratricida, tant’è che addirittura la tecnica pittorica delle anfore etrusco-corinzie (“pontiche”) dei due secoli che precedono l’età classica viene ripartita, in base ai tre artigiani identificati, fra “pittore di Paride”, “pittore di Tityos” e appunto “pittore di Amphiaraos”. La scena della partenza compare infatti su tutti e tre i reperti superstiti del VI Sec. a.C. (cliccare sulla miniatura per ingrandire le immagini) con raffigurazioni dalla saga tebana ed è l’unica, tra le altre, che possiamo interpretare con certezza. Le raffigurazioni sui tre manufatti sono sorprendentemente simili: sulla lamina bronzea dell’inizio del VI Sec. a.C. da Castellina in Chianti mancano il tiro di cavalli e l’auriga, ma le altre tre figure, Anfiarao, Erifile e Alcmeone corrispondono pienamente ai loro pendants sulle due anfore pontiche conservate a Monaco e a Basilea (su quest’ultima si legge addirittura il nome “Tideo”, uno dei personaggi in partenza, sul relativo scudo).
Il duello fratricida era comunque ben noto non solo in Grecia ma anche nella penisola italica, tant’è vero che la più celebre iconografia del mito dei Sette contro Tebe in Italia è considerata — o almeno lo era fino all’affermarsi della teoria sui Bronzi di Riace — il frontone in terracotta del Tempio di Talamone, nell’odierna provincia di Grosseto, in Toscana, risalente al 150 a.C., reperto di epoca etrusco-ellenistica, che ritrae la conclusione del duello: al centro della scena i corpi morti dei due fratelli vengono portati via, mentre intorno è raffigurata la fine degli altri eroi della spedizione. (Neanche qui è presente Giocasta in topless — ndr)
NOTA (2) – È Plinio il Vecchio (Nat. Hist. XXXIV.59) ad affermare categoricamente che «Vicit eum Pythagoras Reginus ex Italia», ossia che Mirone fu superato da Pitagora (il) Reggino «dall’Italia»: un artista magnogreco attivo nella penisola italica, non greco attivo in Grecia.
Non sarebbe molto serio giurare sull’affidabilità di Plinio in un caso («Pythagoras fu il primo a fare vene e tendini, e diligenti ciocche dei capelli…») e poi dirlo inaffidabile in un altro («Pythagoras Reginus ex Italia»). Ciò nondimeno una via d’uscita è offerta nella Nota 3 che segue.
NOTA (3) – A quale tipo di monumento erano destinati i due Bronzi? L’attenzione si concentra sulla notizia di Pausania (II.20.4) relativa all’agorà di Argo, dove c’era un monumento dedicato all’impresa dei Sette contro Tebe. Quello dei Sette era un mito antichissimo, cantato nella già ricordata Tebaide, poema epico quasi completamente perduto che qualcuno attribuiva a Omero ma che probabilmente era precedente all’Iliade, così come i fatti narrati, fra storia e leggenda, erano anteriori alla Guerra di Troia: come già detto all’inizio fu ripreso da Eschilo in una tragedia rappresentata ad Atene nel 467 a.C. e, più tardi, dal poeta latino Stazio. La trama è nota: Eteocle e Polinice, dopo l’allontanamento del padre Edipo da Tebe, non trovano un accordo per la successione, e alla fine decidono che regneranno un anno ciascuno. Il primo turno è di Eteocle, che però a fine mandato non lascia il trono; Polinice va ad Argo, e alla corte del re Adrasto incontra Tideo (padre dell’eroe omerico Diomede) con cui concorda di attaccare Tebe. Al comando di Adrasto partono sette eroi: oltre a Tideo e Polinice, Capaneo, Eteoclo (da non confondere con Eteocle), Ippomedonte, Partenopeo, Anfiarao. Tideo viene mandato in ambasceria: non solo la situazione non si sblocca, ma subisce un agguato di ben cinquanta tebani, che però riesce a sgominare. Gli autori antichi, a partire da Eschilo, descrivono con dovizia di dettagli la sua belluina violenza, il suo forsennato vigore, la sua aggressività sconfinante nell’antropofagia. Ognuno dei Sette ha il compito di attaccare una delle sette porte della città, ma Eteocle pone altrettanti comandanti a difesa. Tutti gli assalitori muoiono (Tideo, in particolare, dopo essere stato mortalmente ferito e, malgrado questo, aver azzannato alla testa il rivale Melanippo), Eteocle e Polinice si uccidono a vicenda, sopravvive solo Anfiarao che era quello che aveva partecipato con più perplessità all’impresa poiché, dotato di virtù profetiche, aveva previsto l’insuccesso.
Qual è il punto?
Il punto è che ci si potrebbe domandare perché Argo volesse celebrare con un grande monumento un’impresa così sfortunata. In realtà, la base nell’agorà della città ritrovata dagli archeologi (a conferma delle parole di Pausania) ospitava una ventina di statue: non solo i Sette, ma anche gli Epigoni, i “discendenti” che, una generazione dopo, avevano vendicato quel disastro, distruggendo Tebe. Il riferimento all’antichissima leggenda assumeva così la funzione di proiezione nel mito (cosa non insolita nella cultura greca) di eventi storici: in questo caso la lunga lotta con Sparta. Nel 494 a.C. gli argivi erano stati battuti dagli spartani a Sepeia, e avevano perso il controllo di Tirinto e Micene, ma nel 461, alleati con Atene, avevano vinto a Oinoe, riprendendosi le due città. In quella stessa fase centrale del V Sec. a.C., la cupa grandezza dell’antica vicenda dei Sette ispirava un magnifico poeta tragico come Eschilo: i Bronzi di Riace furono eseguiti nel giro di anni in cui veniva completata e poi rappresentata la tragedia, e il fatto che almeno per uno dei due sia stato supposto un grande autore argivo ha indotto Paolo Moreno a stabilire un nesso proprio con il monumento illustrato da Pausania.
Al di là di ogni ragionevole dubbio, pertanto, la committenza («il cliente», diremmo oggi) di simili opere non poteva che essere la comunità di Argo: non aveva nulla a che vedere con la Magna Grecia non solo materialmente, come dimostrano le analisi delle terre di fusione, ma proprio in senso socio-culturale.
Dobbiamo dunque da un lato ammettere che non conosciamo affatto bene la traiettoria di Pythagoras di Reggio, e che pur trasferitosi nella Magna Grecia oppure essendovi nato (terra che culturalmente gli avrebbe fornito l’antica versione di Stesicoro anziché quella coeva — e molto più in voga — di Eschilo) la sua attività continuasse a svolgersi prevalentemente nel Peloponneso.
A quanto apprendiamo dalle fonti, Pythagoras era già a Reggio da circa 36 anni, quando il primo dei due Bronzi, la “Statua A”, uscì dalla fornace. Tuttavia l’attività come bronzista di Pitagora Reggino è fissata dalla cronologia delle vittorie ai giochi panellenici degli atleti che Pitagora immortalò nel bronzo, tra il 480 a.C. e il 448 a.C. (che poi è esattamente tutto il lasso di tempo dello stile Severo, si potrebbe quasi affermare che Pythagoras SIA lo stile Severo): dunque verosimilmente viaggiava molto, e aveva parecchia committenza nelle città della Grecia. Lo stesso suo maestro Clearco di Reggio (Kléarchos Rhegínos), in base a Pausania (III.17.6) passava per essere stato il primo artista a realizzare statue colossali in bronzo, quali lo Zeus Altissimo (Zeus Hypatos) nel tempio di Athena Chalkioikos a Sparta.
L’eco della bravura di Pythagoras era ancora viva addirittura sette secoli dopo: Diogene Laerzio nel III Sec. d.C. ricorda (Vite dei filosofi VIII.47) che Pythagoras studiò l’articolazione della figura nello spazio: «E si dice che vi fu un altro Pitagora, scultore di Reggio, che, a quanto sembra, per primo cercò di realizzare ritmo e simmetria».
Perciò, oltre a Plinio e ai perduti trattati di Senocrate di Sicione cui Plinio attinge, esiste un’altra attestazione che descrive Pythagoras come un numero uno della scultura, e non solo per i dettagli (vene, tendini e capelli) ma proprio in generale: un talentuosissimo innovatore. Chiamato a lavorare in tutta l’Ellade: Grecia, Puglia, Calabria, Sicilia.
E dall’altro lato supporre che anche le dinamiche evolutive del mito dei Sette contro Tebe non sono state ancora comprese interamente.
Perché altrimenti non si capisce il motivo per cui Pythagoras avrebbe dovuto attingere a una fantomatica versione magnogreca dei “Sette contro Tebe” — quella di Stesicoro — invece che a quella ben più nota e di successo che circolava nell’Ellade — quella di Eschilo.
Più antico di Stesicoro esisteva d’altro canto nell’antichità un ulteriore poema epico in tema tebaide, oggi perduto, L’Edipodia: ne restano appena tre frammenti. Sappiamo da Eusebio di Cesarea (Chronicon, 4.1) che era stato scritto nel 764-763 a.C. da tale Cinetone di Sparta. Plutarco (Sugli oracoli della Pizia 407b) afferma che Cinetone «aggiunse agli oracoli uno stile pomposo e drammatico non necessario». E il solito Pausania (IX.5.5-6), forse attingendo al poema di Cinetone, scrittore «Lacedemone» che egli nomina tre volte come «autore di genealogie in versi», ci dice che il matrimonio tra Edipo e la madre Giocasta era stato senza figli, e questi ultimi erano nati da una precedente relazione di Edipo con Euriganeia (nello stesso passo scrive: «Onata [scultore coevo di Pythagoras — ndr] dipinse Euriganeia con volto triste per la pugna de’ figli»: qui la madre per la “scena-fotogramma” è un’altra). Quindi conclude: «E avendo [Polinice] pregato Adrasto a dargli un esercito, che lo riconducesse, perde l’armata; e combatté a solo con Eteocle, secondo la disfida: e combattendo morirono ambedue». Cambiano alcuni particolari ma non l’esito: c’è sempre un duello fratricida da cui nessuno dei due esce vivo. E c’è una madre sofferente.
NOTA (4) – Ho cercato di andare a fondo in tale questione di Stesicoro, alla ricerca della sua primigenia versione dei “Sette contro Tebe” per capire in che modo e fino a che punto potesse entrare nella questione. E non ci sono riuscito. (Anzi, a quanto sembra di capire a una prima lettura superficiale, nel brano di Stesicoro — cfr. riquadro successivo — addirittura Giocasta convince Eteocle e Polinice a non duellare!) In ogni caso, anche l’attribuzione del poco che abbiamo è assai incerta.
Frammenti di una “Tebaide” o “Sette contro Tebe” furono originariamente ipotizzati dallo studioso David Campbell (Greek Lyric, Loeb Classical Library, 1983) in base al frammento più lungo attribuito a Stesicoro, scoperto nel 1974 tra gli involucri di una mummia del II Sec. a.C. conservato presso l’università di Lille, generalmente noto come il “Lille Stesichorus” o Papiro di Lille; esso presenta un discorso di una regina tebana, che si pensa sia Giocasta, ai figli Eteocle e Polinice. Tuttavia altri studiosi hanno negato l’attribuzione a Stesicoro, per esempio a causa della «monotona e ripetitiva flaccidità» del brano.
Stesicoro, considerato un genio dai suoi contemporanei, utilizza il dialetto dorico nella sua espressione più aulica e letteraria e fonde lo stile formulare proprio dei poemi omerici con un linguaggio intimistico: poeti successivi, soprattutto i Tragici, ammirarono il periodare ampio, la narrazione solenne e gli sperimentalismi verbali stesicorei e ne trassero ispirazione. Stesicoro viene d’altro canto ricordato per la sua megaloprépeia, ossia per la “gravità e sublimità dello stile” (espressione coniata da Dionigi di Alicarnasso) e per il forte peso della tradizione omerica all’interno della sua opera. Nel I Sec. d.C. il retore Quintiliano (X.1.62), se da un lato elogia in Stesicoro la capacità di attribuire ai suoi personaggi l’appropriato rilievo sia nell’agire sia nel parlare («reddit enim personis in agendo simul loquendoque debitam dignitatem») ne sottolinea d’altra parte la diffusa ridondanza («sed redundat atque effunditur»).
Anche sulla vita di Stesicoro possediamo poche e incerte notizie, a partire dal nome: quello vero sarebbe stato Tisia. Il nome Stesicoro (che in greco significa “ordinatore di cori”, secondo quanto attesta il Lessico Suda— σ 1095 IV.433.16-20 Adler = Stes. TA 10, 1-5 Ercoles1 —, enciclopedia bizantina dell’antichità classica) era un epiteto che gli fu dato perché sistemò per primo i canti corali in triadi composte da una strofe, un’antistrofe e un epodo, e «per primo, istituì un coro con la citarodia». In breve, inventò la lirica corale: quell’immagine stereotipata a noi così familiare, grazie ai pittori preraffaelliti inglesi dell’Ottocento, del poeta che declama accompagnandosi con una cetra, a volte con il supporto di un coro. Nacque forse a Metauro (l’odierna Gioia Tauro, in provincia di RC) nella Magna Grecia, attorno al 630 a.C., ma visse quasi sempre a Imera, in Sicilia, circondato da grande prestigio, e qui si svolse dunque la sua attività di poeta. Aristotele (Rhet. 1393b) lo connette con il tiranno di Agrigento Falaride (570–554 a.C.), da cui il poeta avrebbe invano cercato di mettere in guardia gli abitanti di Imera, quando essi gli si assoggettarono. Fu anche chiamato nella Grecia continentale, in particolare a Sparta (peraltro, città nemica di Argo). Morì attorno al 550 a.C. probabilmente a Catania, dove si trova la sua tomba.
I grammatici alessandrini raccolsero le sue composizioni in 26 volumi, ma di questa vastissima produzione restano solo titoli e scarsi frammenti.
LA QUESTIONE DEI DENTI
Per inciso, non ho rintracciato nemmeno il famoso “digrignar di denti” di Polinice — che ormai si legge perfino su Wikipedia — nella Tebaide di Stazio. Il quale si esprime semplicemente così:
…sic hostile tuens fratrem; namque uritur alto/ corde quod innumeri comites, quod regia cassis/ instratusque ostro sonipes, quod fulva metallo/ parma micet, quamquam haud armis inhonorus et ipse/ nec palla volgare nitens: opus ipsa novarat/ Maeoniis Argia modis ac pollice docto/ stamina purpureae sociaverat aurea telae.
(Stazio, Tebaide XI.396-402)
…in lui volge nemico lo sguardo, e invidia il rode in rimirarlo cinto da turba di seguaci, e su la fronte portar elmo regale, e il gran destriero d’ostro coperto, e fiammeggiar lo scudo di fulgid’oro: ancor ch’ei pur non vile splenda nell’armi, e se ne vada adorno di nobil manto, che con frigi modi gli avea tessuto di sua mano Argia, fregiando il bisso con dorate fila.
(Traduzione dal latino di Cornelio Bentivoglio d’Aragona – 1729)
«L’argento per realizzare la dentatura del Bronzo A, finora unico esempio nella statuaria classica», scrisse Paolo Moreno, lo studioso che per primo propose l’accostamento fra i Bronzi di Riace e i Sette, «enfatizza bene l’espressione di Tideo, che non è per nulla sorridente come sembra. Il suo è invece un ghigno satanico e bestiale, simbolo della ferocia del guerriero capace di divorare il cervello del nemico tebano Melanippo: un orrendo atto di antropofagia che costò all’eroe l’immortalità promessagli da Atena». In altre parole, il… bruxismo indotto dall’ira si addice più a Tideo che a Polinice: se ci si sofferma un attimo a riflettere, effettivamente il particolare del “morso alla testa del nemico” sembra prestarsi molto di più a impressionare un pubblico e a essere ricordato e tramandato, giustificando la realizzazione di denti in argento nel “Bronzo A” — utile ribadirlo: caso unico nella scultura grecoantica —, rispetto a un quasi inoffensivo «hostile tuens» (e la statuaria millenaria ce lo conferma, basta guardare il bassorilievo di Pyrgi, dove Tideo addenta Melanippo — cfr. immagine a seguire). E la totalità dei tragediografi antichi è concorde nel dipingere Tideo come il più focoso e irascibile dei Sette. Tuttavia è anche lecito chiedersi quanto senso avrebbe avuto una sua rappresentazione statuaria che lo raffigurasse in piedi e nel pieno del vigore “con i denti bene in vista”: se si voleva sottolinearne la drammaticità del ruolo, non sarebbe stato più opportuno immortalarlo in bronzo nel momento in cui, morente, “affetta” la testa di Melanippo per succhiarne il cervello (come nel citato frontone di Pyrgi), vista anche la natura “padri sconfitti vendicati dai figli” dei due santuari ad Argo e a Delfi? È quello il momento topico del “digrignar di denti”. Una scena che ispirò perfino Dante, che nella Divina Commedia (Inferno XXXII.132 e XXXIII.77) usa il morso di Tideo come parallelo per il Conte Ugolino.
L’episodio in cui Tideo morente infierisce sulla testa troncata del nemico impressiona anche Stazio, che pure secondo Castrizio dovrebbe aver visto il fatidico “gruppo a 5” e dovrebbe averne tratto ispirazione decisiva: «Tideo si erge, tende il viso ed ebbro di gioia e d’ira, appena vede gli spasmi nel volto e gli occhi stravolti, comanda di troncare quella testa nemica, di dargliela e, afferratala con la sinistra, la guarda ferocemente e gioisce nel contemplare quegli occhi torvi e ancora mobili. Il maledetto era soddisfatto: Tisifone implacabile pretende di più. Già la dea Tritonia ritornava, dopo aver convinto il padre e recava allo sventurato il dono dell’immortalità; lo vede lordo del marciume del cervello spappolato con le mascelle di sangue vivo e i suoi non riescono a strapparglielo…» (Stazio, Tebaide VIII.751-762).
Ciò detto, proviamo ora a farci una domanda interessante. Siamo dei bronzisti di 25 secoli fa che devono piazzare una ventina di statue nella piazza principale della città (Argo) e/o di un santuario (Delfi), opere che devono onorare il mito fondante dei cittadini (gli Argivi) della polis che ci ha dato l’incarico: i Sette e gli Epigoni contro Tebe. Questi eroi devono essere tutti in piedi e in posizione stante, come si usa nello stile del tempo (Severo o Classico). Non è previsto, ovviamente, che ci siano personaggi “estranei” — i tebani —, dobbiamo usare solo quelli del mito, singolarmente: per cui, nel caso di Tideo e Polinice, non possiamo usare né Melanippo né Eteocle. Dovendo scegliere come rendere la focosità e l’ira di Tideo e il tragico fratricidio di Polinice, quante probabilità ci sono che doteremmo di “denti digrignanti” Polinice piuttosto che Tideo? Se facessimo “digrignante” Polinice, non verrebbe confuso con Tideo?
In altre parole: TIDEO CON DENTI D’ARGENTO E SGUARDO TORVO PUÒ ESSERE ASSEGNATO ALLE ESEDRE DI ARGO E DELFI (i denti richiamerebbero il morso a Melanippo), INVECE POLINICE CON DENTI D’ARGENTO HA BISOGNO DI APPARTENERE A UN ALTRO TIPO DI MONUMENTO (per esempio il fantomatico “gruppo a 5” come si vede a Villa Doria Pamphilj), NON POTREBBE STARE IN UN GRUPPO CHE COMPRENDE ANCHE TIDEO.
E oltre a tutto questo, stiamo tralasciando un’ulteriore possibilità. Ossia che quei denti visibili e quell’atteggiamento irato non siano altro che l’effettiva smorfia di qualcuno — foss’egli guerriero, oplitodromo, pugile o chissà cos’altro — che all’epoca era famoso proprio per quell’aria di sfida stampata sulla faccia. E che non aveva nulla a che vedere coi Sette a Tebe. Magari proprio quell’Eutimo di Locri celebrato da Pausania, vincitore di tre Olimpiadi dal 484 al 472 a.C., conosciuto anche a Plinio, Strabone ed Eliano, la cui statua a Olimpia «è opera di Pitagora e merita davvero una visita» (Guida della Grecia VI.6.2). È sufficiente supporre che sia stato ritratto come un oplita, nudo come si conveniva a un kouros ma con la dory, l’hoplon e l’elmo: era un modo diffuso di “eroizzare” atleti, dèi e miti. (Insomma, quanto sostiene Sandro Stucchi.)
In definitiva, sia una Tebaide di Stesicoro in mano a Pythagoras sia il Polinice (ma la cosa vale pure per Tideo) che digrigna i denti sono con tutta evidenza una forzatura: si può dedurre che le cose stiano così, ma le prove archeologiche e letterarie semplicemente non lo dicono.

Mentre giace in fin di vita, Tideo è raggiunto dalla dea Atena intenzionata a salvarlo tramite una medicina avuta da Zeus e che lo renderebbe immortale, ma Anfiarao (che in precedenza aveva avuto il compito di riunire l’esercito ed era stato ostacolato da Tideo), vede la dea e decidendo di vendicarsi con Tideo taglia la testa del già morto Melanippo e la porge a Tideo. Questi l’apre con un fendente della spada e ne mangia il cervello sotto gli occhi della dea che, disgustata, trattiene per sé la medicina e lo lascia morire.
Nella Tebaide di Stazio (VIII.751-756) non figura Anfiarao, ma è Tideo stesso a chiedere a Capaneo di poter avere la testa di Melanippo. In Pausania è Anfiarao a uccidere Melanippo. È il dramma delle fonti antiche, che non avevano a disposizione Internet per fare copincolla: ognuno dava una propria versione diversa dalle altre.
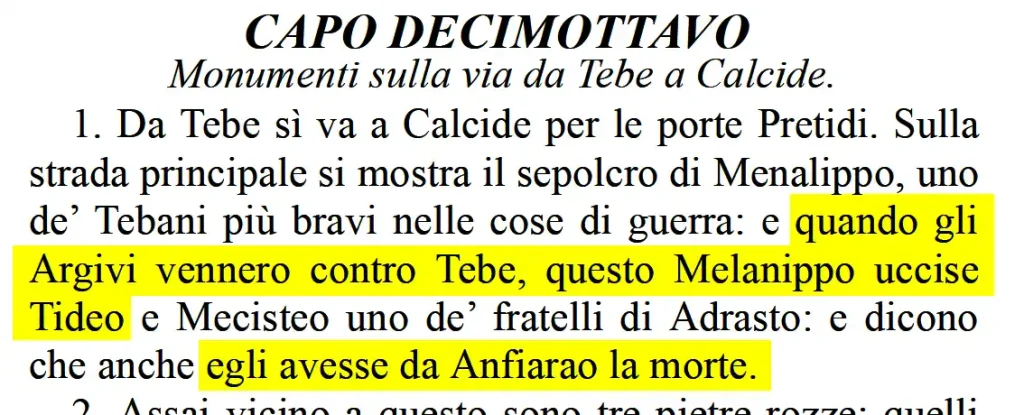


La prima attestazione del mito di Edipo è quella dell’Odissea (XI.271-80), ma sembra essere diverso rispetto alla versione comune, perché qui l’incesto viene scoperto subito. La prima attestazione di un accordo tra i due fratelli si trova nel logografo Ellanico (F 98 Jacoby). Nell’Iliade (XXIII.679) Edipo muore, forse in guerra. Esiodo (Erga 163) parla di una guerra intorno a Tebe che è stata da alcuni interpretata come la guerra dei Sette contro Tebe, ma non vi è niente che lo assicuri: potrebbe trattarsi di uno scontro di altro tipo, come quello descritto nell’Iliade (XI.671) tra Pili ed Epei per una questione di abigeato. È forse nel contesto di questa guerra che si deve situare la versione della morte di Edipo. Pausania (X.5.6) dice che nel ciclo epico Edipo ha quattro figli da Euriganeia, negando figli con Giocasta; in Ferecide si dice che Edipo da Giocasta ha avuto Frastor e Laointas; quindi sposa Euriganeia e ha Antigone e Ismene. Nella Tebaide di Eschilo si parla della maledizione scagliata da Edipo sui figli.
Nel frammento del Papiro di Lille attribuito a Stesicoro non si capisce quale dei due fratelli sia il colpevole. In Eschilo la giustizia viene richiamata dalla parte di Eteocle; nelle Fenicie di Euripide, Eteocle è il colpevole; in Sofocle, Eteocle è presentato come colpevole, ma solo da Creonte, come parere personale.
Val la pena di notare che nel brano del “Papiro di Lille” attribuito a Stesicoro, riprodotto qui di seguito, Eteocle e Polinice (sempre che di essi e di Giocasta si tratti) accettano la proposta della madre e desistono dallo scontro. Questo perché la scena dovrebbe essere antecedente al duello finale, e risalire al primo “accordo” fra i due fratelli. Si tratta di un salomonico compromesso, per cui uno avrà il regno e il palazzo “accanto alle fonti di Dirce” e l’altro, che se ne dovrà andare in esilio, le bestie e tutto l’oro del padre, tra cui la famosa collana donata da Cadmo ad Armonia, che ha scatenato gli appetiti di Erifile (cui Stesicoro dedicò un’opera) e la tragedia di suo marito Anfiarao. Secondo il logografo Ellanico, coevo sia a Pythagoras che a Eschilo (491–405 a.C.), Eteocle avrebbe concesso al fratello la scelta, e quest’ultimo, scelto l’oro, se ne sarebbe poi pentito intraprendendo la spedizione contro Tebe; qui invece la scelta sarà regolata da un sorteggio (i sorteggi sono già conosciuti all’Iliade [III.316 e 324s., XXIII.861s.] e all’Odissea [X.206]), conforme al volere delle Moire, su cui la regina punta, tragicamente, ogni sua residua speranza.
Il tipo di sorteggio appare organicamente partecipe delle problematiche sociali, politiche e normative diffuse nelle colonie magnogreche: da qui l’ipotesi di un “ramo magnogreco” — e stesicoreo — della tradizione sulla Tebaide. Il passo infatti presenta un ritratto tutt’altro che convenzionale di una donna impegnata a prendere una decisione cruciale sotto la pressione di un forte e improvviso impatto emotivo prodotto in lei da una dolorosa profezia: Tiresia ha profetizzato che la contesa fra Eteocle e Polinice potrà risolversi solo con la mutua uccisione dei fratelli o con la distruzione di Tebe. Di fronte a questo dilemma soffocante la regina non si abbandona a uno sfogo patetico, bensì elabora una personale risposta intesa ad affrontare il problema sia sul piano ideologico che su quello operativo. Era un messaggio che, trasposto nella relazione fra Stesicoro e il pubblico delle città magnogreche presso il quale i suoi canti venivano eseguiti accompagnandosi a una cetra, poteva cooperare al tentativo, a cui anche le feste religiose e gli agoni poetici contribuivano, di frenare i contrasti tra le fazioni in lotta, secondo un ruolo del poeta e più in generale del “saggio” che le fonti antiche dichiarano esercitato proprio da Stesicoro a proposito di tensioni interne — sia nella comunità di Locri Epizefiri che in quella Imerese.
Ma tutto ciò è questione di lana caprina — o, se si preferisce, sesso degli angeli — fra studiosi d’un certo spessore ai convegni specialistici. Fatto sta che non abbiamo la più pallida idea di come si svolga la scena del fratricidio in Stesicoro. Il combattimento fra Eteocle e Polinice, fra i grandi autori di “tebaidi”, è presente solo in Euripide (parzialmente: Giocasta e Antigone giungono sul luogo quando i fratelli sono moribondi) e in Stazio, che però sono autori successivi alla realizzazione dei Bronzi; in Eschilo manca il duello, la notizia che i fratelli si sono uccisi è portata da un messaggero; in Sofocle è del tutto assente. Volendo fare a meno di Stesicoro, si può ipotizzare che Pythagoras possa essersi ispirato alle figure dell’Arca di Cipselo: era un’arca in legno di cedro, con ricchi fregi figurati in avorio, dono votivo fatto al santuario di Olimpia dalla dinastia dei Cipselidi. Nel II Sec. d.C. Pausania la vide nell’Heraion e la descrisse minutamente (V.17.5, V.19.10). L’opera, oggi perduta, risaliva a un ignoto artista corinzio del VI Sec. a.C. (quasi un secolo prima di Pythagoras). Il fregio sull’Arca di Cipselo in ogni caso prevedeva solo i due fratelli, senza Giocasta/Euriganeia né Tiresia/Edipo/Creonte né Antigone.
TESTO INTELLIGIBILE SUL “PAPIRO DI LILLE”
(La parte intera del frammento inizia con la parte finale del discorso della regina dopo che Tiresia ha dato il responso oracolare sulle sorti di Tebe e della contesa fra Eteocle e Polinice)
«Non aggiungere ai dolori insopportabili affanni/ e non farmi presagire per il futuro/ tristi speranze.
Infatti non sempre allo stesso modo/ gli dèi immortali hanno stabilito sulla sacra terra/ la contesa intestina per i mortali/ né la concordia, ma a seconda del giorno/ gli dèi dispongono la mente degli uomini.
Le tue profezie, signore Apollo lungimirante,/ non le compiere tutte.
Se è destino che io veda i figli uccisi l’uno dall’altro/ e così hanno intrecciato [la sorte] le Moire,/ allora che io subito raggiunga il compimento della dolorosa morte, prima che io veda queste cose,/ afflitta dai dolori e piangente…:/ i figli nella reggia morti o la città conquistata.
Ma ascoltate!, ragazzi, le mie parole, figli miei, e abbandonatevi alla persuasione,/ perché posso prevedere come tutto questo potrebbe finire:/ l’uno abbia la casa e abiti [nella città],/ l’altro se ne vada con il bestiame/ e con tutto l’oro del caro padre,/ quello che con lancio dei dadi/ sia stato estratto per primo, secondo il volere della Moira.
Questa, infatti, credo/ sia per voi la soluzione della grave sciagura,/ secondo i responsi del divino vate,/ se il Cronide [vuole salvare] la stirpe e la città/ del signore Cadmo,/ scacciando i mali per molto tempo…/ è destino…»
Così disse la divina donna, parlando con miti parole,/ facendo desistere i figli dalla contesa nella reggia,/ e insieme a lei Tiresia interprete di prodigi, ed essi obbedirono.
- E in più lo stesso Pausania, nel brano già citato più volte, ci fa sapere che perfino gli argivi — e dunque gli abitanti della città, Argo, direttamente interessata al mito (cioè coloro che verosimilmente diedero l’incarico a Pythagoras) — seguivano la versione di Eschilo, non l’ineffabile versione di Stesicoro.
Del resto i Sette contro Tebe del drammaturgo di Eleusi conobbero un grande successo di pubblico fin dalla loro prima rappresentazione: lo sappiamo dalla lettura delle Rane di Aristofane, che evidenziano chiaramente come l’apprezzamento di cui la tragedia eschilea godeva presso gli Ateniesi era ancora grande alla fine del V Sec. a.C..
Si può supporre che gli argivi cominciarono a seguire Eschilo soltanto in epoca ellenistica, reagendo alle spoliazioni romane con tutta una nuova infornata di statue ma stavolta limitate a sette: quelle sulle esedre effettivamente ritrovate dagli archeologi. Confermando in tal modo l’altra supposizione sul fatto che quanto vide Pausania non risaliva al V Sec. a.C. ma a secoli successivi. Peraltro, quasi contemporaneamente a Eschilo il numero 7 ricorre in Pindaro (Olimpiche VI.12-17, databile tra il 476 e il 468 a.C., e Nemee IX.9-27, databile tra il 474 e il 471 a.C.), come già visto all’inizio del blogpost: i corpi degli argivi caduti a Tebe «furono posti su sette pire». Forse il tema del numero 7 “era nell’aria” da tempo. Tuttavia così faremmo… voli pindarici su castelli di carte. È l’analisi delle fonti letterarie che citano direttamente la statuaria, la linea che stiamo seguendo, e la nostra fonte dice che gli argivi seguivano «la poesia di Eschilo», con buona pace del magnogreco Stesicoro:
Perché, avendo letteralmente “distrutto” la teoria di Castrizio con tutte queste confutazioni, ho scritto al principio che i contro «non sono ancora decisivi»? Per via della testimonianza di Taziano: il quale ci dà notizia dell’esistenza di due statue di Eteocle e Polinice realizzate da Pythagoras di Rhégion/Samo. Due opere sfuggite a tutte le altre fonti antiche, che pure sono (specie Pausania) prodighe di notizie sullo scultore magnogreco. Ed è da escludere che per faziosità il retore possa essersele inventate, perché l’altra opera da lui nominata (l’Europa sul toro) gode di molteplice attestazione (Cicerone, Varriano e altri). Pur non collegando ancora ai Bronzi di Riace, il passo di Taziano è una prova irrefutabile di cui non possiamo non tener conto.
Non solo. “Eteocle più Polinice” implica che non siamo di fronte a sculture appartenenti ai “soliti donari” di Argo e Delfi ma che si tratti inequivocabilmente del duello fratricida: la figura nemica di Eteocle non avrebbe mai fatto parte di una celebrazione argiva del mito con i kouroi in piedi e in fila in un’esedra. (Detto altrimenti: quale comunità avrebbe potuto voler omaggiare di statua lo “stronzo” Eteocle?)
Ciò nondimeno, i distinguo sono obbligatori. Per dire, nessuno studioso a eccezione di Paolo Moreno sembra aver tenuto in debita considerazione il nesso che deve necessariamente esserci fra Eschilo che esordisce con la “riduzione a Sette” degli eroi (467 a.C., in questo concorde con il tebano Pindaro che nello stesso periodo cita «sette pire» per gli argivi morti a Tebe), la vittoria di Argo a Oinoe (461 a.C.), i cippi dei “soltanto Sette” (e dei loro Epigoni) ritrovati oggi nell’agorà di Argo, e l’input per la realizzazione dei Bronzi (il primo dei quali è datato 460 a.C., e la terra di fusione al suo interno è dell’Argolide): una “strettoia” sia cronologica che geografica troppo precisa e circostanziata per non avere alcuna relazione.
E allora la cosa da fare è, come d’altronde già può avvenire con le teorie di Di Vita, di Odo Pavese, di Stucchi e di Moreno — delle quali si può salvare solo una percentuale o un dettaglio eliminando il resto —, anche qui epurare Castrizio di una parte di teoria che semplicemente “non funziona”. E la parte che non funziona è il “gruppo a 5” con Giocasta, Antigone e la quinta figura che può essere Tiresia o Edipo o Creonte.
A meno che non si scopra una buona volta, stando a quanto denuncia da anni il giornalista Braghò, una statua bronzea di Giocasta trafugata a Riace e nascosta al famigerato Getty Museum (il cosiddetto “terzo bronzo” di cui si favoleggia da tempo), e/o che Giocasta e gli altri del “gruppo a 5” siano ancora sepolti fra le sabbie marine di Riace (le famose “anomalie metalliche” rilevate con i radar), gli indizi testé esposti ci fanno pensare che questo favoloso conglomerato bronzeo non sia mai esistito. La teoria di Castrizio andrebbe quindi “ripulita” da esso: è stato Stazio a ispirare il bassorilievo di Villa Doria Pamphilj, unico esemplare marmoreo pervenutoci comprendente Giocasta fra le decine di altri bassorilievi in tema Fratricidio a Tebe, non è stato Stazio a ispirarsi a un quintetto bronzeo visto nelle sale imperiali del Palatino (Stazio nella sua Tebaide semplicemente “espande” la versione di Euripide del mito).
E si può fare a meno anche di Stesicoro: sappiamo da Pausania che «gli Argivi seguivano Eschilo», non c’è motivo di supporre che Pythagoras, incaricato da quella stessa comunità, si sia ispirato a un’altra storia. È una questione di semplice logica — e di rasoio di Occam.
Quanto a Pythagoras (e qui Castrizio non c’entra), sarebbe altresì il momento di riconoscere che non sono mai esistiti due scultori con questo nome: Pitagora Reggino e Pitagora di Samo sono la stessa persona, Pythagoras si firmava proprio “di Samo”, come ben vediamo sulla base della statua di Eutimo ritrovata a Olimpia.
Il richiamo di Plinio il Vecchio a «sette statue ignude» esposte nel «Tempio della Fortuna» delle quali sarebbe stato autore un «Pitagora di Samo» che era «simile in volto al primo Pitagora» può significare tre cose diverse, con la prima che può essere complementare alle altre due: 1) siamo al cospetto di un qui pro quo (uno dei tanti!) di Plinio, oppure 2) Pythagoras realizzò anche un gruppo elitario dei “Sette” a Tebe (non solo senza Eteocle ma anche senza gli Epigoni e Adrasto, solo gli Eroi morti nella prima sfortunata spedizione) che razziato in Argolide finì nel “Tempio della Fortuna” a Roma, o ancora 3) quelle esposte al tempio romano erano alcune delle numerose statue di atleti olimpici realizzate dallo scultore reggino — e il “7” è soltanto una banale coincidenza.
Tuttavia, visto che siamo in ballo con il “ritoccare Castrizio”, potrei personalmente tentare di spingere la cosa alle estreme conseguenze, se così si può dire aumentando la manopola del contrasto in modo da trasformare tutte le sfumature di grigio (i se, i ma, i forse e i probabilmente) in bianco o in nero: tutto quello che sta sopra il 50% di tonalità (ossia di probabilità) portarlo al 100%, tutto quello che sta sotto azzerarlo. Bianchi o neri, luce o buio, uno e zero, binarietà senza mezze misure.
Lo si prenda come un gioco, da parte mia, dal momento che non sono un luminare del settore — non faccio altro, come ho detto all’inizio, che usare le deduzioni e la logica per far incastrare i pezzi, ma l’unico fine è un divertissement intellettuale. Anzi, visto il sito web, internettuale.
A questo riguardo, dipendesse da me farei immediatamente fuori il fantomatico nipote Sostrato e l’altrettanto fantomatica “scuola reggina di scultura”, e assegnerei a Pythagoras solo la più antica fra le due statue.
I dettagli della precisione dei capelli e della barba e la datazione al periodo “Severo”, apprezzabili soprattutto nel “Bronzo A”, circoscrivono nettamente le possibilità attorno a Pythagoras almeno appunto per la statua più vecchia (che paradossalmente è chiamata “il Giovane”).
E vorrei sottolineare quella che, stando a quanto vediamo coi nostri occhi, a mio avviso va considerata qualcosa in più di una probabilità — ossia, che l’autore del “Bronzo A” sia Pythagoras — attraverso una frase di Plinio il Vecchio che non è la stra-abusata triade «vene, nervi & peli», bensì un’altra osservazione, sempre nel medesimo brano 59 del libro XXXIV della Naturalis Historia in cui parla di Pitagora.
«Syracusis autem claudicantem: cuius ulceris dolorem sentire etiam spectantes videntur», a Siracusa fece poi uno zoppo tale che anche a chi lo guarda sembra di sentire il dolore della sua piaga.
Pur non sapendo in che modo fosse visivamente apprezzabile il dolore per le ferite del Filottete claudicante di Siracusa, nel “Bronzo A” disponiamo di almeno un’altra statua in cui sono resi i sentimenti del personaggio raffigurato: è il “mostrare i denti”, l’omerico Ergos Odonton. L’artista, se avesse voluto soltanto indicare la naturalezza dei denti, avrebbe potuto farli in avorio, così come in avorio ha fatto i bulbi oculari; ma con il lampeggiare dell’argento ha voluto attirare ancor di più l’attenzione dell’osservatore proprio su questo particolare. E non tanto in ottica anatomica, quanto precisamente sull’atto di digrignare i denti contro l’avversario.
Identificare Pythagoras con l’autore di “A” fa combaciare autori che non erano bravi soltanto nel realismo dei dettagli: sapevano rendere le emozioni. Certe loro opere apparivano “vive” in tutti i sensi.
Non vedo alcuna certezza invece per l’autore del “Bronzo B”, e quindi sono costretto a fare una scelta che appartiene più al campo delle scommesse che a quello dell’oggettività. Lo stile, la postura, lo spessore e la lega del bronzo e le analisi dei materiali, ci dicono che è di circa 30 anni successivo e che proviene da un’officina situata in una città diversa; d’altro canto la somiglianza di atteggiamento e la corrispondenza di proporzioni prospettano un’alternativa precisa: una “contaminazione” fra varie scuole, con un “canone” delle proporzioni e delle dimensioni che è diffuso fra vari autori — canone a quanto pare proprio in quel periodo codificato per iscritto da Policleto in un trattato purtroppo andato perduto —. Oltre allo stile “Classico maturo” del “Bronzo B”, alcuni suoi dettagli come il “mignolo varo” nei piedi (e aggiungiamoci la somiglianza con altre opere come esaustivamente riassunto da Odo Pavese) riconducono giust’appunto a Policleto, che per giunta era nativo specificamente dell’Argolide.
Il tema del mignolino varo ha l’aria di essere una sorta di easter egg, come diremmo oggi in ambito informatico: una firma nascosta dell’artista. Un vezzo che ritroviamo non solo nel “Bronzo B” ma in molte opere del maestro argivo, come il Doryphoros o l’Efebo Westmacott.
Di converso, la parte critica di una “teoria Policleto” riguarda due caratteristiche riconosciute del grande scultore: il senso di “andatura” di molte delle sue opere (assente nel “Bronzo B”, ben piantato a terra) e il fatto che fosse impegnato principalmente nel raffigurare atleti, fanciulli e miti (il “Bronzo B” non lo è: la kynê sulla testa è quella di un re o capo militare). E tuttavia va “contronotato” che sia il Discoforo che il Diadumeno sono anch’essi ben piantati a terra, con il primo dei due ancora privo della posa tipica con la gamba sinistra arretrata, e dall’immancabile Plinio sappiamo che l’argivo ritraeva anche “comuni mortali”: per esempio Artemone Periforeto, ingegnere di Pericle nell’assedio di Samo e inventore di macchine belliche. Nel racconto di Plutarco (Vita di Pericle XXVII) Artemone era claudicante e aveva l’abitudine di farsi trasportare al cantiere su una lettiga (da qui il soprannome periforeto, che significa “portato intorno”): non esattamente un “eroe” degno di statua bronzea, dunque. La kynê, per parte sua, potrebbe altresì essere un indizio di ritratto di uno dei primi comandanti della Guerra del Peloponneso, cominciata nel 431 a.C.. Ma «indizio» e verbi al condizionale ora vanno accantonati. Con un po’ di audacia propendo per una datazione alta: ben prima che Policleto si trasferisse ad Atene (ossia ca. 435/430 a.C., quando si unì a Fidia) e sviluppasse definitivamente il suo stile camminante, e non ne escludo il coinvolgimento nello stesso “appalto” degli eroi argivi che riguardò Pythagoras per l’altra statua riacese — il che spiegherebbe sia la postura “non pienamente policletea” sia la kynê —, dal momento che sappiamo attivo Policleto già nel 465 a.C.. Nel qual caso la kynê condurrebbe inequivocabilmente a un unico soggetto: il re che guidava l’impresa contro Tebe.
E dunque, con la manopola del contrasto spinta al massimo…
Negli anni Sessanta del V Sec. a.C. avvengono due episodi importanti. Alle Grandi Dionisie del 467 a.C. ad Atene va in scena per la prima volta la tragedia “I Sette contro Tebe” di Eschilo, che ha immediato, enorme successo; trascorrono sei anni e gli Argivi, aiutati dagli alleati Ateniesi, vincono gli Spartani a Oinoe e riprendono il controllo di Tirinto e Micene. Si celebra l’orgoglio della comunità dando nuovo fasto al mito fondante della città, e sulla scorta della “hit del momento” (la nuova tragedia), che riduce a “7” i protagonisti («Questi personaggi furono da Eschilo ridotti al solo numero di sette, quantunque fossero in maggior numero capitani, che da Argo, Messene e da alcuni de’ luoghi degli Arcadi andarono a quella spedizione», Pausania II.20.4), viene dato incarico ai migliori bronzisti in circolazione.
Pitagora di Rhégion fa parte dell’«appalto» del gruppo statuario “degli eroi in Tebe” (così l’iscrizione nei cippi attorno alla base semicircolare ritrovata dagli archeologi): attorno al 460 a.C. egli fonde nel bronzo uno o più di questi miti, destinati all’agorà di Argo. Fra tali statue ne spicca una per la mirabile cura dei dettagli: vene e tendini, barba e capelli sono così curati che sembrano veri, e c’è quell’incredibile particolare dei denti nell’espressione digrignante del volto: è Tideo, il più irascibile dei “Sette”. Fra 25 secoli sarà conosciuto come il “Bronzo A di Riace”.
Uno, due o finanche tre decenni dopo (comunque non oltre il 431 a.C., inizio della Guerra del Peloponneso e della Peste di Atene), nei dintorni, l’argivo Policleto, che è meno bravo nei particolari ma sta sperimentando efficaci evoluzioni stilistiche di portamento e ritmo, fonde nel bronzo un’altra statua, per la quale il destino ha in serbo un accoppiamento con quella di Pythagoras. (Non è infatti necessario che “B”, la seconda statua, quella policletea, fosse in origine proprio Eteocle: se vogliamo restare nell’ambito dell’«appalto» del Ciclo Tebano, potrebbe trattarsi di Adrasto — l’identità sarebbe denunciata dalla kynê: era lui il re a capo della spedizione dei “Sette” —. Ma potrebbe essere chiunque fra gli artefici che intanto hanno inaugurato un’èra di prosperità ad Atene, alleata di Argo. Per esempio Artemone, ingegnere di Pericle — e da Plinio sappiamo che Policleto ne fece il ritratto —. In ogni caso a questo punto della ricostruzione la sua identità, che resta inafferrabile, non è importante: quel che è certo è che si tratta della figura di un “capo”.)
Le due statue vengono riunite più tardi — secoli più tardi — dagli eventi, quando la Storia ha sfogliato le sue pagine, l’idealità classica è solo un ricordo, è passato Alessandro il macedone come un rullo compressore, è cominciato il corrosivo Ellenismo, e soprattutto sono ormai scesi in campo i Romani con le loro razzie.
Vai a sapere cosa accade durante e dopo una razzia, quando sei un console che invade una terra straniera e poi porta il bottino straniero al suo imperatore, sta di fatto che una volta arrivati nella romanità insieme a migliaia di altre sculture nell’arco di trecento anni (si immagini il traffico, l’immagazzinamento, la redistribuzione, le gelosie, gli intrighi di corte, lo sviluppo vorticoso dell’edilizia nel momento di massimo splendore dell’Antica Roma), Tideo e “Adrasto” di Pitagora e Policleto diventano “i fratricidi Eteocle e Polinice”: soggetto famoso da secoli nella penisola italica, il loro duello è scolpito in decine e decine di sarcofagi, specialmente etruschi.
Però prima ci sono voluti dei ritocchi, ordinati dallo stesso imperatore, quell’Adriano “fissato con la Grecia” che s’è fatto pure una villa a Tivoli stracolma di riproduzioni marmoree delle opere dei maestri greci. (Perché proprio Adriano e non altri, visto che i saccheggi romani in Grecia erano cominciati quasi tre secoli prima di lui ed erano cessati da qualche decennio? Precisamente per la sua passione smodata per la grecità e in particolare, da quanto vediamo a Tivoli, per la statuaria del periodo Severo/Classico.) Il braccio destro del “Bronzo B”, che è peraltro danneggiato, viene rifatto per assomigliare il più possibile a quello del “Bronzo A” (tramite un calco del braccio di “A” oppure prendendolo da un’altra statua) e per poter mettere anche a lui in mano una lancia (viene rozzamente usato del piombo per fissare la lancia fra le dita, piombo ancora visibile dopo oltre due millenni); gli interventi (come noi moderni abbiamo scoperto ai Raggi X) riguardano anche l’avambraccio sinistro: a “B” viene fatto imbracciare uno scudo, la statua in origine ne è sprovvista. Viene tolto quel che resta del “ricciolo” della kynê, elemento superfluo, facilmente già rovinato di suo data la fragile forma a ricciolo. Ora, con hoplon, lancia ed elmo, le due statue sono una lo specchio dell’altra, la postura del busto e delle gambe era già assai simile: sembrano proprio i due fratelli che daranno vita al duello.
Non dev’essere un granché di restauro (l’arte di lavorare finemente il bronzo è ormai perduta da secoli), così per coprire i difetti le due statue vengono “verniciate” di nero (il “fegato di zolfo” identificato oggi sui Bronzi di Riace). Fatto ciò, vengono esposti insieme: uno di fronte all’altro, in simmetrica tensione prima dello scontro fatale.
(I tenoni in piombo, di materiale identico e decisamente ellenico, non sono d’intralcio alla ricostruzione: il piombo del Laurion era diffusissimo in tutto il Mediterraneo, e nulla toglie che sia stato usato anche dai Romani per riesporre le statue, una volta portate via dalla Grecia. Oggi dalle gammagrafie sappiamo pure che l’intelaiatura interna originale delle statue è stata ritoccata durante il restauro, le sbarre di ferro sporgenti oltre i talloni furono segate per far posto ai tenoni.)
Qualche decennio dopo, fra il 150 e il 165 d.C., Eteocle e Polinice, esposti «nelle città de’ Romani» (a Roma o altro centro dell’Impero), vengono notati da un seguace del leader cristiano Giustino, tale Taziano il Siro, noto polemista e gran viaggiatore. «Chi li ha ritratti, questi due infami?», chiede il rètore cristiano; «Quello più giovane è di un certo Pitagora, l’altro non si sa», gli viene risposto; «Ah, è quello dell’Europa sul toro di Taranto… altra infamia, ritraeva solo sconcezze; sarà suo pure l’altro, da come si somigliano»; «Boh, si dice che sia lo scultore di Samo che ha fatto i sette eroi nudi esposti nel Tempio della Fortuna», «Appunto, solo sconcezze: tipico dei Greci».
Non so se il principio è sufficientemente esplicito o rimane talmente implicito da non arrivare, per cui lo dico chiaro e tondo: i Bronzi di Riace non sono nati insieme per uno stesso monumento in Grecia nel V Sec. a.C., le due statue sono state accoppiate nell’Impero Romano, da 4 a 6 secoli dopo la loro realizzazione.
Per quanto mi riguarda, questo è il quadro che si delinea da tutti i dati che abbiamo analizzato insieme fin qui. “Alzando al massimo la manopola del contrasto”, l’identità finale Eteocle–Polinice rimane intatta, e nella teoria ci sono sempre Pythagoras di Rhégion a un capo e Taziano il Siro all’altro capo. Cambia tutto il percorso, facendo a meno, per dirlo con una sigla, di un asse a “tre S” — Stesicoro, Sostrato e Stazio — che non è sostenibile alla luce dell’obiettività documentale, e mantenendo, per dirlo con un’altra sigla, l’altro asse a “tre P” — Pitagora, Plinio e Pausania — che invece è pienamente persuasivo, e inoltre cambiano i punti di partenza: ma le conclusioni restano in qualche modo invariate, i Bronzi di Riace sono effettivamente i fratricidi visti da Taziano nel II Sec. d.C., pur essendo stati creati con differenti finalità.
Ed ecco fra l’altro perché, al contrario di quanto vediamo sull’iconografia dei vasi e dei sarcofagi, le due statue non hanno il dinamismo dello scontro ma posano “serenamente”: non erano nate per raffigurare il duello, erano ognuna un singolo kouros, tipico dei maestri del V Sec. a.C. — e che maestri: Pythagoras e Policleto, dei veri numeri uno.
(Si pensi all’ironia della cosa: oggi conserveremmo al Museo di Reggio Calabria l’unico originale in bronzo di Policleto sopravvissuto ai secoli, e nessuno lo saprebbe.)

Sembra un film? Certo: perché il suo scopo non è la ricerca della verità (vaste programme) ma dribblare tutte le obiezioni, i se, i ma, i forse e i sì-però. Solo che, dribblandoli, la storia che ne viene fuori, pur resistendo a qualsiasi obiezione, suona irrealistica.
Gli studiosi volano più basso di così. Vanno con i piedi di piombo (del Laurion!), usano tutti i verbi al condizionale, il bianco e il nero non esistono, esistono solo le tonalità di grigio. È il metodo scientifico: non ci sono verità eterne, una teoria è buona finché non ne arriva un’altra migliore; tutte le teorie devono poter essere verificabili, e tutte le teorie possono essere invalidate.
L’autore di questo blogpost invece può permettersi il lusso dell’opinione netta. Per me lo sdoppiamento di Pitagora in “scultore di Rhégion” e “scultore di Samo” è una sciocchezza, per i luminari è ammesso. Per me è evidente che al contrario lo sdoppiamento fra autore del “Bronzo A” e autore del “Bronzo B” è inevitabile, ma non per i luminari, che invece in tal caso non ne vogliono sapere di separarsi dall’unità (eppure per chi vive a Reggio Calabria — come me — basta entrare al Museo e rendersene conto coi propri occhi: non li ha fatti uno stesso artista!). Per me è evidente che i denti del “Bronzo A” rappresentano più Tideo che Polinice, che non è mai esistito un “gruppo bronzeo di 5 sculture con Giocasta a seno scoperto”, che ad Argo si andava con Eschilo e non con Stesicoro, che fu la somma Eschilo più battaglia di Oinoe a fornire l’input per la realizzazione della prima statua (“A”), che per quello che abbiamo su di lui da questo Stesicoro non si può trarre nulla… per i luminari, no.
L’idea della modifica al braccio di “B” per trasformarlo in un altro soggetto può apparire follia? Abbiamo già visto che a Roma accadeva: lo “Spinario” bronzeo è composto così, il corpo è del III Sec. a.C. mentre la testa appartiene all’epoca di Pythagoras, Policleto, Agelada, Fidia, Mirone — e i capelli ricordano assai da vicino la tecnica sopraffina delle ciocche dei Bronzi di Riace.
E quanto a “Bronzo B”, Policleto e «idee folli»: suo fratello Polinice lo guarda in modo torvo e feroce (hostile tuens), sua madre lo implora stracciandosi le vesti e mostrando il seno, sua sorella Antigone dà manforte, c’è perfino un anziano che cerca di far valere la propria autorevolezza (l’indovino Tiresia, oppure il re Edipo padre, o ancora Creonte).
Ed Eteocle che fa? Osserva la scena con quell’espressione distaccata, quella calma olimpica, quella flemma che con un anacronismo potremmo definire british, che vediamo nel volto del “Bronzo B”? Inverosimile.
Altrettanto inverosimile che quel Pythagoras capace di rappresentare in maniera così stupefacente l’emotività del personaggio raffigurato nel “Bronzo A” (i digrignanti denti d’argento), disponga — da solo o per il tramite del nipote Sostrato — la realizzazione dell’altra scultura con un atteggiamento così tranchant, elusivo, avulso dal dramma che presumibilmente si sta svolgendo.
Perciò la statua in origine era qualcun altro. Soltanto la somma presunzione dei parvenu dell’antichità, quegli imperatori di Roma dei quali sappiamo la rozza ignoranza direttamente proporzionale al loro sterminato potere, avrebbe potuto indurre a sceglierlo come partner per il beluino, digrignante, ferus “Bronzo A”. In buona sostanza, si scelse “B” esclusivamente per le sue proporzioni: erano perfette, “speculari” a quelle di “A”. E con qualche aggiustamento (il restauro delle braccia) le due statue potevano fare un figurone, messe una di fronte all’altra: i due fratelli della Saga di Tebe (celeberrima nella penisola italica, come vediamo dai sarcofagi) che stanno per uccidersi a vicenda.
Il costrutto «che sembra un film» regge a tutte le obiezioni che ho esposto nell’inchiesta ma, come ho detto, il mio è solo un gioco. E le relative soluzioni alle obiezioni non sono le uniche possibili: per ognuno dei dubbi ci sono tante risposte. Per dirne una, Stazio sembra affascinato non dal fantomatico “gruppo a 5” quanto piuttosto da Tideo: «Quale degli eroi mi offrirai per primo, Clio? Tideo dall’ira smodata?» (Stazio, Tebaide I.41-42). «Tideo di estrema audacia in ogni atto» (II.175). «Uomo che ha superato ogni limite nell’odio» (IX.3-4). «Volto spaventoso» (formidatos vultus, IX.185). «Uomo ardente e completamente accecato dalla sua impresa» (II.696). «Massicce le sue ossa» (VI.844), «smodato nell’ira» (I.42), «macchiato di sangue fraterno» (II.113), «furens» (VIII.458), «rozzo, selvaggio, feroce» (saevus, VIII.499), «cruentus» (VIII.530-531; IX.1-2), «invisus» (IX.26), «abominevole» (infandus, IX.545). «Volontà inesorabile» (immitia, II.696). «Larghe spalle» (I.489), «invincibile possanza» (vis invicta, III.62). «Ferinità dell’uomo» (IX.184).
Ha visto coi suoi occhi il “Bronzo A”, con quell’espressione luciferina e i denti d’argento? Però Stazio scrive la Tebaide nel 92: il colto Adriano, l’imperatore appassionato ammiratore della cultura greca che potrebbe aver ordinato la “cosmesi” della seconda statua, comincia a regnare un quarto di secolo più tardi, dal 117 al 138 d.C.. “A” era già esposto senza “B” e chiamato correttamente Tideo? Le due statue non erano ancora conosciute come Eteocle e Polinice? “A” e “B” erano effettivamente Tideo e Adrasto, due delle «sette statue ignude» conosciute da Plinio nel I Sec. d.C. presso il Tempio della Fortuna, appartenute all’agorà di Argo, poi nel II Sec. d.C. arrivò Adriano e qualche decennio prima che le vedesse Taziano le fece modificare rendendole “i fratricidi”? Adriano non c’entra niente, il restauro fu fatto sotto Vespasiano o Diocleziano? Magari a ordinare i ritocchi fu Nerone, l’imperatore senza rispetto per nulla e nessuno, neanche per l’arte, tanto da rubare e poi manomettere le statue? «E non dovea essere esente da quel disprezzo, che per tutte le cose Nerone mostrava, il quale tolse ad Apollo cinquecento statue di bronzo di Iddii, e di uomini» (Pausania, X.7.1), e «Lysippos […] fece anche molti ritratti di Alessandro Magno cominciando da quando era fanciullo; quest’ultima statua di Alessandro fanciullo Nerone, cui piaceva moltissimo, la fece dorare; ma poi, il costoso ornamento avendo cancellato la bellezza artistica, fu di nuovo tolto l’oro, e così veniva riputata ancora più preziosa di prima, appunto perché rimanevano visibili le cicatrici e le incisioni che erano servite a fare aderire l’oro» (Plinio, XXXIV.63). Però Nerone precede Stazio di trent’anni — c’è sempre qualche trentennio di mezzo… Che cosa ha visto davvero Taziano il Siro a metà del II Sec., e dove? Ammettiamo che fosse a Roma (il che non è scontato: «nelle città de’ Romani» del II Sec. equivale al moderno «L’ho visto in America»): possibile che abbia veduto le «sette statue ignude» nel Tempio della Fortuna e, venendo a sapere che erano quelle del Ciclo Tebano, e che fra gli autori ci fosse Pythagoras, abbia scritto quelle parole semplicemente perché sapeva già del duello fratricida come momento clou del mito, scambiando Tideo per Polinice e “Adrasto” per suo fratello Eteocle, forse per il modo in cui le statue erano disposte in quel tempio? Esiste una consequenzialità fra la pubblicazione della Tebaide di Stazio e la modifica ai Bronzi? Ossia, è plausibile che Stazio, rigenerando una saga di lungo successo in Italia (il Ciclo di Tebe, presente in una miriade di sarcofagi e di vasi precedenti), ne provocò una rinnovata reiterazione nell’arte scultoria, di cui abbiamo esempi sia nei Bronzi modificati da qualche potente (imperatore o senatore) per sembrare Eteocle e Polinice pre-duello, sia nel sarcofago di Villa Doria Pamphilj — e in chissà quante altre opere ormai perdute?
Notare, a ogni strada che decidiamo di prendere, quante altre strade alternative incrociano il nostro cammino. Ci sono soltanto due quesiti davanti ai quali si resta muti, il vicolo è cieco: 1) Come arrivarono a Riace? 2) Perché non esistono copie in marmo del “Bronzo A” (ma anche “B” ha una sola copia e pure contestata)? Tutto il resto ha esegesi multiple.
Basta giocare. La teoria di Castrizio — la quale non è un gioco — pur con tutte le sue pecche (ancorché emendabili) è tuttora la più coerente e circostanziata, fra tutte quelle dei luminari che si sono espressi in mezzo secolo. Andiamo avanti con il resto del “compendio”…
Atleti vittoriosi in gare di oplitodromia (Di Vita, Odo Pavese & C.)
PRO
- La postura, le misurazioni e gli interstizi delle mani destre ci fanno fortemente sospettare che non sia quello il modo di reggere un’arma (lancia o spada).
- Gli stili ci informano altresì che intercorrono tre decenni fra le due opere, il che è compatibile con le analisi d’altro tipo (materiali, fusione, spessore del bronzo).
- La prima metà del V Sec. a.C. fu l’epoca in cui la corsa armata (oplitodromia) era più in voga.
CONTRO
- La kynê del “Bronzo B” indica che il personaggio è un capo politico/militare, non un atleta.
- Perché mai una statua di atleta vincitore dovrebbe avere un’espressione così adirata, come nel “Bronzo A”?
Tideo e Anfiarao (Moreno)
PRO
- Somiglianza fra la testa del “Bronzo A” e le figure nel tempio di Zeus a Olimpia.
- Agelada era il principale scultore di Argo del suo tempo.
- Il “digrignar di denti” del “Bronzo A” si addice a Tideo in base ai racconti che di lui fanno le fonti letterarie.
CONTRO
- Ricostruzione fantasiosa della “cuffia da indovino” del “Bronzo B” e degli altri elementi militari delle due statue.
- La proposta di Anfiarao in quanto descritto dalle fonti sempre accanto a Tideo non è convincente.
- Agelada e Alcamene non sono nominati dalle fonti quali autori di anathémata argivi.
Eutimo (Stucchi)
PRO
- Identificazione di Pitagora quale più probabile autore almeno della statua A in base ai testi di Plinio (stesse argomentazioni poi riprese da Castrizio), allo stile e alla datazione.
- Esistevano due statue di Eutimo, a Olimpia e Locri, la prima delle quali ha anche il supporto degli archeologi (ritrovata la base, firmata “Pitagora di Samo”).
CONTRO
- La tesi presuppone che le due statue non siano mai state in Grecia, e invece le terre di fusione riconducono al Peloponneso — non solo ci sono state, ma son state fatte lì.
- Il naufragio di Pirro già nel III Sec. a.C. va contro il dato del restauro avvenuto 3/4 secoli dopo.
- Il supposto scultore magnogreco per il “Bronzo B” attorno al 425 a.C. non è supportato da evidenze.
- La “cuffia da pugile” del Bronzo B è incoerente con gli antichi dati iconografici sui pugili.
Pericle e Temistocle (Partinico)
PRO
- Somiglianza fra il volto del “Bronzo B” e i busti di Pericle.
- La kynê del “Bronzo B” attesta una figura di capo/comandante — e Pericle lo era.
- Riguardo al naufragio, il “percorso breve” Cefalonia-Riace appare convincente, pur non essendo di alcuna utilità per l’identità delle statue.
CONTRO
- La testimonianza di Demostene non depone a favore di una statuaria attico/argiva dedicata a Temistocle nel V Sec. a.C. ma soltanto dopo la “piena riabilitazione della sua memoria”, dal IV Sec. in poi e quasi certamente dall’epoca ellenistica.
- Temistocle, all’epoca di realizzazione del “Bronzo A”, era in fuga dalla Grecia, ostracizzato ed esiliato dagli Ateniesi e condannato a morte dagli Spartani: è un po’ come dire che qualcuno dedicò una preziosa statua a Hitler, rintanato nel Reichstag, mentre le truppe sovietiche entravano a Berlino nel 1945.
- Un gruppo statuario di cui facessero parte sia Pericle che Temistocle già a metà del V Sec. a.C. (peraltro con Pericle ancora in vita, e per giunta con 30 anni di differenza fra “A” e “B”), come ci dicono sia gli esami che gli stili delle due statue, è incongruo e dunque assolutamente improbabile.
- Non è chiaro perché Pericle e Temistocle avrebbero dovuto essere ritratti con lo scudo e un oggetto in mano, qualunque esso fosse (lancia, spada o alloro).
- Soprattutto non si capisce per quale motivo Temistocle (Bronzo A), capo militare come e più di Pericle (Bronzo B), dovrebbe essere sprovvisto di kynê.
- Le supposizioni su iperlordosi, progenismo e altri difetti anatomici paiono eccentricità con scarso o nessun fondamento (e anzi paradossalmente una di tali teorie, quella del varismo al 5° dito del piede, superflua nel dimostrare qualunque cosa su Pericle, potrebbe andare a rinvigorire il parere di coloro che nel “Bronzo B” intravedono il lavoro di Policleto, poiché i piedi — con tanto di varismo — di “B” e del Doryphoros sono pressoché identici, e il 5° dito varo è anche nell’Efebo Westmacott, altra opera policletea. Un po’ come il farmaco minoxidil: nato contro l’ipertensione e poi invece usato per la crescita dei capelli…).
- La coincidenza fra periodo di realizzazione ed età d’oro di Pericle, da sola, non è sufficiente a dirci assolutamente nulla.
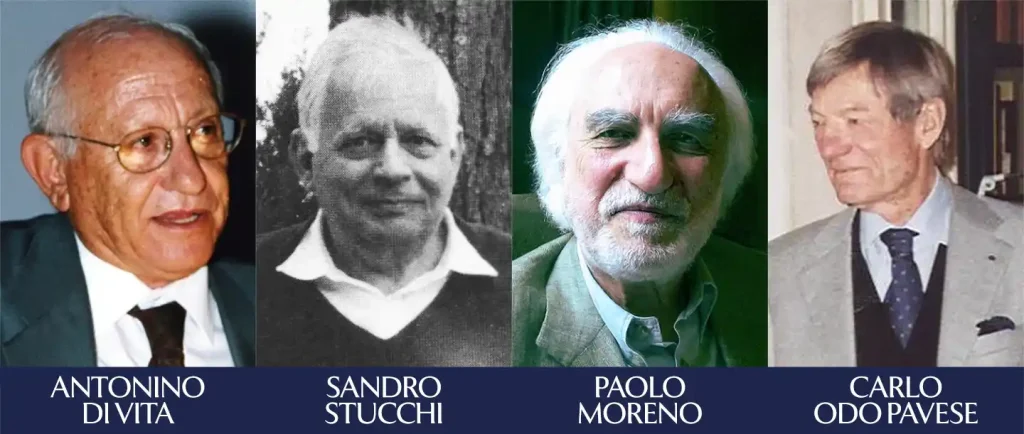
Come si vede, è praticamente impossibile anche solo tentare una armonizzazione per poter formulare una conclusione attendibile e definitiva sull’identità dei Bronzi di Riace. E ho risparmiato al lettore tutte le altre interpretazioni: Fuchs, Isler, Arias, Rolley, Paribeni, Dontás, Harrison, Bol & Deubner, Holloway, Sismondo-Ridgway, Brinkmann & Koch-Brinkmann… Ma godiamo comunque di una certezza. Di natura oserei dire filosofica.
Non nacquero insieme. Tuttavia erano esposti insieme, come provano i “tenoni”; furono restaurati insieme, in imprecisati momenti antichi (e una seconda volta dopo due millenni); furono probabilmente saccheggiati insieme, per poi fare naufragio insieme, o forse per qualche secolo furono adorati insieme (prima come Castore e Polluce e poi come Cosma e Damiano) e infine occultati insieme in bassi fondali. Dopo chissà quanti secoli sott’acqua insieme, sono stati destinati a rimanere per sempre insieme in un museo a godere dell’umana ammirazione — che in fondo era il loro scopo fin dall’inizio.
Altro elemento significativo è che, per restare in tema epico, dopo un’odissea ancor più lunga di quella di Ulisse abbiano chiuso il cerchio stabilendosi a Rhégion, la patria del loro più accreditato creatore.
(Profugo lui, profughe anche le sue creazioni. È il Fato di Riace.)
È questa la singolare, incredibile e bellissima favola che accomuna i due capolavori sconosciuti. Quando si dice “un matrimonio riuscito”…!


FONTI BIBLIOGRAFICHE, STORICHE E ICONOGRAFICHE
Fonti letterarie storiche primarie:
Pausania il Periegeta, Guida della Grecia / Plinio il Vecchio, Naturalis Historia / Taziano il Siro, Discorso ai Greci / Eschilo, Sette contro Tebe – Coefore / Sofocle, Edipo Re – Antigone / Euripide, Le Fenicie / Publio Papinio Stazio, Tebaide
Fonti letterarie storiche aggiuntive:
Omero, Iliade – Odissea / Esiodo, Erga / Pindaro, Olimpiche – Nemee – Pitiche / Aristotele, Retorica / Plutarco, Vite Parallele – Sugli oracoli della Pizia – Quaestiones convivales / Marco Tullio Cicerone, In Verrem / Marco Terenzio Varrone, De lingua latina / Marco Vitruvio Pollione, De architectura / Tito Livio, Ab Urbe Condita / Marco Fabio Quintiliano, Institutio oratoria / Dione Crisostomo, Orazioni / Diogene Laerzio, Vite dei filosofi / Galeno, Sulle opinioni di Ippocrate e Platone / Eusebio di Cesarea, Chronicon / Giovanni Tzetzes, Chiliadi / Jacopo da Varagine, Legenda Aurea / Dante Alighieri, La Divina Commedia
Fonti moderne:
Vol. Due bronzi da Riace: rinvenimento, restauro, analisi ed ipotesi di interpretazione su Bollettino d’Arte del Ministero dei Beni culturali e ambientali, Roma 1984, contenente i seguenti autori e opere:
ARIAS Paolo Enrico, Lettura delle statue bronzee di Riace;
DONTÁS Geórgios, Considerazioni sui bronzi di Riace: proposte sui maestri e sulla provenienza;
FORMIGLI Edilberto, La tecnica di costruzione delle statue di Riace;
GIULIANO Antonio, I grandi bronzi di Riace, Fidia e la sua officina;
PARIBENI Enrico, I bronzi di Riace;
ROLLEY Claude, Delphes? Non!;
SABBIONE Claudio, La statua A – La statua B – Tabelle tecniche.
BONANNO ARAVANTINOS Margherita, Sarcofagi, in Archeologia Classica Vol. 59, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2008
BIEBER Margarete, Künstler-Lexikon, Vol. XXVII, Lipsia 1933
BIEBER Margarete, The Sculpture Of The Hellenistic Age, Columbia University Press, 1955
BOL Peter C., Antike Bronzetechnik: Kunst und Handwerk antiker Erzbildner, C.H. Beck, Monaco 1985
BRAGHÒ Giuseppe, Facce di bronzo. Personaggi e figuranti a Riace, L. Pellegrini Ed., Vibo Valentia 2007
BRINKMANN Vinzenz, KOCH-BRINKMANN Ulrike, Das Rätsel der Riace-Krieger. Erechtheus und Eumolpos, in Athen – Triumph der Bilder. Eine Ausstellung der Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt am Main 2016
BUSIGNANI Alberto, Gli eroi di Riace. Daimon e Techne, Sansoni, Firenze 1981
CAMPBELL David, Greek Lyric, Loeb Classical Library, Harvard 1983
CAPUTO M., PIERI L., Innalzamento eustatico del livello marino nel Mediterraneo, Venezia 1972
CASTRIZIO Daniele, I Bronzi di Riace. Ipotesi ricostruttiva, Iiriti Ed., Reggio Calabria 2000
CASTRIZIO Daniele, L’elmo quale insegna del potere, Falzea, Reggio Calabria 2007
CASTRIZIO Daniele, IARIA Cristina, Bronzi di Riace. L’enigma dei due guerrieri. Ediz. italiana e inglese, Città del Sole, Reggio Calabria 2016
DEUBNER Otfried, DE GRUYTER Walter, Die Statuen von Riace, in Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, CIII, 1988
DE FRANCISCIS Alfonso, Il Santuario di Marasà in Locri Epizefiri. Il Tempio arcaico, Napoli 1979
DI VITA Antonino, Due capolavori attici: gli oplitodromi-‘eroi’ di Riace, in Due bronzi da Riace, serie speciale n. 3/11 del Bollettino d’Arte del Ministero dei Beni culturali e ambientali, Roma 1984
DI VITA Antonino, I Bronzi di Riace, la Statua di Mozia, Pitagora. Un aggiornamento, in Lo stile severo in Grecia e in Occidente, Roma 1995
DONTÁS Geórgios, Some remarks on the bronze statues of Riace Marina, in Actes du XII Congrès International d’Archéologie Classique, III, 1988
ERCOLES M., FIORENTINI L., Giocasta tra Stesicoro ed Euripide, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 179, Bonn 2011
FAULKNER Neil, A Visitor’s Guide to the Ancient Olympics, Yale University Press, 2012
FOTI Giandomenico, Shoreline Evolutionary Trends Along Calabrian Coasts: Causes and Classification, Università Mediterranea di Reggio Calabria, 2022
FUCHS Werner, Zu den Großbronzen von Riace, in Boreas 4, Wiley Online Library, The Wiley Foundation, Hoboken (New Jersey, USA) 1981
FUCHS Werner, Thesen zu den Riace-Statuen, in Actes du XII Congrès International d’Archéologie Classique, III, 1988
HARARI Maurizio, A proposito dei bronzi di Riace. Pausania e gli eponimi mancanti, l’iconografia di Pandione e altre considerazioni, in Athenaeum n.s. LXVI 3-4, Pavia 1988
HARRISON Evelyn Byrd, Early Classical Sculpture: the Bold Style, in Greek Art, Archaic into Classical. A Symposium, University of Cincinnati, April 2-3 1982 (a cura di C.G. Boulter), Leiden 1985
HEURGON Jacques, La Magna Grecia e i santuari nel Lazio, in La Magna Grecia e Roma in età arcaica, Atti dell’VIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 6-11 ottobre 1968, II.2, Napoli 1969
ISLER Hans Peter, Die Bronzekrieger von Riace, Bern 1983
JACOBY Felix, Die Fragmente der Griechischen Historiker, Leuven 1958
JAMES Peter, Centuries of Darkness: A Challenge to the Conventional Chronology of Old World Archaeology, Jonathan Cape, London 1991
KRAUSKOPF Ingrid, I Sette contro Tebe nell’arte etrusca arcaica e classica, in Scienze dell’Antichità Vol. 10, Heidelberg 1997
LAMBOGLIA Nino, Relazione sulla campagna di ricerche archeologiche sottomarine svolta nelle acque di Riace dal 28 agosto al 4 settembre 1973, in Archivio Soprintendenza Archeologica per la Calabria, 1 — PALLARÈS Francisca, Relazione del prof. Nino Lamboglia sullo scavo archeologico sottomarino nelle acque di Riace dal 28 agosto al 4 settembre 1973. Giornale di scavo, in Rivista di Studi Liguri, Ventimiglia 1974
MORENO Paolo, I Bronzi di Riace, Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe, Milano 2002, seconda edizione Electa; Les Bronzes de Riace, Le Maître d’Olympie et les Sept à Thèbes, Gallimard, Paris 1999
MORETTI Luigi, Olympionikai. I vincitori negli antichi agoni olimpici, in Atti della Accademia nazionale dei Lincei. Memorie, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Roma, 1957
ODO PAVESE Carlo, Interpretazione dei Bronzi di Riace, in Studi Classici e orientali, XXXII, Università di Pisa, 1982
PARIBENI Enrico, Lo stile e la datazione, in Lombardi Satriani L.M., Paoletti M. (a cura di), Gli eroi venuti dal mare. Heroes from the Sea, Reggio Calabria-Roma 1986
POUILLOUX Jean, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, vol. 1, De Boccard, Parigi 1954
RAUBITSCHEK Antony Erich, The Greek historians: literature and history, Stanford University 1985
REBAUDO Ludovico, I Bronzi di Riace: archeologia e archeometria, in Castrizio D., Malacrino A. (a cura di), I Bronzi di Riace e la bronzistica del V Secolo a.C., Atti del Convegno Internazionale (Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale; Messina, Dipartimento di Civiltà antiche e Moderne, 25-26 ottobre 2018), Reggio Calabria-Roma 2020
ROLLEY Claude, La sculpture grecque. Des origines au milieu du Ve siècle, Editions A et J Picard, Paris 1994
ROMA Giuseppe, I bronzi di Riace: brevi considerazioni, in Ostraka. Rivista di antichità, Vol. 16, Edizioni Ets, 2007
ROSS HOLLOWAY Robert, Gli Eroi di Riace sono siciliani?, in Sicilia Archeologica, Voll. 66-68, 1988
SCHMIEDT Giulio, Il livello antico del Mar Tirreno. Testimonianze dei resti archeologici, Leo S. Olschki, Firenze 1972
SISMONDO RIDGWAY Brunilde, The Riace Bronzes: A Minority Viewpoint, in Due bronzi da Riace, serie speciale n. 3/11, Vol. 2, Roma 1984
STUCCHI Sandro, Nuove osservazioni sulle statue bronzee di Riace, in Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti XLIII, 1986, pp. 99–102; Le due statue di bronzo dal mare di Riace. Una revisione, in Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti XLI, 1986, pp. 111–135
WEINSTOCK Holger, Ein Torso in Brüssel und Riace B, in Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, LXIV, Bruxelles 1993, pp. 61-89
Altri media, articoli, autori, scrittori e giornalisti
JSTOR.org
ACADEMIA.edu
Lo Stile Severo in Grecia e in Occidente: aspetti e problemi a cura di Antonella Mandruzzato, «L’Erma» di Bretschneider, Roma 1995
Antichità di Villa Doria Pamphilj, a cura di R. Calza, Roma 1977
“I Bronzi di Riace in origine erano 5 ed erano biondi”, La Repubblica, 16/08/2020
“Bronzi di Riace, intervista al professore Daniele Castrizio”, classicult.it, 13/10/2020
BUCCOLIERI G., Buccolieri A., Donati P., Marabelli M., Castellano A., Portable EDXRF Investigation of the Patinas on the Riace Bronzes. Nuclear Instruments and Methods, in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2015, no. 343
CASTRIZIO Daniele, La korinthie kune nelle emissioni monetali e nella statuaria di età classica, in Quaderni Ticinesi di Numismatica e antichità classiche, 1998, vol. 27, pp. 83–104
CASTRIZIO Daniele, “Spot sui bronzi: un falso problema”, Strill.it, 13/06/2011
MANGLAVITI Luigi, Cerco il Figlio, Rainkids, Reggio Calabria 2011
SETTIS Salvatore, “Riace e i colori di Atene”, Il Sole 24 Ore, 31/05/2015
SETTIS Salvatore, “La fortuna dei Bronzi di Riace”, Il Sole 24 Ore, 10/01/2016
Scopri di più da L’internettuale
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli via e-mail.







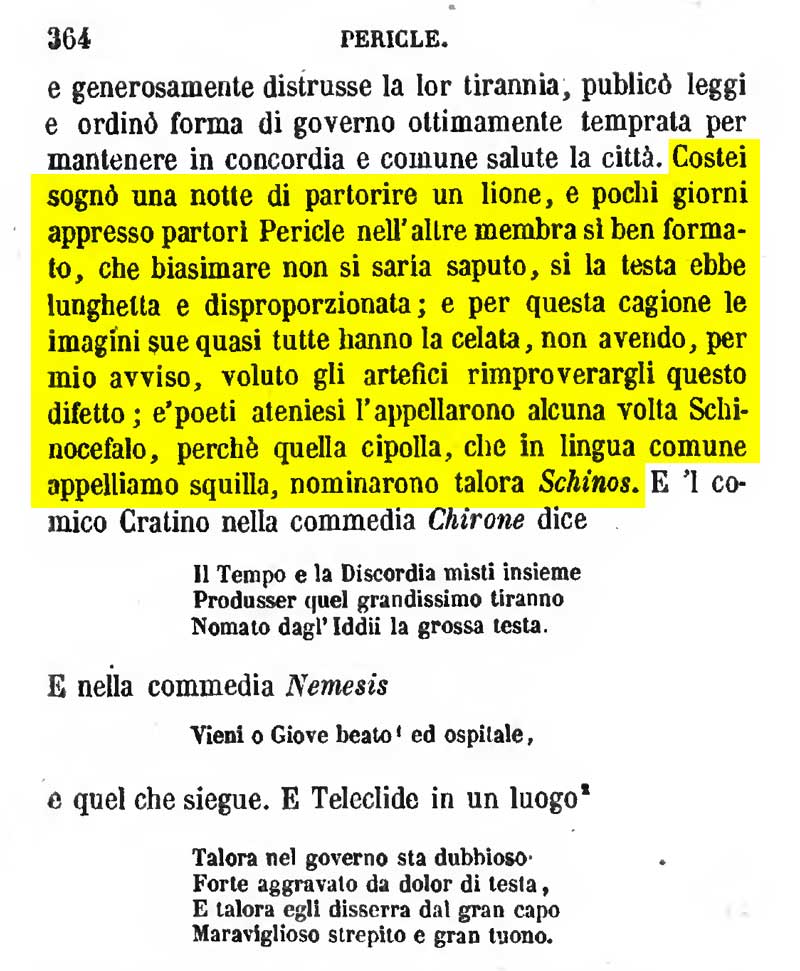

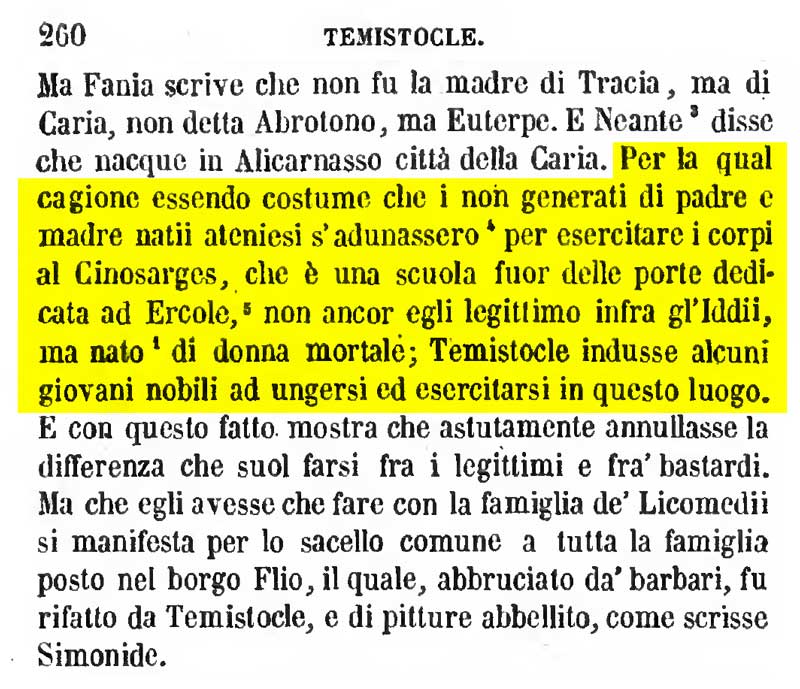










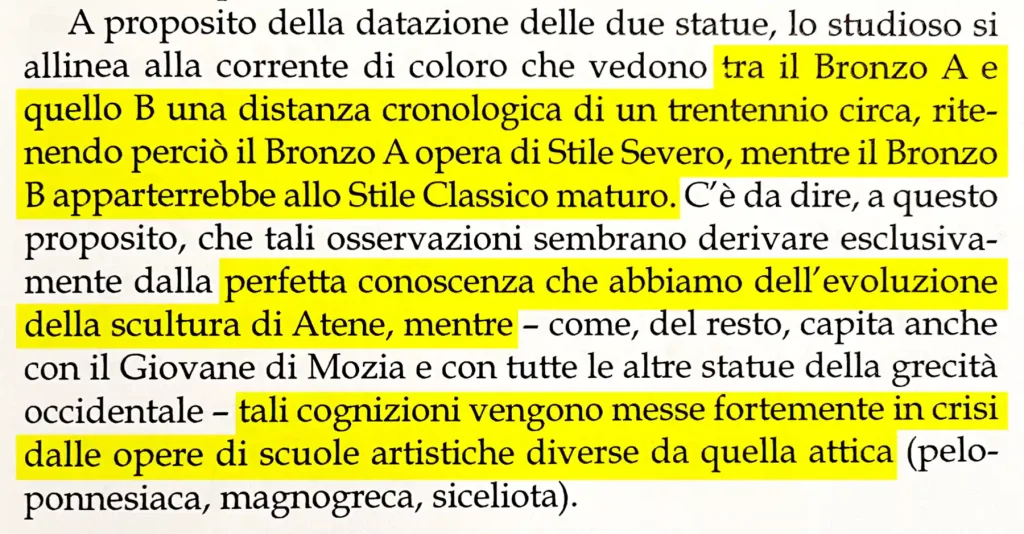

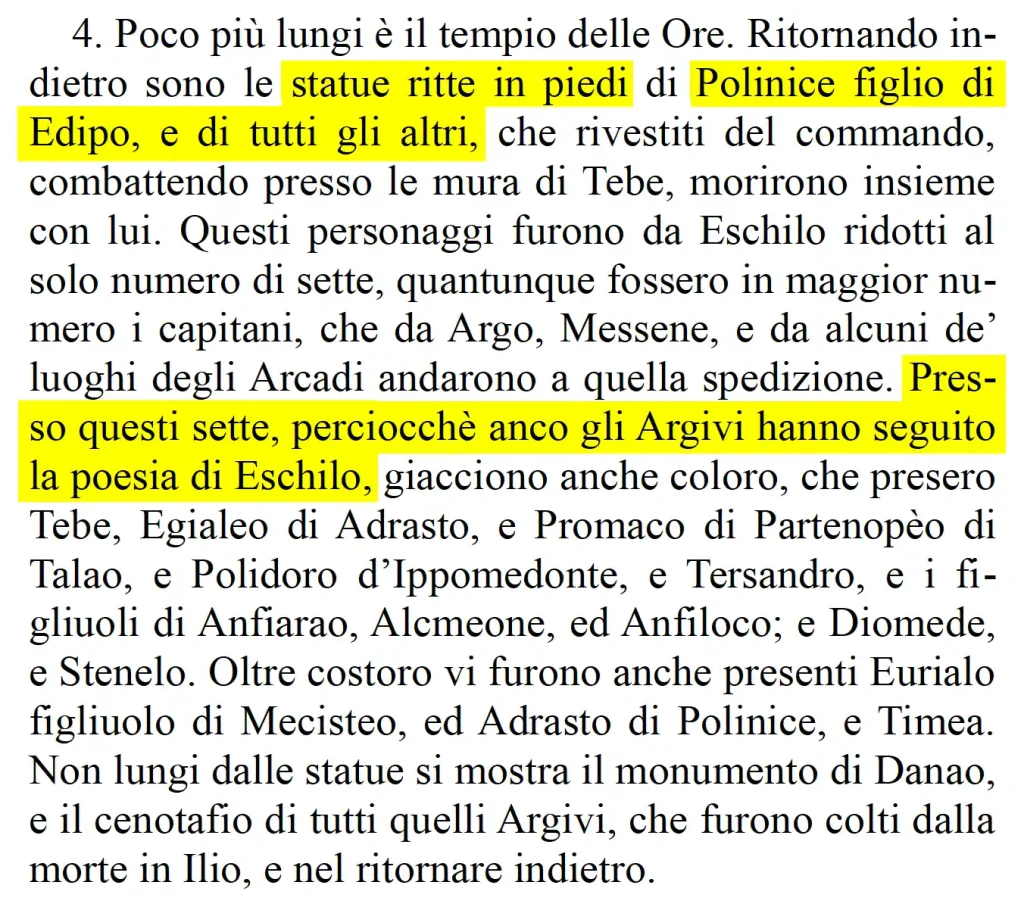
molto interessante, documentato, acuto e divertente. grazie !
Grazie a lei! 🙂
Eccellente ed esaustiva ricerca: unica! Congratulazioni!
Grazie mille! 💚