
Il prezzo del petrolio balzato a 150 dollari al barile ha costretto anche i media della destra più accanita a concedere un congruo spazio al populismo, dilungandosi in ogni trasmissione sulle ultime gesta di Big Oil, il petrolio superstar. Qualche conduttore parla amabilmente del nuovo, insidioso fenomeno del “capitalismo che sfrutta i disastri”. Un sistema che in genere va forte, specialmente coi NeoCon. Almeno finché non si inceppa. Ad esempio David Letterman, ridendo, dice: «Credo di sapere qual è la via più breve per far scendere i prezzi. Abbiamo investito ben 650 miliardi di dollari per liberare una nazione di 25 milioni di abitanti. Non sarebbe giusto chiedere in cambio il loro petrolio? Dovremmo veder venire intere carovane di autocisterne, tutte in coda come nel peggiore ingorgo dell’ora di punta davanti al fetentissimo Lincoln Tunnel, con tanto di nota di ringraziamento del governo iracheno. Perché non ce lo prendiamo, il loro petrolio, dato che abbiamo investito per liberare quel Paese? Ecco come lo risolverei io, il problema del caro-petrolio: non in dieci anni, ma in dieci giorni».
Ovviamente, all’atto pratico Letterman si troverebbe alle prese con qualche problema. Tanto per cominciare, il piano da lui descritto sarebbe la più colossale rapina della storia mondiale. E oltretutto Letterman ci è arrivato buon ultimo, dato che il saccheggio del petrolio iracheno è cosa fatta — o quanto meno ben avviata.
Il metodo più in voga per cambiare il mondo nell’interesse delle corporation multinazionali è lo sfruttamento sistematico della Paura™® e del disorientamento che accompagnano i momenti di shock e di crisi profonda. Oggi il pianeta è scosso da tutta una serie di traumi a catena: un periodo adatto per guardarsi attorno e vedere come applicare al meglio questa strategia.

Il capitalismo dei disastri è quanto mai attivo: dalle società di vigilanza anti-incendio private nella California del Nord, dove i boschi sono divorati dal fuoco, all’arrembaggio per l’acquisto di terreni nella Birmania colpita dai cicloni, alla legge per la casa attualmente in preparazione al Congresso degli Stati Uniti — una legge che non prevede granché in fatto di case a prezzi accessibili, ma in compenso accolla ai contribuenti i costi della crisi dei subprime, garantendo una certa copertura alle banche che hanno concesso i mutui a rischio: non a caso nei corridoi del Congresso si parla di quel disegno di legge come del “piano Crédit Suisse”, dal nome della banca che lo ha generosamente proposto.
Ma i succitati esempi di capitalismo sfrutta-disastri sono roba da dilettanti a confronto con quello che sta accadendo al ministero del Petrolio iracheno. Tutto è cominciato con l’annuncio di una serie di contratti “no-bid” (assegnati senza gara d’appalto) con ExxonMobil®, Chevron®, Shell®, Bp® e Total® (prossimi alla firma). Non è insolito che le multinazionali vengano remunerate per la loro… consulenza tecnica: l’anomalia sta nel fatto che questi contratti siano andati quasi invariabilmente a società di servizi del settore petrolifero e non alle major della carbon wealth, proprietarie e specializzate in prospezioni e produzione. Come ha sottolineato l’esperto londinese Greg Muttitt, questi contratti possono avere un senso solo in relazione alle voci secondo le quali le major del petrolio hanno insistito per un diritto di prelazione sui contratti futuri per la gestione dei campi petroliferi iracheni. In altri termini, qualunque compagnia sarà libera di partecipare alle gare d’appalto per quei futuri contratti, ma saranno queste ultime a vincerle.
Una settimana dopo l’annuncio del contratti “no-bid” si è potuto avere a livello mondiale un primo sentore di quello che sarà il prezzo reale da pagare. Dopo anni di pressioni esercitate nell’ombra, l’Iraq ha spalancato ufficialmente le porte, cedendo agli investitori stranieri sei dei suoi maggiori campi petroliferi, pari a circa metà delle sue riserve. Secondo quanto ha dichiarato il Ministero iracheno del Petrolio, i contratti di lungo periodo saranno firmati entro un anno. Anche se apparentemente l’Iraq National Oil Company continua a mantenere il controllo dei campi petroliferi, le compagnie straniere avranno nelle loro mani il 75% del valore del contratti. Al partner iracheno resterà solo il 25 per cento.
Una siffatta spartizione non ha precedenti negli Stati arabi e persiani, dove la conquista del controllo nazionale di maggioranza sul petrolio è emblematica della vittoria nella lotta anticoloniale. Sempre secondo Greg Muttitt, finora si era pensato che le multinazionali avrebbero avuto accesso all’Iraq per aprire nuovi campi petroliferi, e non per prendersi quelli già in produzione, che di conseguenza non hanno particolari necessità di supporto tecnologico. «Finora» dice Muttitt, «si era sempre parlato di assegnare questi campi petroliferi alla Iraq National Oil Company. Ma ora siamo in presenza di un rovesciamento totale della linea politica, dato che all’Inoc andrà solo il 25%, anziché il 100% come previsto».
Com’è possibile che si conduca una politica così sordidamente esosa nei confronti di un Paese già tanto duramente colpito? Purtroppo, e paradossalmente, l’Iraq viene trattato così proprio perché ha tanto sofferto, e vive tuttora in uno stato di crisi che non sembra avere vie d’uscita. Proprio per questo ha dovuto subire una transazione che minaccia di alienare al Paese la sua maggior fonte di reddito. Ecco qual è la logica: dopo anni di sanzioni che l’hanno svenata e privata dell’apporto di nuove tecnologie, l’industria petrolifera irachena ha bisogno di esperti stranieri; e dato il crescente degrado — in seguito all’invasione e alle incessanti violenze —, l’Iraq ha urgente necessità di produrre più petrolio, per l’appunto a motivo della guerra. Il Paese è distrutto, e il flusso miliardario dei contratti “no-bid” concessi alle compagnie occidentali non è servito a ricostruirlo. A questo punto intervengono i nuovi contratti, sempre stipulati direttamente e senza gare d’appalto: serviranno a reperire più denaro. Ma l’Iraq è diventato ormai un Paese così infido che, per investire, le major petrolifere hanno bisogno di “incentivi”. Ecco in che modo l’invasione dell’Iraq serve addirittura da argomento per il suo successivo saccheggio.
Molti degli architetti dell’invasione irachena non cercano neppure più di negare che il principale obiettivo dell’operazione fosse il petrolio. In un suo intervento trasmesso dall’emittente radiofonica nazionale To the Point, Fadjil Chalabi, che è stato uno dei principali consulenti dell’amministrazione Bush al momento dell’invasione, ha recentemente descritto la guerra come «una mossa strategica da parte degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito in vista di una presenza militare nel Golfo, al fine di assicurarsi in futuro le forniture petrolifere». Per Chalabi, già sottosegretario iracheno al Petrolio, che prima dell’invasione aveva incontrato gli esponenti delle major petrolifere, questo era “un obiettivo primario”.
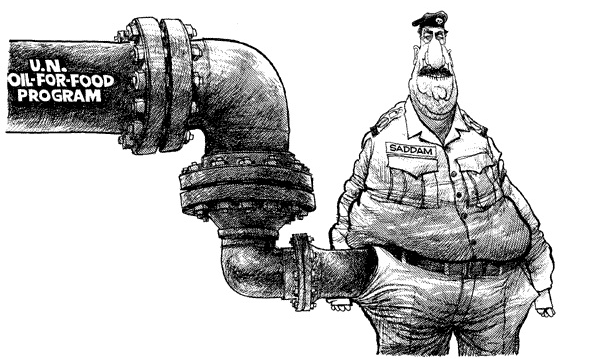
La Convenzione di Ginevra vieta di invadere un Paese per impossessarsi delle sue risorse naturali. Gli invasori hanno dunque commesso un atto illegale, e hanno quindi la responsabilità di farsi carico della gigantesca impresa di ricostruire le infrastrutture irachene — comprese ovviamente quelle petrolifere — e di assicurarne il finanziamento. Dovrebbero essere obbligati al pagamento delle riparazioni (si ricordi che il regime di Saddam Hussein ha versato al Kuwait 9 miliardi di dollari a titolo di riparazione per l’invasione del 1990). Mentre l’Iraq è costretto a vendere il 75% del suo patrimonio nazionale per pagare il conto dell’invasione e dell’occupazione illegale che ha dovuto subire…
E la rapina petrolifera non colpisce solo l’Iraq. L’amministrazione Bush sta attivamente cercando di sfruttare la conseguente crisi dei prezzi petroliferi per rispolverare il vecchio sogno di trivellare l’Area naturale protetta dell’Artico (Anpa). Oltre che, ovviamente, trivellare off shore. E trivellare la solidissima pietra scistosa (roccia distribuita su piani paralleli) del bacino del Green River. George W. Bush dichiara: «Il Congresso deve confrontarsi con questa dura realtà: o si accetta il penosissimo onere degli attuali prezzi dei carburanti, con la prospettiva di vederli aumentare ancora, oppure gli Stati Uniti dovranno produrre più petrolio». Eccolo qua, il presidente, nella sua funzione di capo estorsore, col bocchettone del gas puntato contro la testa del suo ostaggio, che nel caso di specie è l’intero Paese. Datemi l’Area naturale protetta dell’Artico, o passerete tutti quanti le vacanza nel cortile dietro casa vostra: è l’ultimo assalto alla diligenza del presidente cow-boy.
Ma in barba a tutto questo gran parlare di trivellazioni e alla proliferazione degli adesivi “Pay less” (paga di meno) sui parabrezza degli Americani e degli Europei, il petrolio dell’Artico inciderebbe comunque in misura irrilevante sui flussi petroliferi globali, cosa peraltro ben nota anche i suoi promotori. Secondo la loro tesi, l’effetto sul prezzo del petrolio si otterrebbe non per motivi economici concreti ma grazie ad una sorta di effetto psicologico sul mercato: le trivellazioni lancerebbero un “messaggio” ai paesi esportatori, i quali, a fronte dei nuovi flussi di greggio, sarebbero indotti ad abbassare i prezzi. A questo punto si impongono due commenti.
Primo: in questa era, anche in piena emergenza nazionale, Bush presenta come azione di governo il tentativo di spuntarla contro gli iperattivi esportatori di materie prime usando l’arma psicologica.
Secondo: il trucco è comunque destinato a fallire. A fronte dell’andamento del mercato petrolifero, la sola previsione plausibile è che i prezzi continueranno a salire, indipendentemente dall’effetto annuncio di nuove fonti.
In realtà un boom è già in atto, grazie allo sfruttamento delle sabbie petrolifere dell’Alberta, in Canada. Queste fonti hanno gli stessi pregi di quelle proposte da Bush: sono vicine e la loro sicurezza è a tutta prova, dato che l’accordo americano di libero scambio (Nafta) vieta tassativamente al Canada di tagliare le sue forniture agli Stati Uniti. Ora, e senza squilli di fanfare, il petrolio estratto da questo giacimento largamente inutilizzato sta già scorrendo sul mercato: dal 2005 al 2007 il Canada ha incrementato di almeno 100 milioni di barili il quantitativo di petrolio esportato negli Usa, passando al primo posto tra i suoi fornitori, davanti all’Arabia Saudita. Eppure, nonostante questo significativo aumento di un flusso certo e affidabile, il prezzo del petrolio non ha mai cessato di lievitare. L’insistenza sulle trivellazioni nell’Artico trova quindi la sua spiegazione non nella realtà dei fatti ma esclusivamente nella dottrina dello shock. La crisi del petrolio ha creato le condizioni per dare a bere una politica (assai redditizia) che altrimenti nessuno avrebbe preso in considerazione.
La crisi globale dei prezzi alimentari è intimamente connessa a quella petrolifera. Non soltanto il rincaro del greggio in quanto tale fa lievitare i costi delle derrate alimentari, ma ad aggravare la situazione è intervenuto anche il boom dei biocombustibili, la cui produzione sta cancellando la linea di demarcazione tra cibo e carburanti, e toglie spazio alle colture alimentari incoraggiando la speculazione rampante. In vari Paesi latinoamericani si tende ora a rivedere criticamente la recente politica di corsa ai biocombustibili, e a chiedere il riconoscimento del cibo come un diritto umano, e non una merce come le altre.
Ma il vicesegretario di Stato americano John Negroponte la pensa diversamente. Nello stesso discorso in cui promuove l’impegno degli Stati Uniti a contribuire agli aiuti alimentari d’emergenza, invita i Paesi destinatari ad «abbattere le restrizioni alle esportazioni e le tariffe», nonché ad «eliminare gli ostacoli all’uso di tecnologie innovative per la produzione vegetale e animale, ivi comprese le biotecnologie». Una rapina innegabilmente più sottile, anche se il messaggio è chiaro: i Paesi in condizioni di povertà farebbero meglio a spalancare i loro mercati agricoli ai prodotti americani e alle sementi geneticamente modificate, se non vogliono vedersi tagliare gli aiuti.
Gli Ogm vengono presentati come una panacea contro la crisi alimentare: è la tesi della Banca Mondiale (che fino a poco tempo fa era comandata, è utile ricordarlo, dall’ex-grilletto-neocon Alan Wolfowitz), ripresa anche dal presidente della Commissione europea («è ora di ingoiare il rospo») e sostenuta dal primo ministro britannico Gordon Brown. Ed è ovviamente quella delle società dell’agribusiness. «Oggi non si può sfamare il mondo senza gli organismi geneticamente modificati» ha detto recentemente al Financial Times il presidente della Nestlé®, Peter Brabeck. Il problema è però che, almeno per il momento, nulla prova che gli Ogm servano ad aumentare la resa delle colture. Anzi, spesso la riducono.

Anche se esistesse una semplice chiave per risolvere la crisi alimentare mondiale, saremmo davvero disposti ad affidarla alle varie Nestlé® e Monsanto®? Cosa ci costerebbe usarla? In questi ultimi mesi Monsanto®, Syngenta® e Basf® si dedicano freneticamente all’acquisto di brevetti per le cosiddette sementi a prova di clima, che dovrebbero generare piante in grado di crescere persino nei terreni bruciati dalla siccità o imbevuti di sale in seguito ad alluvioni. Si tratta, in altri termini, di piante modificate in maniera tale da essere in grado di sopravvivere al futuro caos climatico.
Sappiamo fin d’ora che la Monsanto® farà di tutto per tutelare la sua proprietà intellettuale: non esiterà a spiare i coltivatori e a citarli in giudizio se avranno osato mettere da parte le proprie sementi per l’anno dopo. Abbiamo già visto milioni di malati dell’Africa sub-sahariana lasciati senza cure in nome dei brevetti dei farmaci anti-Aids: perché aspettarsi comportamenti diversi nel caso delle sementi a prova di clima?
Nel frattempo — e mentre dovunque si fa un gran parlare di nuove, elettrizzanti scoperte in fatto di genetica e tecnologie di trivellazione — l’amministrazione Bush ha annunciato una moratoria di due anni per tutti i nuovi progetti legati all’energia solare sul territorio federale, in omaggio, a quanto pare, a sedicenti preoccupazioni energetiche. Siamo all’ultima frontiera del “capitalismo dei disastri”: i nostri leader decidono, guarda caso, di non investire proprio in quelle tecnologie che servirebbero realmente a evitare i futuri sconvolgimenti climatici. E scelgono invece di procedere mano nella mano con chi progetta i modi più innovativi per lucrare sui cataclismi.
Privatizzare il petrolio iracheno, assicurare il dominio globale degli Ogm sulle colture, eliminare le ultime barriere commerciali, sfruttare senza più ostacoli gli ultimi rifugi naturalistici… ancora poco tempo fa questi obiettivi si perseguivano attraverso accordi commerciali formalmente inappuntabili, presentati sotto lo pseudonimo benigno di “globalizzazione”. Oggi i promotori di quest’agenda ormai screditata si vedono costretti a cavalcare le crisi che si susseguono, spacciando i loro progetti per medicine salvavita, da somministrare ad un mondo malato.
Una sola cosa non è cambiata: la tecnica della Paura™®. Vedere capitolo intitolato “Osama bin Laden – AlQaeda” di una fiction che sorprendentemente è ancora di moda e che probabilmente dipanerà il nuovo atto in occasione delle prossime elezioni Usa.
Scopri di più da L’internettuale
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli via e-mail.

Be First to Comment